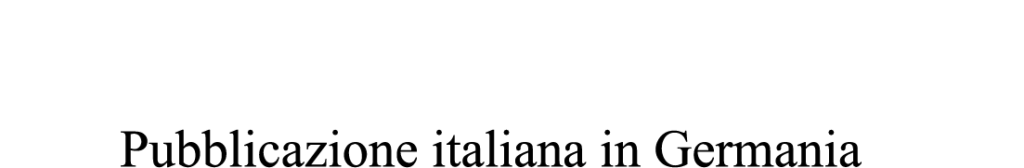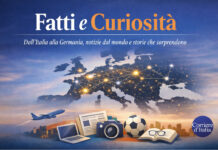Nel suo saggio ‚Social Media: Rivoluzione culturale o impoverimento sociale e cognitivo? (Armando Editore)‘, Sebastiano Tanasi affronta con lucidità e rigore critico le complesse dinamiche che caratterizzano l’impatto dei social media sulla società contemporanea. Lungi da una visione semplicistica, l’autore esplora sia le potenzialità rivoluzionarie di questi strumenti, capaci di connettere e informare, sia i rischi di impoverimento del pensiero critico e delle relazioni umane. Attraverso un’analisi multidisciplinare, Tanasi mette in luce come la pervasività dei social stia ridefinendo i concetti di comunicazione, identità e cultura, invitando a una riflessione profonda sul futuro della nostra società digitale.“
Per approfondire le tematiche centrali del suo libro, abbiamo avuto il piacere di intervistare l’autore, Sebastiano Tanasi. In questa conversazione, Tanasi ci guida attraverso le sfide e le opportunità poste dai social media, offrendo spunti di riflessione originali e provocatori. Dalle implicazioni cognitive dell’iperconnessione alla polarizzazione del dibattito pubblico, l’intervista esplora i nodi cruciali di un fenomeno che sta plasmando il nostro presente e il nostro futuro
Nel suo libro, lei introduce il concetto di „cretino contemporaneo“. Potrebbe approfondire come i social media abbiano contribuito a trasformare il „stolto“ dell’antichità in questa nuova figura? E quali sono, secondo lei, le caratteristiche distintive di questo „cretino“?
„L’esistenza del ‚cretino‘ è un fenomeno storico. Tuttavia, i social media hanno fornito a questi individui una visibilità senza precedenti, permettendo loro di esprimere opinioni infondate con sicurezza. Questa arroganza, derivante dalla mancanza di dubbi e dalla riluttanza all’autocritica, rende difficile contrastarli efficacemente, poiché richiederebbe di impegnarsi in un dibattito privo di logica e fondato su posizioni dogmatiche.
Mentre in passato i ‚cretini‘ erano spesso relegati a un ruolo marginale, le piattaforme social livellano le interazioni, equiparando il parere di un esperto a quello di chiunque altro. Questo, combinato con una cultura di tolleranza eccessiva verso ogni opinione, indipendentemente dalla sua validità, e una diminuzione del senso di responsabilità individuale, ha favorito la diffusione di opinioni superficiali e non informate.
Di conseguenza, si assiste a una prevalenza dell’opinionismo sulla cultura, sia umanistica che scientifica. Molti si sentono legittimati a esprimersi su qualsiasi argomento, anche in assenza di competenze specifiche. Questa ‚prevalenza del cretino‘, come lucidamente osservato da Umberto Eco, è diventata una caratteristica distintiva della nostra epoca.“
La diffusione di fake news è un problema crescente sui social media. Come possiamo contrastare questo fenomeno e promuovere una cultura della verifica delle fonti? Qual è il ruolo delle piattaforme social in questo contesto?
La diffusione di fake news è iniziata con la carta stampata, dove veniva applicato il principio delle 5 W (Who, Where, When, What, Why – Chi, Dove, Come, Quando e Perché). Era il controllo basilare che ogni giornale doveva eseguire, ma per scrivere sui giornali bisognava avere dei titoli e delle competenze. Oggi, grazie ai social media, siamo tutti creatori di contenuti. Il numero di follower di un singolo utente può superare il numero di copie vendute di quotidiani storici come La Repubblica. Spesso, questi utenti non hanno né capacità né interesse a garantire la veridicità dei contenuti. Più il contenuto è sensazionalistico, più seguito ottiene. Dovrebbe essere compito delle piattaforme come Facebook, YouTube e Twitter (oggi X) implementare strutture di fact-checking. Internet si è sviluppata in modo slegato da qualunque territorialità, rendendo difficile la regolamentazione. Le normative finora si sono concentrate principalmente su aspetti economici come la concorrenza e il pagamento delle tasse, mentre il lato etico è stato trascurato. Da quest’anno è in vigore il Digital Services Act, che impone una struttura di fact-checking alle piattaforme. Questa misura è ancora sperimentale e speriamo che possa migliorare la situazione, soprattutto considerando l’avvento dell’intelligenza artificiale che crea contenuti falsi. La nostra vita politica è influenzata da queste piattaforme, il che rende il problema delle fake news ancora più serio.
Lei parla di „democrazia social“. In che modo i social media hanno influenzato il modo in cui le persone partecipano al dibattito pubblico e come questa partecipazione si è evoluta nel tempo? Quali sono i rischi e le opportunità di questa nuova forma di democrazia?
In origine vi era una grande distanza tra la sfera privata dei leader politici e quella pubblica. I leader politici si proponevano per le loro capacità superiori alla media, mentre oggi passa un messaggio opposto: „Votami perché sono come te“. I leader condividono ogni aspetto della loro vita privata sui social media, creando un senso di totale eguaglianza con l’elettore. Questo ha portato alla creazione di una forma di digital storytelling sempre aperto, dove i messaggi vengono adattati ai sentimenti del momento. I social media manager analizzano le tendenze e modificano l’atteggiamento del leader in tempo reale, per mantenere la sintonia con l’elettorato. Tuttavia, ciò porta a politiche di corto respiro, dove manca il giudizio e l’analisi approfondita. I dibattiti politici sono diventati più polarizzati e meno confrontativi. Questo cambiamento ha modificato nettamente il modo di fare politica, con una polarizzazione estrema che nasce dalla relazione tra democrazia e social media.
I giovani sono i maggiori utilizzatori dei social media. Quali sono gli effetti a lungo termine dell’uso intensivo di queste piattaforme sullo sviluppo cognitivo e sociale dei giovani? E quali misure potrebbero essere adottate per mitigare i potenziali rischi?
Oggi i social media sono i nuovi luoghi di incontro per i giovani, che devono plasmare la propria identità e ruolo. Le nuove generazioni non hanno idea di com’era il mondo prima dei social. I social media sono centrali nelle loro vite, e questo mette in luce nuovi rischi. I giovani spesso si trovano isolati, con un’unica relazione virtuale che può portare a un senso di solitudine e malessere. Questo può causare depressione e uso di droghe. Dall’altra parte, c’è una tendenza a integrare i social media nella scuola, per condividere esperienze e creare un canale di comunicazione con gli insegnanti. Investire in una scuola moderna e competente può rendere la società meno permeabile al disagio e più forte. Come diceva Gesualdo Bufalino, ci vuole un esercito di maestre per aumentare la dose di civiltà e sconfiggere il male nella società.