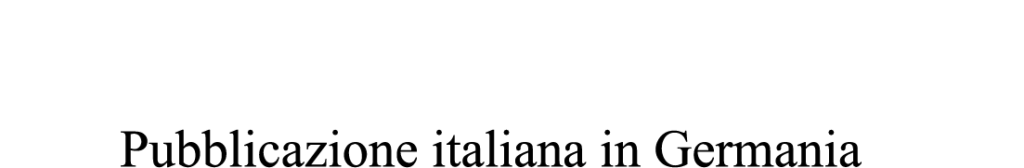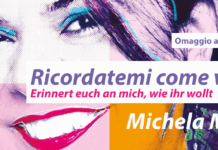Il 24 aprile 1918 è festa in casa di Thomas Mann, a Bogenhausen, quartiere residenziale di Monaco. Nasce la figlia nr. 4, Elisabeth, forse la prediletta fra i 6 figli (3 maschi e 3 femmine), eminente studiosa di diritti marittimo internazionale e soprattutto futura moglie di Giuseppe Antonio Borgese, eminente giornalista letterario e antifascista della prima ora. Mann era a 43 anni all’apice della letteratura tedesca: i Buddenbrook, Morte a Venezia, Tonio Kröger e Tristano erano romanzi che venivano letti ed apprezzati in Germania e nel mondo per il realismo introspettivo che li animava, senza contare decine di saggi pedagogici e culturali, che ormai apparivano da Londra a Parigi, da Mosca e New York. Era stata non di poco contrastata però la scelta di campo nel 1914 a favore della guerra contro l’Intesa occidentale. Fino al 1913, con La morte a Venezia, aveva diradato la questione politica e si era dedicato al problema dell’artista in una società borghese, dove la patologia decadentista e la condizione umana erano oggetto primario ed esclusivo, salvo qualche cenno sociale nei Buddenbrook, una saga familiare di borghesi arricchiti a Lubecca e poi caduti in miseria, come era avvenuto per la sua famiglia di imprenditori marittimi. Ma col saggio storico Federico e la grande coalizione del 1915, nonché con l’articolo Pensieri in guerra, pubblicato nel 1916, giustificò ed esaltò la militaristica azione prussiana durante la guerra dei 7 anni, quando Federico invase la Sassonia nel 1740, malgrado questa fosse neutrale nella guerra europea fra Francia, Inghilterra, Austria e Russia in contesa per la primazia coloniale in America ed in Asia, nonché per accedere nei Balcani e nel Mar Nero, dove la decadenza ottomana era appetita da Austria e Russia.
L’atto offensivo alla Sassonia come quello al Belgio nel 1914, era stato necessario per rompere l’accerchiamento della Prussia dall’Est russo, dal Sud Austriaco e dall’Ovest francese. Di più: nelle successive Considerazioni di un impolitico, Mann si scagliò contro la democrazie occidentali, ree di aver snaturato la Cultura europea in nome di una libertà e di una eguaglianza che avevano massificato l’uomo, lo avevano despiritualizzato e gli avevano preso l’anima per favorire il capitalismo finanziario e consumistico. La Germania era l’unica Nazione che poteva vincere la democrazia illusa dalla tutela dei diritti civili. Il Parlamento liberale altro non sarebbe stato che una classe dirigente di pochi ricchi a danno del popolo tedesco, refrattario sin dall’epoca romana ad essere un suddito dell’occidente capitalista. In fondo Mann riprendeva la vecchia polemica luterana contro la Chiesa di Roma, le cui mollezze e corruzioni, (per esempio le vendite delle indulgenze), si riflettevano nelle Costituzioni liberali franco/inglesi. Esse avevano inquinato la natura umana e l’identità nordica. Wagner, Nietzsche e Schopenhauer erano i veri padri dell’Europa con una Germania sottomessa, mentre Francia ed Inghilterra erano i mostri dell’Io scientifico e tecnico depredatori dello Spirito.
Si capisce che tale modello – detto metapolitico perché fuori dalla Storia – sollevasse la reazione ideologica delle forze progressiste e cattoliche, peraltro schierate dalle parte dell’Intesa. Malgrado la Germania e le sorelle Austria e Turca fossero alla fine della guerra – complice la caduta degli approvvigionamenti interni, l’epidemia di spagnola e l’arrivo degli Stati Uniti a favore delle Potenze occidentali – il grado di speranza nazionalista di Mann (ma anche di Jünger, Hoffmannstahl e Kantorowicz, senza contare Weber e gli Junker prussiani) svanì a Compiègne nel vagone ferroviario dove nel novembre del 1918 fu firmato l’armistizio. Brema, Amburgo, Kiel e Monaco insorsero chiedendo la Repubblica; Guglielmo di Prussia fuggì in Olanda, la pace era fatta, ma sulla carta. I filosovietici tedeschi – gli Spartachisti – insorsero a dicembre del 1918 e pretesero di affidare tutto il potere ai Consigli operai e contadini. Una rivoluzione tedesca modello russo era scoppiata. La borghesia conservatrice, cattolica e socialdemocratica, si riunì invece a Weimar a scrivere una Costituzione democratica. Fra il 1919 ed il 1922 si tremò e piansero tanti morti per le strade.
La guerra civile segnò il paese: i socialdemocratici si accorderanno con l’esercito e la rivoluzione finirà in un bagno di sangue come era avvenuto nel 1849 a Francoforte ed a Dresda. Fame, inflazione, epidemie, attentati fra le opposte fazioni proliferarono. A Versailles, la pace punì la Germania, perché le Potenze vincitrici obbligarono restituzioni e riparazioni che misero sul lastrico l’economia già disastrata. La confusione politica e l’ordine pubblico diventarono il tema del giorno. Chi legge i drammi ed i romanzi dell’epoca, da Wassermann a Brecht, da Spengler a Benn, da von Keyserling a Bloch, da Hesse a Toller, non può che rinvenire un forte senso di spaesamento e di paura che attraversava le classi medie e che piuttosto speravano più che nella
Repubblica, nella conquista del potere di una dittatura illuminata meglio se militare. Thomas Mann, invece, si chiuse nel privato. Dopo il tuffo nella politica, nell’esistere quotidiano, meditava un ritorno nell’essere interiore. E trova nel cane (parliamo di Cane e padrone, un racconto lungo del 1918) un suo simile. Come se fosse un racconto realista, al pari di quelli che scrisse in gioventù, Mann compiva una singolare piroetta rispetto a Morte a Venezia del 1911, pur mantenendo uno stile ed un linguaggio acquisito formalmente limpido e suadente. Emergono così i pensieri più remoti del cane stesso, quasi un suo doppio. Era la via di fuga di un intellettuale incompreso ormai dai vecchi realisti e non ancora apprezzato in area espressionista, anche perché il doppio registro descrittivo dei Buddenbrook del 1901, non era stato maturato nel contesto naturalista dell’epoca.
Un po‘ quello che avvenne per Pirandello col suo Fu Mattia Pascal del 1904. In ambedue casi si voleva realizzare un mutamento di prospettiva verso il proprio sé, un essere comune presente fra lui ed il cane stesso, coll’effetto di ritrovare nell’animale quella bontà che vide scomparire nell’animo umano dopo la terrificante Grande Guerra. Nacque così un lungo racconto, dove si incontra una piacevole dialettica fra cane e padrone, uniti nell’amore per la natura, con risvolti umoristici, non lontani dall’amato Pirandello che ormai legge quotidianamente specialmente nelle novelle che circolano a Monaco e che discute nel salotto letterario di casa, aperto ad intellettuali cristiani – per esempio Hermann von Keyserling – e liberaldemocratici, come l’amico Walther Rathenau, il potente ministro dell’economia che lo erudisce sulle future riforme costituzionali e sociali.
Perfino il pacifismo, messo a zimbello nelle Considerazioni, fu tema di dibattito con Hesse, il cui parallelo carteggio durerà a lungo. In altri termini, Cane e padrone gli servì come strumento di preparazione del romanzo di ben diversa caratura, La montagna incantata, che dal 1913, sia pure a sbalzi, andava limando e perfezionando, che uscirà finalmente nel 1924). Attraverso le sue passeggiate nell’area riservata della villa – a pochi passi però dal centro città – Mann provava a ritrovare una grazia espositiva che non abbandonerà più, ben diversa da un racconto realista proprio con un altro cane, Esaù, ed un altro padrone, Tobias Mindernickel, protagonista del racconto breve di tale titolo del 1897. Comune ai due scritti era il ricordo del mondo agricolo antico, dove forza e bellezza della natura e dell’uomo classico trovavano valori umani che sembravano perduti.
Si pensi al cane Argo dell’Odissea ed al messaggio di San Francesco, che con la sua sottile ironia, raffreddava le tensioni sociali dell’epoca medievale. Solo che nel precedente racconto, Tobias era veramente un padrone dispotico ed Esaù una povera vittima delle angherie dell’altro, tanto che il povero animale finirà bastonato e perfino ucciso da quel padrone solo perché aveva osato disobbedirgli ed era addirittura fuggito dai ceppi in cui era stato legato. Vero è che quel padrone lo aveva raccolto perché unico essere vivente che lo aveva rispettato, rispetto ai vicini di casa del padrone che invece avevano maltrattato e dunque il servo non era che una proiezione del padrone. Ma ora Mann, penetrato nel suo sé interiore, cambia prospettiva: dice agli amici ed ai figli che una passeggiata senza Baushan era come mangiare un cibo senza sale. Dunque, familiarità, complicità ed amicizia, un rapporto che Mann presenta in nome di quella Kultur naturale degli esseri viventi tutti figli di Dio, una rilettura nuova ed evangelica rispetto all’identitarismo nazionalista e militarista che aveva sbandierato nelle Considerazioni.
E quando il cane morirà qualche anno dopo, Mann riesumerà una vecchia poesia di Platen, come iscrizione mortuaria: è veramente baciato da un felice destino chi già in vita è lodato da un canto immortale/e la sua morte non sarà così orrenda...pensiero che guardava al passato di una decadenza familiare tremenda e ad un futuro di morte civile quale sarà l’esilio in America. Ma se guardiamo al racconto in esame, Mann lo definì un idillio gioioso pur nella logica della sua ironia degli opposti. La stupenda traduzione di Francesco Saba Sardi – ed. Fratelli Fabbri, 1968 – rivela come la contrapposizione fra Kultur e Zivilisation ormai è sfumata in un intimismo ambientale che finalmente rinnega quelle idee che avevano nel 1918 isolato l’autore e costretto a ritirarsi a meditare. Mentre il 1920-1921, passeranno alla storia della Germania come quelli più bui della Repubblica di Weimar. Anzi, il 13.3.1920 fu il giorno del tentativo di colpo di Stato fomentato dalla destra militarista del generale Kapp, fallito per la pronta mobilitazione popolare e dalla proclamazione di uno sciopero nazionale (eventi simili avvenivano in Italia a seguito delle violenze fasciste, con effetti diametralmente opposti perché rafforzarono l’ascesa di quel movimento). Ma il 19 marzo scoppiò una rivolta di minatori nella Ruhr diretta alla occupazione delle fabbriche e seguì
una potente repressione da parte del Governo di Weimar, peraltro aggravata dalla successiva invasione della Francia e del relativo bacino industriale e perfino della città di Francoforte. Squilli di guerra civile che si propagavano dopo un plebiscito favorevole ai Polacchi di alcune zone dell’alta Slesia appartenenti alla Germania, seguito dall’occupazione militare (4.5.1921). Fatti che lasciavano l’amaro in bocca di Mann, che nei suoi Diari ancora criticava gli alleati democratici perché non accettavano rapidamente una rateazione del risarcimento dei danni di guerra e perché insistevano nella richiesta al Governo di Weimar per un forte disimpegno per il disarmo. Le polemiche di Jünger sulla coltellata alle spalle erano poi rivolte alla borghesia che non reagì appieno all’armistizio di Compiègne mentre c’era ancora un esercito presunto intatto e con i continui rischi di invasione ed occupazione di aree della Patria. Obiezioni che non convinsero però Mann, che rinunziò ad aderire ufficialmente al movimento estremista intellettuale della Rivoluzione conservatrice di Arthur Moeller van den Bruck e Carl Schimtt. La tempesta del dubbio nazionalista lo investirà fino al 15 ottobre del 1922, dove in un importante discorso a Berlino (Sulla repubblica tedesca) si dichiarerà finalmente a favore della Democrazia e della Repubblica. Ma questa è un’altra storia.