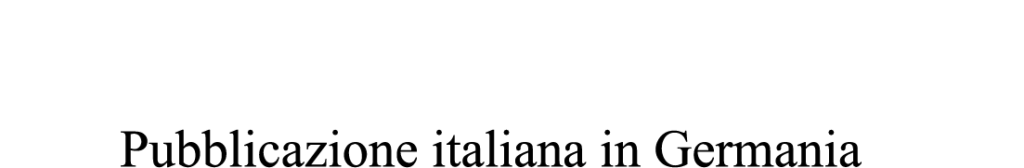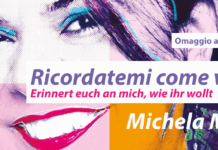Nel XIII secolo il conflitto tra i poteri universali del papato e dell’Impero raggiunse il suo apogeo. Due miniature del rotolo di pergamena custodito nel Museo Diocesano di Salerno ne raccontano la storia.
La parola pontefice deriva dal latino pontifex da pons «ponte» e facere «fare». In origine pontifex designava colui che curava la costruzione del ponte sul Tevere, principale via di comunicazione tra la Roma imperiale e il luogo in cui fu sepolto San Pietro e dove, per volere dell’Imperatore Costantino, nel IV secolo sorse la prima basilica di San Pietro.
La scomparsa di Papa Francesco, pontefice che ha dedicato la sua vita a costruire ponti tra i potenti della terra affinché potessero trovare soluzione le grandi questioni che attanagliano l’umanità, in primis la pace, consente una riflessione sulla relazione tra i detentori del potere spirituale e del potere temporale durante la prima metà del XIII secolo, in particolare durante le tre decadi in cui sacro romano imperatore fu Federico II Hohenstaufen.
Poche persone sanno cosa sia un Exultet. Non era così nel medioevo quando, la notte del sabato santo, se ne faceva uso per accompagnare la veglia pasquale dei fedeli. La veglia era fervida attesa della resurrezione, della celebrazione della luce, della sua vittoria sulle tenebre. Exultet è la prima parola del canto liturgico che annunciava la Pasqua: Exultet iam angelica turba coelorum, “esulti ormai la schiera angelica dei cieli”. Fisicamente gli Exultet erano rotoli di pergamena che venivano srotolati dal diacono dall’alto dell’ambone. I fedeli, in gran parte analfabeti, potevano vederne le immagini miniate e partecipare al rito cantato.
Secondo Guglielmo Cavallo, tra i massimi studiosi italiani di paleografia e storia della scrittura, i canti “erano di incomparabile bellezza e rivestivano un significato liturgico profondo che attraverso la benedizione e l’offerta del cero pasquale diventava atto di lode a Cristo risorto”. Furono un fenomeno esclusivo dell’Italia meridionale. Sorsero nei secoli dal X al XIII e ad oggi ne sono sopravvissuti 28. La maggior parte vide la luce nel monastero benedettino di Montecassino, a quel tempo centro culturale di grande importanza. Tre sono custoditi nell’Archivio capitolare di Troia, altri tre nel Museo diocesano di Bari.
Autorità temporali e autorità spirituali
In questo articolo vogliamo parlare di quello, particolarmente bello ed emblematico, custodito nel Museo diocesano di Salerno. L’ultima delle sue miniature mostra un sovrano troneggiante, in mezzo a dignitari di dimensioni più piccole. La penultima mostra un vescovo e un papa assiso, in mezzo a rappresentanti del clero. Le due miniature sono chiamate “Le autorità temporali e le autorità spirituali” e rappresentano il punto di arrivo di un percorso narrativo che si sviluppa lungo 18 immagini successive. C’è consenso unanime che il sovrano sia Federico II. Ma chi è il papa?

La questione di chi sia il papa è di grande importanza perché legata alla datazione della pergamena. Tralasciamola per un attimo occupandoci di un altra questione, non meno importante: in che luogo è rappresentato l’imperatore? Sappiamo che Federico II scelse Foggia come Regalis Sedes Imperialis e ne fece la sua residenza preferita nel Regno di Sicilia. La maggior parte delle immagini della pergamena salernitana disponibili in rete non mostrano con sufficiente chiarezza i dettagli. Siamo stati a Salerno e abbiamo visto con i nostri occhi i riquadri. Osservando attentamente le colonne ai lati di Federico abbiamo notato una chiara somiglianza con quelle della cripta della Cattedrale di Foggia. Somiglianza dovuta, a nostro parere, al materiale col quale sono state realizzate. Si tratta della la breccia rosata corallina che durante il medioevo fu estratta nel promontorio del Gargano e per questo chiamata anche mandorlato garganico.
La breccia rosata garganica fu utilizzata da Federico II in numerose altre località: nel portale d’ingresso della cattedrale di Termoli (città che in epoca sveva era compresa nel giustizierato di Capitanata); nel Palatium di Lucera; a Torre Alemanna vicino a Cerignola; in altre sedi minori. Ancor più marcatamente fu utilizzata nella realizzazione dei principali elementi plastici decorativi di Castel del Monte (portale d’ingresso, finestre, archivolti, colonne, capitelli, etc.). Realizzare tali elementi in breccia corallina poneva enfasi sulla bellezza dell’opera finale attuando un preciso disegno politico-ideologico del sovrano che si servì dell’architettura come espressione della propria magnificenza e autorità imperiale, nonché quale strumento di potere per la creazione di consenso. Non a caso nel 1240 l’imperatore ordinò a Riccardo di Montefuscolo, giustiziere di Capitanata (dove si trovava e si trova il promontorio del Gargano), di accelerare il completamento dello splendido maniero, oggi patrimonio Unesco dell’umanità.
Ritorniamo alla penultima miniatura e alla questione di chi sia il papa rappresentato. Nel periodo imperiale (1220 – 1250) i papi coevi di Federico II furono Onorio III, fino al marzo 1227; Gregorio IX, da marzo 1227 ad agosto 1241; Innocenzo IV, da giugno 1243 a dicembre 1254. Federico fu scomunicato da papa Gregorio IX il 29 settembre 1227 e il 20 marzo del 1239; il 17 luglio 1245 da papa Innocenzo IV. Le scomuniche papali crearono problemi al sovrano soprattutto per le conseguenze che ebbero sui sudditi. La prima scomunica ebbe luogo a seguito della mancata partenza per la crociata, causata da un’epidemia, ma per Gregorio si trattò di una scusa.
La crociata degli scomunicati
Federico partì un anno dopo, nel giugno 1228, e conquistò Gerusalemme (più di una conquista si trattò della restituzione alla cristianità del Santo Sepolcro). Ottenne questo risultato da scomunicato, e senza spargimento di sangue, grazie alle sue capacità diplomatiche e alla trattativa con il Sultano d’Egitto al Malik al Kamil. Durante la sua assenza molte città del regno si ribellarono, Foggia compresa. Al suo ritorno (giugno 1229) Federico dovette ristabilire l’ordine sottomettendo le città ribelli. Minacciò persino di invadere il Patrimonium Sancti Petri (lo Stato della Chiesa) ma poi grazie alla diplomazia ci rinunciò. Il 23 luglio 1230 con la pace di San Germano la scomunica gli fu revocata. San Germano è il nome storico di Cassino, città situata ai piedi della montagna di Montecassino. La pace durò dieci anni, fino alla scomunica del 1239 (ma questa volta a causarla fu il conflitto con i Comuni della Lega) ed è in quegli anni che Federico ordinò la realizzazione della cripta. Secondo lo studioso foggiano Giuseppe de Troia, il sovrano volle costruire la cripta a immagine e somiglianza del Cenacolo di Gerusalemme.
L’Exultet di Salerno ha la particolare caratteristica di non avere testi (eccezion fatta per il prologo, redatto in scrittura gotica). Si riteneva che fosse costituito solo da immagini, ma recentemente l’attento studio della riproduzione fotografica effettuata all’inizio del secolo scorso ha rivelato che il rotolo è stato privato di alcune parti, probabilmente quelle relative al testo, eliminate quando fu tagliato in riquadri.
Per stabilire chi è il papa (e magari anche chi è il vescovo che gli sta accanto e cosa gli porge) bisognerebbe sapere quando e perché è stata realizzata la pergamena. Gran parte della letteratura scientifica afferma che il rotolo salernitano è stato concepito nei primi anni del terzo decennio del XIII secolo. Dunque quando Onorio III era papa. Chi scrive ritiene invece che sia il risultato della pace di San Germano con Gregorio IX. Con la pace l’autorità temporale e l’autorità spirituale tornarono ad essere in armonia e tutta la parte peninsulare del Regno ne beneficiò. L’Exultet di Salerno doveva testimoniare la riconciliazione tra i due poteri universali.
Rientrato a Foggia Federico diede impulso ai suoi piani di governo, promulgò la costituzione, coniò l’Augustale, moneta considerata la più bella moneta del Medioevo. L’Augustale doveva contribuire a creare sviluppo economico nel Regno, ma anche riconquistare la fedeltà dei sudditi che potevano vedere l’immagine del Sovrano.
Probabilmente non fu Federico a commissionare la pergamena di Salerno, ma iniziativa della comunità felice della ritrovata armonia tra imperatore e papa.