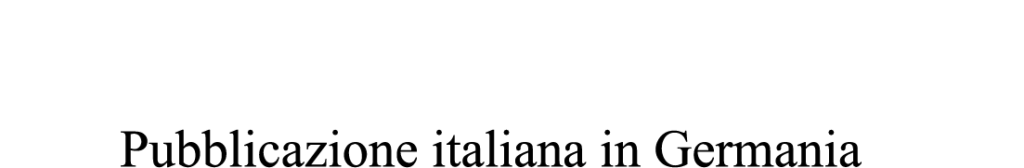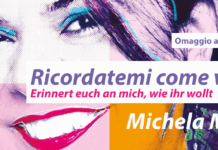Focus: 70 anni dagli accordi bilaterali tra Italia e Germania
L’emigrazione siciliana in Germania è la più numerosa rispetto alle altre regioni d’Italia e in questo anno in cui ricorrono i 70 anni dagli accordi bilaterali, proponiamo un approfondimento con testimonianze realizzato da Grazia Messina, docente e direttrice della ricerca scientifica per il Museo delle migrazioni di Giarre. Il lavoro di Grazia Messina è apparso sulla rivista scientifica Studi Storici Siciliani (www.studistoricisiciliani.it).
Lo proponiamo sul Corriere d’Italia online per gentile concessione dell’autrice, preceduto da una sua introduzione. Le note si trovano in fondo all’articolo. (n.d.r. PC)
„Mi ha sempre colpito la copiosa emigrazione dalla Sicilia in Germania, sostanzialmente ininterrotta dagli anni Cinquanta ad oggi. Nelle case di molti siciliani partire per la Germania è stata esperienza ricorrente durante la fase dei contratti stagionali, interi paesi si sono svuotati, per tornare a rianimarsi durante le ferie o il periodo estivo. C’erano bambini affidati ai nonni che aspettavano con ansia il ritorno dei genitori, mogli che attendevano i mariti, genitori che compravano le case per i figli sperando in un loro rientro. La storia della Sicilia si scriveva parlando della lontana Germania.

Riflettendo sulla ricorrenza del 70° anniversario degli accordi bilaterali tra Italia e Germania mi rendo conto che in quelle reiterate partenze la motivazione delle necessità si associava sempre alle opportunità che si prospettavano. La Germania offriva lavoro, garanzie contrattuali, un possibile futuro libero da rinunce, umiliazioni, catene clientelari che, in alcuni casi, erano anche mafiose. Questo spiega in parte perché tanti hanno poi deciso di fermarsi e di crescere con le loro famiglie lontano dalla terra d’origine, come le diverse voci che ho raccolto in questo mio studio in vario modo testimoniano.
Oggi i giovani, e sono tanti, ripartono attratti dagli sbocchi professionali che il paese tedesco propone con più ampia scelta e gratificazione. Studiano, si specializzano, trovano impiego, costruiscono famiglie. Anche mio figlio è stato per qualche anno “tedesco”, visto che ad Heidelberg ha conseguito il dottorato in fisica teorica. La sua esperienza, e la nostra come famiglia, mi hanno certamente spinto ad approfondire i vecchi come i nuovi cammini verso la Germania per capire meglio processi, dinamiche sociali, relazioni umane che continuano a segnare una storia di legami sempre più fitti e intrecciati tra i due Paesi. (Grazia Messina, direttrice della ricerca scientifica per il Museo etneo delle migrazioni di Giarre).„
Auf wiedersehen Sizilien! Settanta anni di emigrazione dalla Sicilia in Germania
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania nel desiderio di approfondire e di stringere sempre più nell’interesse reciproco le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarietà europea, nonché di consolidare i legami d’amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera ed un pieno sfruttamento delle possibilità di produzione, nella convinzione che questi sforzi servono l’interesse comune dei loro popoli e promuovono il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo sul reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania[1].
Si apriva con questi auspici l’ultimo accordo bilaterale del dopoguerra per orientare l’emigrazione dall’Italia[2], firmato a Roma il 20 dicembre 1955 con la Germania Federale[3].
Era l’inizio di un cammino che prosegue da settant’anni anche per la Sicilia, se si considera che i trasferimenti anagrafici dall’Isola nel Paese tedesco guidano ancora la lunga lista degli espatri. Una compagnia di autobus con sede a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, collega ogni giovedì il comune di Canicattì (Agrigento) alla città di Pforzheim (Germania), con fermate intermedie fino a Messina. Una linea diretta al costo di circa 150 euro a tratta, che viene incontro anche a chi si mette in marcia dal cuore dell’Isola, con pesanti bagagli da portare nella terra d’adozione. E sono autobus sempre pieni, bisogna prenotarsi per tempo.
Nonostante la crisi oggi non risparmi neppure la Germania, il Paese d’oltralpe attira molti siciliani per gli studi, il lavoro, il futuro delle famiglie. Con numeri che, seppure con lenti incrementi, fanno salire l’asticella, come si evince dalla tabella relativa al periodo 2006-2024: nell’ultimo anno la rotta tedesca ha catturato il 30,4 per cento del movimento regionale complessivo, con 251.550 registrazioni ufficiali nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) [4].

Tabella 1. Dalla Sicilia in Germania (2006-2024)
L’emigrazione “assistita” e i nuovi accordi
Il terzo ciclo di emigrazione del Novecento prende forma dopo il secondo conflitto mondiale. Si inaugurava in quegli anni l’ultimo cammino migratorio del secolo, stavolta attraverso precise intese intergovernative: si trattava di una novità rispetto al passato, che metteva sul piatto della bilancia politica ed economica numeri, costi e benefici degli spostamenti umani dalle aree meno fortunate dell’Italia. Non si partiva più verso incerta fortuna e in forma spontanea, come era accaduto soprattutto nella “grande emigrazione”, quanto piuttosto per rispondere a specifiche offerte di lavoro, suggerite e incoraggiate dai governi con accordi bilaterali. Per tale motivo anche il suo sviluppo, per molto tempo e soprattutto verso alcune destinazioni, avrà andamento stagionale e intermittente, con pause e conseguenti rientri in Italia durante periodi di crisi o di saturazione dei mercati.
L’Italia postbellica mise subito tra le priorità quella di risanare la sua economia stremata dal conflitto, puntando a ridurre la forbice tra sviluppo demografico e scarsità di capitali attraverso uno sbocco per l’esubero di manodopera che si era venuto a creare anche durante gli anni dell’autarchia fascista e della limitazione delle partenze dall’Italia[5]. I primi governi repubblicani videro nella ripresa dell’emigrazione un possibile sollievo per l’economia nazionale. Presero a confidare negli espatri per fronteggiare l’aumento della disoccupazione, e nell’arrivo di nuove rimesse per rimettere in sesto la bilancia dei pagamenti. Si pensava inoltre che dalle nuove partenze, incanalate da garanzie di lavoro, potesse provenire un grado di benessere tale da alleviare potenziali conflittualità sociali e di conseguenza consolidare il consenso politico alla nuova classe dirigente[6]. Era inoltre in gioco «una nuova politica estera, riallacciando relazioni e rapporti fondamentali nel contesto della ricostruzione post-bellica»[7].
In questa direzione verranno siglati gli accordi bilaterali sin dal 1946, con i quali si prospettò una «inedita estensione della sfera d’intervento dello Stato nazionale»[8], tanto da far parlare di “emigrazione assistita”, se con tale termine intendiamo la pianificazione, con relativa negoziazione internazionale, dei flussi di uscita. L’europeismo, che definirà intese sui movimenti delle persone e sulla ripresa postbellica nei trattati di Roma del 1957 e nella nascita del MEC, vedrà l’Italia tra i maggiori sostenitori anche per questo motivo: il problema occupazionale italiano avrebbe potuto trovare una risposta europea superando i confini nazionali[9]. La risposta dalla Sicilia non si fece attendere e raggiunse presto cifre significative. Alle opportunità attrattive che i nuovi contratti europei sembravano prospettare, si associavano delusioni e incertezze d’agire che ricordavano alcune spinte espulsive della “grande emigrazione”:
[..] anche nelle partenze degli anni 1950 c’è un elemento che ricorda quelle di fine Ottocento. Se allora aveva giocato il fallimento del movimento dei Fasci, nella definitività della scelta migratoria conta la sensazione di una nuova sconfitta politica e il ruolo dell’illegalità mafiosa come garante degli equilibri di potere. Si parte dunque perché non si può influire sullo sviluppo democratico dell’isola e perché ci si vuole allontanare dalla Mafia […][10]
La ricostruzione della provenienza regionale degli emigrati in Europa consegna un efficace quadro geografico delle partenze dalle varie aree italiane. Il dato che emerge vede in testa alle statistiche il Veneto, seguito a buona distanza da Sicilia, Campania e Calabria su posizioni quasi allineate, poi dalle altre con numeri più contenuti:

Tabella 2[11]

Tabella 3[12]
Le trattative con la Germania si inserivano in questo ampio quadro generale.
Alcuni accordi erano stati firmati nel 1953 per le tutele sociali e lavorative, avviando un meccanismo di cooperazione bilaterale e, alla fine di quell’anno in Germania, dove era stata segnalata già la presenza di 23.247 italiani immigrati, si parlava di «un possibile interesse italiano all’esportazione di manodopera»[13]. L’afflusso nelle banche italiane di valuta tedesca attraverso le rimesse degli emigranti era ritenuto un toccasana e ben si associava ad un possibile assorbimento della disoccupazione, con la speranza di un indebolimento dei contrasti sociali interni a favore di un consolidamento politico della Democrazia Cristiana, tutti obiettivi a cui puntava l’Italia di quegli anni, come prima si accennava[14].
Persistevano però alcuni ostacoli. In primis le resistenze dei sindacati tedeschi, che ancora puntavano ad un assorbimento della disoccupazione interna e non vedevano di buon occhio l’arrivo di lavoratori immigrati per le incerte conseguenze sulle conquiste salariali già raggiunte. La stampa e alcuni settori politici italiani avevano a loro volta diffuso il timore di possibili infiltrazioni di idee comuniste dalla Germania orientale tra i lavoratori italiani nei cantieri di lavoro tedeschi[15]. Circolavano insomma inviti alla cautela, in entrambi i Paesi:
D’altra parte, però, l’Italia era un’importantissima importatrice di carbone e i maggiori introiti delle esportazioni tedesche erano fatturati nel commercio di prodotti dell’industria meccanica, metallurgica e chimica, proprio con l’Italia[…] Così, all’inizio del 1955, la Germania federale propose all’Italia un accordo “preventivo” sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani, un accordo che sarebbe entrato in vigore solo nel caso in cui la Germania federale ne avesse avuto bisogno, e cioè solo quando la disoccupazione tedesca fosse stata completamente riassorbita.[…] Nel settembre 1955 la disoccupazione tedesca toccò il 2,7% e a novembre il ministero del lavoro tedesco stimò a 800.000 il «bisogno aggiuntivo di manodopera per il 1956»[16]
La nuova congiuntura di fine estate, decisamente favorevole per alcuni settori (edilizia, industria delle materie prime, beni d’investimento, industria dei beni di consumo), insieme al calo della disoccupazione interna, scesa a meno di mezzo milione[17], giocarono a favore della conclusione di un’intesa bilaterale per l’arrivo di manodopera dall’estero.
Nel novembre 1955, al rientro dalla visita in Italia del ministro tedesco dell’economia Erhard, furono abbattuti gli ultimi paletti per prospettare una «possibilità di collaborazione italo-tedesca»[18]. E a Roma, appena venti giorni dopo, si arrivò alla firma tra il ministro italiano agli Esteri Martino e il ministro del Lavoro tedesco Storch. Gli accordi avevano validità annuale, con tacito rinnovo alla scadenza[19].
Fu messo tutto in chiaro in ventitré articoli. Il governo tedesco, attraverso la Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Ente federale per il lavoro e l’assicurazione contro la disoccupazione) avrebbe comunicato professioni e manodopera di cui necessitava al governo italiano (artt.1, 2, 4). Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avrebbe a sua volta avviato in Italia preselezioni professionali e sanitarie in alcune regioni maggiormente interessate (art. 5). La selezione finale veniva affidata ad una Commissione tedesca, che avrebbe raggiunto alcuni punti di raccolta in Italia (art. 3). I lavoratori, selezionati per competenze professionali certificate, attestato di buona salute e certificato di buona condotta (artt. 6,7) avrebbero ricevuto in caso positivo un contratto di lavoro (art. 9) e una prima copertura delle spese di viaggio (art. 10). Si prevedevano anche contratti stagionali di nove mesi (art. 12), ma in questi casi non era previsto un permesso di soggiorno per le famiglie, ammesse soltanto in caso di contratti a lungo termine e a seguito di attestazione ufficiale di alloggio «adeguato alla composizione della famiglia» (art. 16). Si apriva inoltre favorevolmente la collaborazione ad enti di supporto, ai fini di un migliore inserimento nel tessuto sociale tedesco, prevedendo che «assistenti di organizzazioni sociali ed ecclesiastiche italiane potranno facilitare ai lavoratori italiani l’adattamento alle nuove condizioni di vita, in collaborazione con rappresentanti delle corrispondenti organizzazioni tedesche» (art. 14).
Si trattava nella sostanza di accordi legati alla domanda tedesca, che permettevano comunque all’Italia, insieme ai benefici a cui prima si è fatto cenno, di mantenere fede all’art. 35 della Costituzione repubblicana entrata in vigore nel 1948:
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi sanciti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
I nuovi contratti
L’accordo entrò in vigore subito dopo la firma. Vennero adottate le misure concordate, e il 6 febbraio 1956 la Commissione tedesca iniziò il reclutamento presso il Centro di emigrazione di Milano. Dal mese di giugno fu creato a Verona un ulteriore Centro di accoglienza per affrontare il transito di oltre 1.000 persone al giorno, a cui spesso bisognava garantire un posto letto[20]. La rapida crescita economica della Germania Federale e la maggiore richiesta di manodopera per la costruzione del muro di Berlino spinsero inoltre tra il 1960 e il 1966 a prevedere una commissione tedesca aggiuntiva presso il Centro di emigrazione di Napoli[21].
Fino al 1975 a Verona furono selezionati gli italiani diretti in Germania soprattutto da Veneto, Puglia e Campania, per rispondere alle richieste inizialmente avanzate nel settore agricolo ed edilizio del Niedersachsen, Baden-Württemberg e Nordrhein-Westfalen. All’inizio degli anni Sessanta il settore agricolo venne superato da quello edilizio e dall’industria meccanica:
Dalla metà degli anni sessanta fino alla crisi petrolifera del 1973 il flusso emigratorio italiano si diresse verso il settore metalmeccanico assumendo, soprattutto negli stati federali del Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern e Hessen, le caratteristiche di un’emigrazione di lavoro permanente[…] A partire dai primi anni settanta si andarono stabilizzando, grazie ai ricongiungimenti familiari, le comunità straniere residenti nella Germania federale. I lavoratori italiani erano passati da circa 220.000 del 1961 a circa 450.000 del 1973 e, alla stessa data, la comunità italiana consisteva di circa 620.000 persone[…][22]
I Centri di emigrazione perderanno gradualmente rilievo dopo i decreti attuativi dei Trattati di Roma firmati nel 1957, e l’emigrazione “assistita” avrebbe infine lasciato posto all’emigrazione di lavoratori che, attraverso catene migratorie con parenti, amici, conoscenti già occupati nella Germania federale, sarebbero stati assunti direttamente dai datori di lavoro tedeschi. Gli espatri in Germania si trasformeranno così in un flusso continuo con maggiore incidenza di donne e famiglie, chiamato a misurarsi con nuove incertezze sia lavorative che di inserimento sociale.
L’iniziale struttura stagionale del movimento di Gastarbeiter[23], non scoraggiò assolutamente il nuovo esodo, che anzi trovò larghi consensi specie in Sicilia, dove non si pensava di lasciare definitivamente il paese e la famiglia, quanto piuttosto di accumulare i risparmi per poter rientrare e acquistare una casa, avviare un’attività in proprio e garantire un migliore stile di vita ai propri cari[24].
A seguito della costruzione del muro di Berlino nel 1961 e del blocco della manodopera tedesca interna proveniente dalla Germania dell’est, aumentò tuttavia la richiesta di manodopera interna, e ciò portò le istituzioni tedesche a rinnovare con facilità i permessi temporanei di lavoro, tanto da permettere agli immigrati di progettare una permanenza a lungo termine, spesso definitiva. I lavoratori sperimentarono di conseguenza una maggiore mobilità occupazionale, con la possibilità di cambiare lavoro e migliorarne le condizioni: dall’edilizia del primo periodo transitarono nell’industria o nei servizi con posizioni meglio garantite. Inoltre presero a sganciarsi dai programmi di immigrazione governativi e chiamarono parenti, amici, conoscenti dai paesi di origine, o a loro volta raggiunsero colleghi parenti o amici in altre località tedesche dove avrebbero meglio potuto proseguire la permanenza all’estero[25]. Proprio in questo periodo si formano molte comunità italiane in varie zone della Germania[26], mentre aumentano le cancellazioni anagrafiche dai comuni italiani.
Quanto al pendolarismo, tratto caratteristico dei primi spostamenti del dopoguerra specie in Germania e Svizzera, rimane ad oggi di difficile misurazione poiché le statistiche italiane divergono da quelle tedesche: esso infatti non viene mai registrato in Italia, mentre è sistematicamente presente nei calcoli tedeschi per l’assunzione di manodopera stagionale. Questa discrepanza di fondo ha portato per molto tempo a sottostimare le partenze verso la Germania, poiché in Italia la misurazione veniva collegata alle cancellazioni dalle anagrafi comunali che, proprio perché si trattava di spostamenti temporanei, non venivano richieste dai lavoratori legati a brevi contratti in Germania. Le cifre risultano pertanto decisamente più alte nelle tabelle generali del movimento in ingresso rispetto a quelle relative al movimento in uscita[27]. Bisogna poi tener conto dei ripetuti rientri, che hanno reso i calcoli sugli espatri dall’Italia sempre piuttosto approssimativi, e ad oggi con i dati disponibili non è possibile una quantificazione univoca confermata da entrambi i Paesi.
La rotta “Sicilia-Germania”
Se le partenze ufficiali dalla Sicilia erano state orientate dal 1946 soprattutto verso il Belgio, dopo la tragedia di Marcinelle (8 agosto 1956), i nuovi accordi del 1955 e l’adesione al MEC, l’emigrazione in Germania divenne un possibile e allettante sbocco occupazionale[28].
Il movimento iniziale dall’Isola sfugge ancora a calcoli precisi perché le informazioni provenienti dagli uffici del lavoro di alcune province siciliane non sempre riportavano, anche per i motivi di cui si è detto prima, gli effettivi flussi in uscita verso i diversi paesi europei: a Caltanissetta, per esempio, le partenze sembravano marginali, mentre cifre più significative si registravano a Catania[29]. Si partiva comunque soprattutto con contratti a termine per brevi periodi lavorativi, seguiti da reiterati rientri. Le famiglie, in questa fase, seguivano di rado il lavoratore[30].
L’emigrazione ha trovato lunga articolazione soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta, quando divenne possibile espatriare senza passare dal Centro di Verona, che richiedeva comunque un titolo professionale valido per ottenere un contratto tedesco, titolo non sempre in possesso da chi aveva pensato di lasciare la Sicilia. Le catene migratorie, avviate da coloro che già lavoravano nelle industrie o nei servizi tedeschi, hanno più facilmente permesso di tentare, inizialmente in via temporanea, l’esperienza lavorativa in Germania. Dalla fine degli anni Sessanta la stagionalità diminuisce, aumenta la presenza femminile e la stanzialità delle famiglie. Le donne hanno trovato impiego nelle industrie tessili, in lavori domestici, in imprese di pulizia, nella ristorazione, sperimentando in molti casi per la prima volta una autonomia lavorativa. Quando sono partite col marito o sono state dallo stesso chiamate in un secondo tempo, non sempre hanno portato i figli in Germania[31], e anche per questo motivo hanno spinto per un rientro dopo alcuni anni di permanenza all’estero.
Gli uomini si sono inizialmente inseriti nell’agricoltura o come operai nell’industria metalmeccanica, come carpentieri e muratori nell’edilizia, con vari compiti nella ristorazione. Molti lavoratori hanno raggiunto col tempo un discreto livello di benessere, hanno assunto incarichi di responsabilità grazie a contratti di lunga durata e non di rado sono riusciti ad avviare imprese in proprio quando hanno rinunciato al progetto di rientro nel paese di origine. In quegli anni il governo tedesco inaugurava una sorta di politica del “doppio binario”, incoraggiando da un lato i rientri in patria alla scadenza dei vecchi contratti, ma nel contempo cercando di promuovere stabilizzazione e integrazione degli immigrati[32] anche con nuovi contratti.
Non sono certo mancate criticità legate all’inserimento dei bambini nelle scuole, alla ricerca di alloggi adeguati ai nuclei familiari più numerosi, come pure alla mobilità lavorativa a seguito del nuovo e più articolato movimento. Sono contemporaneamente aumentate le azioni di sostegno ai singoli e alle famiglie a cura di patronati, sindacati, comitati di assistenza scolastica e sociale, Missioni Cattoliche.
Divenuti cittadini italiani residenti all’estero, raggiunti ormai per buona parte dalle famiglie di origine, gli emigrati con contratti di lunga durata hanno infine interrotto il ciclo delle rimesse tipico della fase stagionale, con partenze e ritorni stabiliti dalla stagionalità del periodo iniziale[33].
In Sicilia il massiccio flusso di partenze ha inevitabilmente inciso in modo marcato non solo sulla demografia ma anche sul profilo socioeconomico e antropologico dell’isola[34], come si evince da analisi più ampie che includono la raccolta di testimonianze, di certo significative per valorizzare le diverse esperienze di vita, le difficoltà incontrate nel paese di accoglienza e le risposte date dai singoli e dai gruppi per reagire a forme di marginalità o discriminazione. Il loro apporto permette inoltre di volgere attenzione alle comunità e alle forme di associazione laica e religiosa nate all’estero, senza trascurare i legami con la terra d’origine, le relazioni e gli scambi che nel tempo si sono conservati fra i due mondi dell’emigrante siciliano[35].
Il vissuto migratorio
Nel racconto spontaneo di alcuni siciliani che hanno raggiunto la Germania negli ultimi decenni del Novecento ̶ qui di seguito riproposto ̶ prendono forma tutte le sfaccettature dei trapianti migratori, con le ombre di inevitabili criticità e le luci di scommesse riuscite: la partenza, le separazioni forzate, l’arrivo e l’inserimento in Germania, le nuove prospettive di vita.
Le selezioni tedesche infatti non sempre garantirono quanto promesso, sia per tipologia, condizioni e luogo di lavoro, che per l’offerta di un alloggio dignitoso. Chi arrivava si scontrava con difficoltà linguistiche e pregiudizi, era arduo districarsi tra i cavilli burocratici e le scuole dei figli. In Sicilia, i lavoratori stagionali lasciavano poi spesso moglie e figli, con separazioni forzate destinate a segnare tracce profonde e a spingere talvolta nel tempo verso un progetto di rientro.
La Germania si rivelerà tuttavia per altri versi il “paese del riscatto”, in cui lavoro, famiglia, garanzie sanitarie e previdenziali, opportunità di studio e di impegno sociale avrebbero pesato positivamente sul piatto della bilancia nella decisione di fermarsi all’estero, nell’ottica di un cammino di vita più sereno. Alcuni hanno provato un ritorno in Sicilia, per i legami ancora in vita o la speranza di proseguire con competenze e risorse acquisite, ma non sempre ci sono riusciti.
Dopo la lettura dei ricordi messi in ordine, si coglie in tutti lo strappo delle “spartenze”, la fatica del progetto d’esistenza in luoghi nuovi e non privi di ostacoli, la piega nostalgica tra gli eventi riportati alla memoria, la sfida comunque messa in atto. I protagonisti di quel cammino riannodano e raccontano, consegnando piccoli tasselli di storia personale e comune che confermano il contributo arricchente delle fonti orali[36].
La partenza
[…] E il settembre del 1961: un signore di Bolognetta (Palermo, N.d.A.) si interessa perché nel nostro paese venga realizzato un corso per carpentieri in legno. I diplomati avranno facoltà di poter lavorare all’estero, nella Repubblica Federale Tedesca, per circa sei mesi. Presi dall’entusiasmo, un gruppo di giovani volenterosi ci incamminiamo verso un nuovo mondo: quello dell’edilizia […] ci aggrappiamo a questo solo e unico filo di speranza, come il naufrago a dei relitti […] Il corso ha buona conclusione: 15 su 17 ci qualifichiamo[…] Il primo passo è fatto! Ora adoperiamoci per ottenere al più presto il passaporto e poi…poi via libera! Non vediamo l’ora di guadagnare per poter agevolare le nostre famiglie e per appagare qualche nostro desiderio. Dopo una lunga attesa, il 15 giugno del 1962 arriva la lettera di partenza, ancora bisogna sostenere una visita a Napoli. Ecco i 10 più assidui pronti alla partenza! […] Dopo la visita, in un ufficio veniamo presentati ad un tedesco, il quale ci chiede se intendiamo lavorare per la sua ditta; d’accordo tutti accettiamo e firmiamo il contratto di lavoro numero 446. Spunta un altro giorno. Veniamo impacchettati in un treno colmo di emigranti tutti numerati come detenuti! Viaggio verso l’ignoto, così lo definisco; non sappiamo la destinazione né la durata del viaggio (Pino Guttilla).
Quando arrivai in Germania nel 1956 a 26 anni, c’era solo disperazione a casa mia a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, da giovane si poteva andare a Palermo e diventare un soldato della Mafia o emigrare e cercare lavoro. Ma sono stato fortunato. Un prete mi ha indicato il secondo modo di scegliere, e mi ha aiutato a prendere la strada per la Germania. Insieme a un amico, abbiamo seguito l’indicazione che la società di costruzioni Alfred Müller stava cercando lavoratori a Völklingen. Abbiamo comprato i biglietti e guidato il 29/03/1956 da Catania via Milano, Metz, Forbach (L. Fichera).
Decisi di partire da Giarre (Catania) nel 1958, all’età di diciotto anni, dopo la licenza di scuola media, non riuscendo a trovare un lavoro stabile. In quel periodo in Sicilia era difficile trovare lavoro, e molti giovani lasciavano la loro terra per andare all’estero. Tramite il consolato italiano seppi che la Germania cercava all’epoca operai da inserire nelle miniere e nelle fabbriche e gli italiani venivano assunti soprattutto nelle fabbriche di mattoni e blocchi per l’edilizia, oppure nelle acciaierie. Così arrivai in Germania con un contratto di lavoro in fabbrica, e oltre a lavorare iniziai un corso serale per imparare il tedesco (Giuseppe Restivo).

Ho lasciato a 23 anni, nel 1960, San Piero Patti, in provincia di Messina. Avevo seguito gli studi fino alla terza media ma, non trovando lavoro nel mio paese, decisi di emigrare in Germania perché avevo saputo che alla Volkswagen assumevano operai. Partii in treno insieme a mio fratello e ad altri coetanei (Cesare Lembo).
Quando arrivai a Schönaich, nel distretto di Boblingen, nel 1963, all’età di quattro anni, con i miei genitori e due fratelli maggiori da Mirabella Imbaccari, provincia di Catania, era tutt’altro che bellissimo. Nel 1961 venne mio padre, un anno dopo portò mia madre in Germania e nel 1963 noi che eravamo bambini, che ci piacesse o no (Gaetano Venezia).

Sono nato a Carlentini (Siracusa) un paese di 13.000 abitanti situato in collina a 25 km sud da Catania. Dopo le scuole medie con mio fratello frequentammo per tre anni le scuole di addestramento professionale al CIAPI e imparammo un mestiere: mio fratello come congegnatore meccanico ed io come tornitore/ fresatore […] Dopo aver finito il professionale nel giugno del 1972 con altri due amici compagni di scuola, la voglia di poter trovare un posto di lavoro era immensa, e quindi passammo tutta l’estate con Biagio e Claudio chiedendo a tutte le ditte metalmeccaniche della zona di Catania e Siracusa se gli serviva della mano d`opera. […] Verso gli inizi di settembre Biagio ci fece sapere che mediante dei parenti, era venuto a conoscenza che in Germania esattamente a Sulz am Neckar c’erano molte ditte metalmeccaniche e una ditta cercava esattamente operai con qualifica di tornitore/fresatore e che se entro la fine di settembre fossimo disposti a trasferirci, ci avrebbero aiutato anche a trovare un posto per dormire […] Con la 600 di Biagio ci mettemmo in viaggio, quattro giorni ci impiegammo per arrivare a Sulz am Neckar, per attraversare le Calabrie ci volle tanto tempo, oltre a un guasto della macchina non c’erano nemmeno le autostrade allora (Franco Albani).
Nel 1977 sono stato costretto ad emigrare all’estero in cerca di lavoro, perché a Mascali (Catania) il lavoro scarseggiava. Avevo lavorato come bracciante agricolo abituale (tratturista) e raccoglitore di agrumi, ma in quel periodo quel settore rendeva davvero poco, a causa delle crisi che cominciava ad investire il settore agrumicolo ed agricolo in generale. Cambiai così la mia qualifica di bracciante in quella di manovale comune, frequentando un cantiere-scuola per 120 giorni. La qualifica di manovale mi diede la possibilità di trovare lavoro all’estero. L’11 novembre partii per la Germania, dove ero già stato precedentemente per pochi mesi (Alfio Zappalà).
In Germania
Finalmente arriviamo alla frontiera italiana; dal Brennero attraverso l’Austria e un tratto di Svizzera giungiamo in Germania[…] Un solo nome ci è noto: «Sterkrade». Arriviamo in questa città alle 22.00 circa. Alla stazione viene a prenderci il tedesco e l’interprete che abbiamo incontrato a Napoli. Man mano che usciamo dalla stazione entriamo in una cabina di foto istantanee (in un minuto quattro foto!). […] Dopo le foto ci imbussolano in un camion chiuso ed in 20 minuti circa arriviamo a Sterkrade più preciso a Fronstebruk. Basta trasportarsi con la fantasia in un villaggio western con una stradetta dritta lunga circa 300 m, fiancheggiata da baracche di legno per avere l’idea del luogo! Ogni baracca ha due porte, quattro stanze per ogni porta anch’esse numerate. Non manca la grande sala pure in legno (paragonabile al saloon), mensa per gli abitanti del villaggio. Televisione e radio sono sistemati in un altro salone; i due saloni sono divisi dalla cucina per poter servire meglio. Il camion ci scarica dinanzi il saloon. È venerdì, l’interprete ci chiama ad uno ad uno, ci offre un anticipo e ci annuncia che lunedì visiteremo la fabbrica, nostra fonte di lavoro. L’interprete ci assegna i letti, stanchi e soli con i nostri pensieri ci addormentiamo con un bagaglio di ricordi e con una grande speranza per il futuro! (Pino Guttilla).

L’Ufficio di collocamento mi trovò un posto presso l’azienda Firma Saiszi a Waiblingen. Lì lavorai per sei anni come manovale comune (non specializzato) in cantieri per la costruzione di case e infrastrutture. Trascorso questo periodo trovai impiego nel settore metallurgico e principalmente in fabbriche di componenti automobilistici; lavorai pure in fonderia (Alfio Zappalà).
Sono arrivata a Monaco con la mia famiglia negli anni Sessanta, avevo 11 anni. Siamo partiti da Taormina con la Freccia del Sud, a Bologna abbiamo poi preso il treno per Monaco, per altre 12 ore di viaggio, avevamo finito il cibo, eravamo stanchissimi. Ci aspettavano alcuni amici e abbiamo trovato alloggio in un quartiere di italiani. I problemi sono iniziati a scuola perché non capivo il tedesco ed ero l’unica alunna italiana in classe. L’insegnante ripeteva: «Non so come fare con questa ragazza, non so dove metterla». Mi misero al primo banco e mi dissero che dovevo copiare tutto quello che vedevo sulla lavagna, ma io non capivo nulla. Due mesi dopo aprirono la scuola italiana e con gli altri ragazzi italiani siamo stati spostati lì, dove abbiamo imparato anche il tedesco. Finita la scuola dell’obbligo, sono stata assunta nel 1970 in una grossa ditta come interprete perché parlavo italiano e potevo aiutare i miei connazionali (Maria Caggegi).
In Germania nacquero alcune amicizie, tra cui quella con un altro siciliano che diverrà il padrino di mio figlio, e con una coppia di tedeschi con cui sono ancora in contatto. Alcuni tedeschi invece erano diffidenti poiché erano convinti che gli immigrati rubassero loro il lavoro. Dopo i primi mesi mi ero ambientato, mi piaceva lavorare, avevo imparato la lingua e, per avere un lavoro sicuro e dare un futuro migliore ai figli, avevo pensato di stabilirmi in Germania. Mia moglie però non è mai riuscita ad ambientarsi: rimaneva per brevi periodi, per poi ritornare in Sicilia. Così dopo vent’anni, nel 1978 abbiamo deciso insieme di rientrare definitivamente in Sicilia (Giuseppe Restivo).
Schönaich non era casa mia e qualche anno dopo, quando arrivai a scuola la situazione peggiorò. A quel tempo, nessuno sapeva veramente cosa sarebbe successo agli scolari di origine straniera. I compagni di scuola erano tutt’altro che gentili con me. Continuavo a farmi prendere in giro, quindi non avevo voglia di andare a scuola. Il mio rendimento scolastico era commisurato alle circostanze e in seconda media lasciai la scuola senza un certificato di maturità. Nel periodo successivo, ho voluto provare a farcela più e più volte per la dichiarazione del preside della scuola, che mi aveva detto in una conversazione faccia a faccia: „Ragazzo, non sei così stupido! Puoi farcela se vuoi!“
Ho completato il mio certificato di scuola secondaria attraverso una speciale acquisizione di formazione per adulti italo-tedesca e così ho avuto la possibilità di imparare la professione di autista di pullman. Con la qualifica professionale, anche la mia autostima è cresciuta. Avevo raggiunto con successo un obiettivo che nessuno si aspettava grazie alla fiducia in me stesso. Di conseguenza, ho frequentato una scuola tecnica per un paio d’anni e nel 1986 ho superato con successo il mio master a Karlsruhe.
Fino all’età di 20 anni, il mio piano era quello di costruire qualcosa in Italia. Ma per vari motivi questo non è accaduto. Dopo il mio master, mi è venuta l’idea di dare un primo nome a un piccolo laboratorio di carrozzeria a Schönaich[…] Nel 1999 ho presentato la mia candidatura per il consiglio comunale e sono stato anche eletto con i voti degli elettori tedeschi[…] Per decenni, la Germania non è stata la mia casa, e spesso pensavo come e quando di lasciarla. Ho incontrato e sposato mia moglie, anch’essa di Mirabella, in Sicilia. Abbiamo due figli di 18 e 16 anni e vogliamo tornare in Italia, in vacanza, qualche volta. Ci piace essere italiani, ma ci piace avere la nostra casa a Schönaich, in Germania (Gaetano Venezia).


Mia madre Giuseppa Vicenzino era arrivata nel 1970 con la famiglia da Militello Val di Catania. Essendo la maggiore dei figli, doveva accudire la casa e le due sorelle di 5 e 3 anni, incontrando anche l’ostilità dei vicini, perché nella casa in cui vivevano non erano accettati bambini stranieri. Infatti dopo alcuni mesi furono sfrattati e finirono per un breve periodo in una baracca di legno.
Quando le mie zie furono in grado di andare a scuola da sole, mia madre espresse il desiderio di ritornare a scuola ma, essendo ormai grande, poteva solo frequentare la scuola serale gestita dalla Missione Cattolica.
Vi rimase solo alcuni mesi, perché i compagni di scuola non erano della sua età, ma persone adulte e stanche, che dopo una giornata di lavoro dormivano sui banchi e a cui la licenza della terza media serviva solo per poter avviare un esercizio pubblico. Così la mamma a 16 anni iniziò a lavorare da Mc’ Donalds, cominciando ad avere delle relazioni sociali.

Il nonno e la nonna nel frattempo avevano deciso di aprire una pizzeria e ci riuscirono dopo 8 anni: nel 1978 aprirono “La bella Pizzeria da Enzo”.
Il desiderio di ritornare nella propria terra era tuttavia sempre molto forte e incominciarono penosi e frequenti viaggi di andata e ritorno. In uno di questi viaggi mia madre conobbe mio padre e decise di rimanere in Sicilia e di non ritornare più in Germania[…] Un emigrante, lei dice, è un albero sradicato (Valeria La Spina).
In Germania siamo arrivati nel 1961, sono stati anni di duro lavoro, di sacrifici e di difficoltà legate soprattutto alla non conoscenza della lingua. Con mio marito abbiamo trovato impiego in una fabbrica tessile per dodici ore al giorno, e ci alternavamo per occuparci del bambino. Abbiamo incontrato molti altri immigrati come noi, con cui condividevamo pensieri e stati d’animo (Grazia Vecchio Licciardello).


A Forbach siamo stati prelevati da un connazionale che ci ha contrabbandato illegalmente attraverso il confine franco-tedesco fino a Völklingen. […] Con altre 90 persone, tutte all’estero, abbiamo condiviso alcune caserme per dormire. Non avevamo quasi alcun contatto con i tedeschi al di fuori del lavoro.
Ero solo tra gli stranieri, senza essere in grado di comunicare linguisticamente, con un duro lavoro, la nostalgia di casa, umiliazione e fatiche. La cosa peggiore era venire in caserma la sera e non trovare nessuno che ti aspettasse. Nel 1972 sono diventato caposquadra e ho lavorato in azienda fino a quando sono diventato pensionato nel 1992 (L. Fichera).

Arrivati a Sulz trovammo pure paesani e molti altri italiani disposti ad aiutarci, alleviando le difficoltà che incontravamo non conoscendo la lingua tedesca, per sbrigare i documenti. All’inizio in fabbrica cercavo di farmi capire con quelle poche conoscenze dell’inglese apprese alla scuola media. Dal mese di ottobre fino al giugno del ’73 cambiai tre ditte, l’impatto con la realtà, la disciplina, la puntualità e perfezione nel mondo del lavoro che non conoscevo, furono il motivo per il licenziamento, il non essere puntuale, alle 5:30 dovevo timbrare il cartellino, con quel freddo ghiaccio e neve che io in Sicilia non avevo mai visto e provato. L`ambiente era buono, però dopo il lavoro avevo contatti solo con italiani: bar, ristorante, circolo, cinema discoteca , tutto in italiano[…] decisi di cambiare aria di andarmene a Wolfsburg dove c’era un amico d’infanzia il quale lavorava alla Volkswagen e mi disse che la ditta assumeva operai. Così fu proprio come lui mi aveva descritto, mi ospitò nell’appartamento che si dividevano in quattro, una cucina in comune e con i servizi igienici. Dopo il terzo giorno d’arrivo, andai a passare la visita e la settimana dopo mi assegnarono un posto per dormire, non negli appartamenti dove abitava ll mio amico, bensì nelle baracche di legno. Una stanza, quattro lettini, due armadi, un tavolo con quattro sedie, i servizi igienici così pure la cucina erano in comune che ci dividevamo con altri 20 lavoratori di diversa nazionalità […] Mi ricordo che quando mi alzavo di notte per andare ai servizi il pavimento di legno scricchiolava, cosi pure quando rientrava qualcuno di notte o a tarda sera, mi svegliavo e non potevo più dormire […] quando alla Mercedes si prospettò l’opportunità di lavorare nel consiglio di fabbrica mi presentai subito. Pian piano la fabbrica è divenuta così la mia vera casa […] posso senz’altro dire che l’esperienza in Germania mi ha molto arricchito. Considero questo Paese anche in parte “il mio Paese” (Franco Albani).
Sono nato in Germania, da emigranti italiani. Emigranti da Aragona (Agrigento) furono i miei nonni, i miei zii. Mio padre, rimasto a 10 anni orfano di padre, dovette lasciare l’Italia quando ancora non aveva compiuto sedici anni, nel 1962. Il viaggio, benché in treno, non fu felice: si trattava di un minore non accompagnato. In Germania non rimase molto. A seguito di un’imprudenza di carattere amministrativo, restò senza lavoro e per riparare si recò in Svizzera. Là subì angherie. Sprovvisto di documenti, rientrò in Germania a Lippstadt. Dapprima si mise a commerciare maglioni di lana e guanciali, poi passò a fare il lavavetri, e anche qui una brutta esperienza: il datore di lavoro non gli corrispose il salario, perché papà era clandestino. Abitava in una baracca, i servizi igienici e la mensa erano comuni e posti fuori dall’abitazione. Visse con degli spagnoli, gli altri italiani si rifiutavano di stare con loro. Il suo approdo a Oberhausen, dove sono nato, non avvenne immediatamente, ma solo nell’agosto del 1968. Finalmente, dopo anni di erranza, si stabilì a Oberhausen, divenendo un operaio delle acciaierie […] La mia vita di emigrato non è durata molto, ma di quella esperienza ricordo una frase che, di tanto in tanto, mi sentivo urlare addosso con veemenza, senza capirne il senso e la motivazione: Ausländer raus!, «straniero vattene!». Conservo il ricordo della nostra padrona di casa avida e cattiva, ma anche quello di un vicino tedesco, buono come il pane, che ci voleva bene e che ogni giorno mi dava un marco per comprarmi il gelato. Nel 1975 siamo rientrati in Italia, con un’invalidità a causa del lavoro. Da oltre quarant’anni mio papà paga, e noi con lui, un prezzo altissimo: di migrazione si vive, ci si ammala e ahimè si muore, ultimamente moltissimo. Sono cresciuto nello sradicamento: la mia patria è l’Italia e la mia nostalgia la Germania (Alfonso Cacciatore).

La mia famiglia è originaria di Biancavilla, in provincia di Catania. Nel 1989 mio marito decide di rientrare in Germania, dove ancora viveva la sua famiglia. Nel 1990 l’ho raggiunto anch’io con la piccola di 11 mesi: era la prima volta che uscivo dal paese e quel viaggio, che feci da sola su un bus della ditta Cipolla con mia figlia in braccio, rappresentò per me una grande, forte esperienza. A Francoforte ci siamo inseriti e lì abbiamo cresciuto la nostra famiglia. Provammo per un paio di anni un rientro in Sicilia ma quel tentativo non andò bene e tornammo a Francoforte. Qui io ho prima avviato una sartoria ma adesso lavoro come cuoca in un asilo statale (Concetta Sergi).

Le separazioni forzate

La mia famiglia proveniva da Caltagirone (Catania). Mia madre aveva raggiunto mio padre, già emigrato a Lippstadt, nel 1968. Io sono nata in Germania nel 1969[…] Sono rimasta con i miei genitori fino a 15 mesi, poi sono stata affidata alla nonna materna in Sicilia, dove sono rimasta fino a 14 anni […] Mi è sempre pesata la separazione dai genitori e dai fratelli: non riuscivo a comprendere perché soltanto io fossi stata allontanata da loro. Conservo ancora un ricordo: avevo due anni e mezzo, forse tre, e piangevo perché volevo il papà. La zia dalla disperazione per il mio pianto mi disse che il mio papà era il nonno. E così da quel momento il mio nonno è sempre stato il mio papà.
Sentivo i miei genitori ogni due settimane o una volta al mese: chiamavano al telefono che si trovava presso il bar o dalla vicina, perché i nonni non avevano il telefono in casa. I miei genitori telefonavano al centralino e fissavano un appuntamento per sentirci. Poi qualcuno del bar veniva a comunicarci l’appuntamento telefonico e i nonni ed io andavano al centralino. A volte poteva succedere di aspettare la telefonata per ore. Quegli appuntamenti non erano per me sempre momenti di gioia perché sentivo spesso la voglia di vivere con loro e talvolta mi sono rifiutata anche di parlargli al telefono (Alda Gravina[38]).
Mio padre Giuseppe Biondo e mia madre Rosaria Pizzo per motivi di povertà emigrarono lasciando me e mio fratello Damiano ai nonni materni. Per otto anni, fino al 1970, io e mio fratello siamo stati cresciuti ed educati a Terrasini (Palermo) da nonna Grazia e nonno Damiano, umile e fortissimo zappatore e con la presenza di tre zii: zio Turi, zio Lorenzo e zio Pino. Ogni mese i miei genitori mandavano un vaglia postale di colore rosa ai miei nonni per farci mangiare, studiare e vestire. Sia alle scuole elementari, come alle scuole medie inferiori, ho avuto sempre maestri di sostegno perché ero demotivato nello studio ripetevo come un mantra: «dove a mamma, u ne‘ u papa?». Avevo nel cuore una forte carenza affettiva e nessuno mi capiva. Molto tardi ho saputo una confidenza di mia madre, quanto ha pianto per il distacco dei figli e la nostalgia del paese (don Arcangelo Biondo).
Sono emigrata in Germania da Giarre (Catania) nel 1961 a 22 anni, con mio marito Pasquale Licciardello e mio figlio, mentre ho dovuto lasciare in Sicilia la secondogenita, affidata con dolore ai miei genitori per quasi sei anni (Grazia Vecchio Licciardello).

Quelle valigie di sofferenza
Tutti dicono Germania Germania– e se ne riempiono la bocca / come fosse la manna del cielo /
a me non ha portato che sfortuna / ma io sono cocciuto come un mulo /
e andrò in Germania fino a quando crepo[…][39]
Il viaggio d’emigrazione, con tutte le sue implicazioni e conseguenze, è stato ripreso anche in produzioni letterarie, cinematografiche e di altro respiro artistico[40]. Se è stato difficile, almeno nella prima fase, misurare con i numeri l’esodo dalla Sicilia verso la Germania per i motivi prima indicati, il diffuso movimento con i suoi grovigli di sofferenza ha trovato più immediata espressione nella produzione di poeti, scrittori, registi.
Versi e racconti provano a dipanare i nodi di quei conflitti interiori che si cercò con forza di stipare nelle valigie delle partenze. Nella cinematografia il quadro diviene forse più corale, declinando testi e immagini nella denuncia sociale e nella volontà di riscatto.
Consegna al grande schermo le difficoltà presenti nella terra di origine che costringevano a fuggire dall’Isola, il film Palermo o Wolfsburg di Werner Schroeter (1980), successivamente acuite dall’ isolamento linguistico e relazionale dell’emigrato nel paese straniero.
Il giovanissimo Nicola Zarbo decide di lasciare Palma di Montechiaro per lavorare alla Volkswagen, ma non riesce ad inserirsi facilmente nel nuovo contesto e il suo sogno di un avvenire sereno tramonta assai presto: verrà infatti incriminato a Wolfsburg, nella Bassa Sassonia, per l’omicidio di due amici della sua fidanzatina tedesca, uccisi in un momento di devastante smarrimento, accecato dalla gelosia. Durante il processo, una lunga arringa difensiva trascina all’interno del tribunale le condizioni di vita dei siciliani, presentandoli privi di lavoro dignitoso e in fuga dalla povertà, costretti all’abbandono di ogni affetto e protezione. La pellicola portava all’attenzione del pubblico internazionale i costi umani e sociali dei flussi migratori forzati dal bisogno, insieme alle pesanti imprevedibili conseguenze che una mancata integrazione, a seguito dello sradicamento dai luoghi di origine, avrebbe potuto generare.
La sceneggiatura puntava a rappresentare «atmosfere, situazioni e personaggi di una realtà crudele, indifferente al dolore e priva di ogni alito umano»[41]. Rimandava alla comune condizione di emarginazione degli emigrati in terra straniera, costretti a frequentarsi tra loro in gruppi chiusi, allontanati anche per i limiti linguistici da ogni tentativo di integrazione reale.

Si torna a Palma di Montechiaro, comune agrigentino ancora oggi a fortissima incidenza emigratoria, con il film La Terramadre di Nello La Marca (2008). Il regista porta nella pellicola non più il forte desiderio di partire presente nel lavoro di Werner Schroeter, quanto la pena dei dolorosi distacchi dai luoghi di origine, facendosi portavoce delle nuove dinamiche che sembravano prendere forma in Sicilia alla fine del secolo, quando si pensava che l’emigrazione appartenesse ormai al passato e che tutta l’Italia fosse piuttosto divenuta terra d’immigrazione. Gaetano, il giovane protagonista, rimasto orfano di madre, ha per anni sofferto la mancanza del padre, emigrato in Germania, e si è aggrappato all’affetto di una zia rimasta in paese che lo ha accolto nella sua casa. La Germania entra nell’immaginario del giovane, che non ha mai raggiunto il padre, come il paese della separazione, associato ad assenze più che a presenze, a sconfitte più che a successi. Terra di ulteriore umiliazione, piuttosto che contesto di riscatto. E quando il padre ritorna in paese per convincere Gaetano a salire con lui sull’autobus “Palma di Montechiaro-Mannheim”, il ragazzo, cresciuto nella terra in cui è sepolta sua madre, trova in quel legame alle cose e ai ricordi dei tempi felici, la spinta per rifiutare la decisione paterna: riprende la sacca già caricata nel bagagliaio del bus e volta le spalle al gruppo che si accinge a partire, dichiarando così la sua volontà di studiare e rimanere in paese, di conservare le radici nella “terramadre”.
Non partire ma rimanere, dunque, diventa il suo progetto di futuro. In una Sicilia che in quegli anni sembrava voler escludere nuove odissee forzate per il mondo, per mettere alle spalle i drammi delle “spartenze” che avevano segnato intere famiglie.

Ancora si dice «Germania Germania»
La storia ha però ripreso la vecchia strada. Dai primi anni del Duemila, quando si pensava che il ciclo emigratorio si fosse ormai notevolmente ridotto, secondo alcuni addirittura esaurito, in Italia riprende un significativo flusso di mobilità verso l’estero, con prevalenza di giovani in formazione o già qualificati. Proprio a partire dal 2008 si aprirà il nuovo ciclo delle partenze[42], e Palma di Montechiaro dovrà di nuovo caricare le valigie su bus, treni, aerei in cerca di benessere e guadagno altrove: nel 2024 il 57,2 per cento dei suoi abitanti risiede all’estero, soprattutto in Germania. Ma non è l’unico comune trascinato nella nuova ondata migratoria:
Poco meno di un siciliano su tre di quelli che risiedono all’estero vive in Germania. Nella locomotiva d’Europa, eletta da decenni a destinazione preferita di tante comunità dell’Agrigentino, del Trapanese o del Catanese, vivono 251.500 siciliani. Molti dei quali si spostano nelle tratte affollate che dall’aeroporto di Trapani raggiungono città come Dusseldorf o Karlsruhe. O le autolinee di bus che dall’Agrigentino collegano decine di centri tedeschi con lunghi viaggi che attraversano l’Europa. Così la “Sizilien” in Germania è la 28esima città più popolosa della Repubblica federale[43].
Sono numeri in crescita, sebbene negli ultimi anni siano mutate le opportunità professionali e di inserimento sociale offerte dal sistema tedesco. L’arrivo del Covid19 ha generato un impatto non indifferente sulle condizioni lavorative degli italiani immigrati, che hanno visto in poco tempo cambiare contratti e sbocchi occupazionali, con un drastico aumento del tasso di disoccupazione, salito tra i giovani immigrati italiani del 63,4 per cento rispetto al 2019, con maggiore incidenza tra i laureati. Ne hanno risentito soprattutto «la gastronomia, il turismo, la logistica, il commercio, il settore dei servizi digitali, culturali o sociali»[44]. Molti i dubbi sul futuro del mercato del lavoro tedesco e sugli effetti che il nuovo scenario potrebbe avere sulla mobilità e sui progetti di permanenza in Germania, così come sulla reale valorizzazione delle competenze che fino a qualche anno fa fungeva da fattore attrattivo per chi entrava nel paese con titoli di studio elevati:
Che tipo di mobilità possiamo pensare per il domani dell’emigrazione italiana in Germania? Ci sarà un ripensamento sul perché “mettersi in moto”, non solo per le tante famiglie ma anche per i cosiddetti “nuovi mobili”?[45]
Aerei e bus sempre pieni, si diceva. Non è possibile dire fino a quando, e in quale orizzonte di scelte e prospettive, ma al momento un dato è certo: nella Sicilia delle partenze ininterrotte si preparano ancora le valigie. E si continua a dire «Germania Germania».
[1] Preambolo dell’Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il
collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 17 agosto 1956.
[2] L’Italia aveva firmato tra il 1946 e il 1955 accordi bilaterali con quattordici nazioni: nel 1946 gli accordi bilaterali con il Belgio e la Francia, nel 1947 con la Gran Bretagna, la Cecoslovacchia, la Svezia, l’Argentina, nel 1948 gli accordi con il Lussemburgo, la Svizzera, l’Olanda, nel 1950 con il Brasile, nel 1951 con la Sarre (Saarland). Nello stesso 1951 si registrava l’Assisted Migration Agreement con l’Australia, che così apriva le sue porte all’emigrazione europea ( con picco di arrivi tra il 1947 e il 1971), e l’accordo tra Venezuela e CIME (Comitato intergovernativo per l’emigrazione europea), che entrò in vigore l’anno successivo e che fino al 1956 permise l’arrivo di 167.000 italiani, seguiti da altri 5.000 nel 1957. Il Venezuela divenne in alcuni centri della Sicilia ( tra cui Canicattini Bagni e Santa Ninfa) una meta preferita alla stessa Argentina, tanto che fino al 1960 il numero totale di arrivi toccò le 236.000 unità. Nel 1952 venne firmato l’accordo con l’Ungheria e nel 1955 quello con la Repubblica Federale tedesca.
[3]Per la Germania Federale si trattava della prima intesa postbellica per il reclutamento di manodopera straniera. Avrebbe firmato tra il 1955 ed il 1968 otto accordi bilaterali: oltre che con l’Italia, con la Grecia e la Spagna nel 1960, con la Turchia nel 1961,con il Marocco nel 1963, con il Portogallo nel 1964, con la Tunisia nel 1965 e con la Jugoslavia nel 1968.
[4] La tabella è stata realizzata dall’Autrice con i dati forniti da Delfina Licata della “Fondazione Migrantes”, che ringrazio per il sostegno alla ricerca.
[5]F. Romero, L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973), in P. Bevilacqua, A. De Clementi e E. Franzina ( a cura di), Storia dell’emigrazione italiana – Partenze, Donzelli Editore, Roma 2001, pp. 400- 403.
[6]Cfr. Ministero Affari Esteri, Direzione generale dell’emigrazione, Emigrazione italiana (Situazione, prospettive, problemi) 31 marzo 1949, MAE, Roma 1949.
[7] M. Colucci, Forza lavoro in movimento. L’Italia e l’emigrazione in Europa, 1945-1957, Tesi di dottorato, Viterbo 2008, p. 248.
[8] F. Romero, L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973), cit., p. 403.
[9] Ivi, p. 404.
[10] M. Sanfilippo, L’emigrazione siciliana, «Archivio storico dell’emigrazione Italiana», n.3, 2007, pp. 85-86.
[11] Colucci, Forza lavoro in movimento…, cit, p. 256.
[12] Ivi, p. 252.
[13] Ivi, p. 226.
[14] A. De Clementi, “Curare il mal di testa con le decapitazioni”. L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra. I primi dieci anni, «’900», 8-9 (2003), p. 14.
[15] I toni erano talvolta allarmistici: «i comunisti della Germania orientale hanno stabilito di inviare loro agit-prop fra i lavoratori italiani dopo che questi saranno giunti nella Repubblica federale tedesca. Gli agenti comunisti faranno tutto il possibile per infiltrarsi nei cantieri nei quali saranno impiegati gli italiani» («Corriere della sera», 16 dicembre 1954, p. 12).
[16] G. Pontera, L’emigrazione italiana verso la Repubblica federale tedesca. L’accordo bilaterale del 1955, la ricezione sulla stampa, il ruolo dei Centri di emigrazione di Milano e Verona, «Storicamente», 2008.
[17] Ibidem.
[18] Colucci, Forza lavoro in movimento…, cit, p. 231.
[19] Gli accordi verranno sostituiti dalla graduale adozione della normativa comunitaria dopo i Trattati di Roma del 1957.
[20] G. Pontera, L’emigrazione italiana verso la Repubblica federale tedesca…, cit.
[21] Ibidem.
[22] Ibidem. Le condizioni di accoglienza dei lavoratori arrivati in Germania non sempre risultarono fedeli alle promesse del trattato. Iniziarono, anche da parte della stampa, le prime segnalazioni nelle fabbriche per alloggi non idonei, trattamento salariale inferiore alle aspettative, vitto insufficiente, condizioni di lavoro non tutelate, ma gli operai non sempre riferivano correttamente sullo stato delle cose per timore dei licenziamenti. Quei malesseri furono spesso soffocati. «Le autorità tedesche – in questo poco contrastate dai colleghi italiani – mostrano fin dai primi mesi successivi all’accordo di non gradire proteste organizzate e critiche da parte degli immigrati alle strutture di accoglienza» (M. Colucci, Forza lavoro in movimento…, cit, pp. 235-236).
[23] Con tale termine venivano indicati i “lavoratori ospiti”, arrivati in Germania con contratti di breve durata.
[24] Per i trasferimenti definitivi in quegli anni si optava soprattutto per le città del Nord Italia, dove con minori difficoltà linguistiche e culturali le famiglie avrebbero potuto essere più facilmente trapiantate, oppure ancora a mete extraeuropee, in particolare all’Australia, divenuta per la Sicilia orientale il nuovo orizzonte da raggiungere. Questo spiega perché il maggior numero di rientri negli ultimi decenni del Novecento sia stato registrato da paesi europei piuttosto che da quelli extraeuropei o dal Nord Italia.
[25] F. Romero, L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973), cit., pp. 411- 412.
[26] La maggiore concentrazione di siciliani emigrati in quel periodo si registra oggi nelle regioni industriali della Germania occidentale, in particolare nella zona di Monaco di Baviera (stabilimento BMW), Stoccarda (Mercedes), Francoforte e Colonia.
[27] F. Romero, L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973), cit., pp. 412-413.
[28] E. Pugliese, In Germania, in P. Bevilacqua, A. De Clementi e E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli Editore, Roma 2002, p. 128.
[29] M. Colucci, Forza lavoro in movimento…, cit, p. 118.
[30] Cfr. L. Licata, Siciliani in Germania: storia di una generazione dai sogni infranti, «L’inchiesta Sicilia», 2 marzo 2016.
[31] La separazione forzata imposta ai bambini è dolorosamente ricordata dalle madri e dai figli, seppure sia stata rimossa per molto tempo dalle quotidiane conversazioni. Rimane per molti di loro una ferita ancora aperta, come emerge da alcune testimonianze presenti in questo saggio.
[32] Cfr. Enrico Pugliese, In Germania, in P. Bevilacqua, A. De Clementi e E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli Editore, Roma 2002, p. 130.
[33] Nel 1980 solo in Sicilia le rimesse furono di 213.027 milioni di lire. Il flusso è ancora proseguito per alcuni anni, tanto che da Agrigento le rimesse nel 2005 sono ancora quantificate in 2 milioni e 400mila euro sui 22 milioni 631 mila regionali. La provincia mantiene il primato di espatri dalla regione (106.144 su 554.491) registrati in AIRE, comprensivi anche delle precedenti emigrazioni. Nel 2006 la cifra sale a 2 milioni 817 mila su 21 milioni 224 mila regionali; proseguono nel 2007, con 2 milioni 551 mila su 20 milioni 211mila (quindi oltre il 10 per cento regionale), cifra con cui la provincia si colloca al terzo posto dopo Palermo e Catania, con un totale di iscritti AIRE di 134.547 su 629.115 regionali. Dal 2008 il dato “rimesse” non viene più riportato nelle statistiche nazionali, probabilmente perché divenuto ormai poco rilevante.
[34] All’emigrazione verso l’estero, dalla Sicilia si aggiunse fino agli anni Novanta una massiccia migrazione interna verso il Centro e il Nord Italia, mentre proseguiva quella dalle aree interne alla zona costiera e urbana. Dal 1951 al 1971, mentre solo il 30 per cento dei suoi abitanti è rimasto nelle zone interne, la popolazione agricola si è quasi dimezzata, le città hanno avuto un incremento demografico del 240 per cento e il settore primario dell’agricoltura è addirittura precipitato nel bilancio economico regionale dal 40,5 per cento al 16,7 per cento. Sull’argomento rimando a Giuseppe Oddo, La Sicilia delle spartenze nel secondo dopoguerra, in N. Grato, G. Oddo, Nostra Patria è il mondo intero, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo 2021, pp. 134-135.
[36] Le testimonianze di questa sezione, raccolte in vari periodi e qui riportate con brevi estratti per esigenze di spazio, ricostruiscono alcuni progetti di vita in Germania coltivati in diverse aree della Sicilia nella seconda metà del Novecento. Ringrazio la giornalista del «Corriere d’Italia» Paola Colombo per il prezioso aiuto nella ricerca delle fonti a Francoforte; il sindacalista-operaio Franco Albani per avermi introdotto, attraverso il racconto della sua storia, alle condizioni lavorative dei nostri emigrati nel settore metalmeccanico della regione del Baden Württemberg. Alda Gravina, Concetta Sergi, Alfonso Cacciatore per le lunghe conversazioni telefoniche sulle loro esperienze dalla Sicilia in Germania; il Museo etneo delle migrazioni per le storie e le immagini di Cesare Lembo, Alfio Zappalà, Giuseppa Vicenzino, Giuseppe Restivo, Grazia Licciardello; don Arcangelo Biondo, religioso guanelliano, con cui ho a lungo conversato in occasione del Convegno Nazionale delle Missioni/Comunità cattoliche di lingua italiana in Germania (Palermo3-6 ottobre 2023) organizzato da don Gregorio Milone col patrocinio della Fondazione Migrantes. La testimonianza di Pino Guttilla è tratta da S. Lombino, Cinque storie migranti. Fronstebruk 1962 di Pino Guttilla, in «Nuova Busambra», n. 2, dicembre 2012, pp. 69-71. La storia di Gaetano Venezia è stata pubblicata su B. Di Croce ( a cura di), Das Land, Das Nicht Unser Land War, Von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe 2018, pp. 197-198; quella di L. Fichera è tratta da B. Di Croce (a cura di), Die Arbeit Jenseits Der Heimat, Von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe 2017, p. 24. Per la testimonianza di Maria Caggegi rimando al video “Testimonianze”, realizzato all’interno del “Progetto Migranti” (https://youtu.be/yyAXhu0R4Vs ).
[37] L’immagine è tratta da B. Di Croce ( a cura di), Das Land, Das Nicht Unser Land War, Von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe 2018, p. 198.
[38] Alda precisa che si è in seguito ricongiunta ai familiari in Germania, e le nuvole presenti nel periodo della separazione si sono pian piano diradate, permettendo spazi di condivisa serenità: «In Germania ho continuato gli studi. Ho ottenuto una certificazione come infermiera professionale, sono stata come volontaria nelle Missioni dell’Amazzonia e Angola e, dopo essermi laureata, sono adesso assistente pastorale presso la parrocchia di lingua italiana Villingen-Singen. Con il tempo ci siamo chiariti in famiglia e ora abbiamo tutti un buon rapporto. Oggi posso dire di essere serena nelle mie relazioni con loro».
[39] S. Vilardo, Tutti dicono Germania Germania, Sellerio, Palermo 2007, p. 99.
[40] M. Sanfilippo, L’emigrazione siciliana, in «Archivio storico dell’emigrazione Italiana», n.3, 2007, pp. 79-95.
[41] S. Gesù, Cinema ed emigrazione, in L’emigrazione italiana transoceanica tra Otto e Novecento e la Storia delle comunità derivate, vol. II,Trisform, Messina 2003, p. 655.
[42] Si rimanda per numeri e processo dal 2006 al 2024 alla tabella 1.
[43] T. Filippone, Quei quarantamila siciliani emigrati oltre lo Stretto. La Germania rimane la prima meta, «la Repubblica», 18 novembre 2024.
[44] E. Pichler, Nuova mobilità o tradizionale emigrazione del lavoro? L’immigrazione Italiana in Germania ed il Covid, intervento al Convegno “ Le migrazioni degli italiani”, Accademia dei Lincei, 29 ottobre 2020.
[45] E. Pichler, Passato, presente e futuro della comunità italiana in Germania, «Dialoghi Mediterranei», gennaio 2022.
Focus: 70 anni dagli accordi bilaterali tra Italia e Germania
Articoli correlati:
Verso una memoria condivisa. Conversazione con Gino Carmine Chiellino – Corriere d’Italia