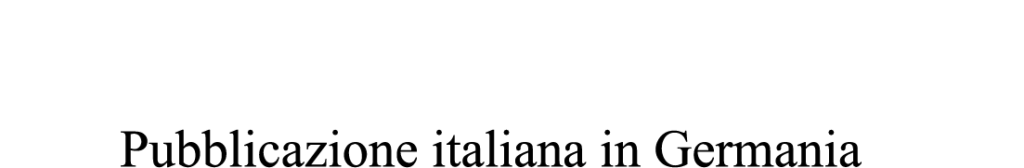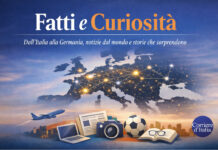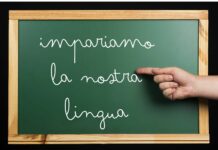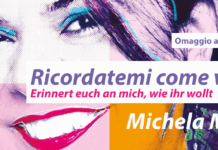Contro lo storicismo a favore del popolo di Dio senza essere modernisti
Spesso la teoria che si intende criticare diventa lo strumento d’interpretazione e di attuazione di quello che che si tende a difendere; ed ancora più di frequente in tal modo si favorisce quello che si vuole svalutare. In modo subdolo, si direbbe per ironia della storia, quello che si è respinto riemergerà come linfa vitale a sostegno di principi ritenuti assoluti da parte di chi se ne fece paladino, perfino anche contro chi si provava a mediare. E questo ci pare sia avvenuto sul noto quanto triste caso del Modernismo teologico, tacciato dal Cattolicesimo ufficiale come un’eresia, sol perché vari teologi di tutto il mondo, anche ecclesiastici, fra gli anni ’90 dell’800 ed il primo decennio del’900, vollero rileggere il messaggio cristiano alla luce dei mutamenti sociali dell’epoca.
In particolare, lo Storicismo positivista si poneva a rileggere ed a riproporre i valori classici della Fede, a reinterpretare razionalmente la bibbia, a superare la filosofia Tomista, a riavvicinare la religione ai gravi problemi delle classi sociali subalterne, soprattutto a passare dal Cristo mitico al Cristo storico, immettendo un po‘ di materialismo nel Vangelo, destrutturando il testo e sulla scia di Hegel per ricostruire il contesto. Nella Germania imperiale, dopo la famosa legislazione bismarckiana – la c. d. Kulturkampf – la battaglia culturale laica si contrappose alla chiesa cattolica, per ridefinire i limiti della politica centrista popolare e spiccatamente anticlericale, per esempio la legislazione sulla libertà dell’insegnamento religioso ai ministri di culto affidando allo Stato la loro vigilanza fin dal 1872. Tuttavia, un giovane sacerdote cattolico di Friburgo, Hermann Schell, già nel 1873, nell’esercizio dell’attività pastorale, si avvicinò alla corrente dell’epoca progressista ed alla predicazione dell’inglese cardinale Newman, passato al Cattolicesimo dal Protestantesimo anglicano che come quello Luterano sembrava essersi appiattito su aspetti devozionali e formali, mentre la realtà sociale connessa allo sviluppo industriale nascente apriva nuovi scenari pastorali nelle città operaie, come il nostro Don Bosco e poi Giuseppe Toniolo sperimentarono quasi contemporaneamente nel triangolo industriale lombardo-piemontese.
Una frazione di cattolici prese le parti governative, opponendosi al Vaticano Primo che aveva dogmatizzato l’infallibilità del Papa, aveva riaperto il dialogo con i luterani, ed avviato pratiche di fatto scismatiche. Era il caso dei Vecchi Cattolici del presbitero Döllinger, la cui scuola storicista andò a svilupparsi a Würzburg, poco distante dalla Monaco fedelissima a Papa Pio IX. Piuttosto un altro gruppo di giovani presbiteri, lontano da tentazioni sincretiste coi protestanti e per nulla vicini alla borghesia conservatrice calvinista e Guglielmina, erano capitanati proprio da Hermann. Schell ipotizzò un punto di mediazione fra la Chiesa, il progresso scientifico e la difesa delle classi più deboli esposte all’attacco del Capitalismo, più legato alla domanda di profitto individuale ma a discapito del Bene Comune. Il pensiero di Hermann ritornava alle radici tomiste di armonia tra fede e scienza, dove la teologia non era vista come un freno al progresso, quanto e piuttosto l’ancella della evoluzione scientifica, cosa che avrebbe certamente giovato alla elevazione sociale e culturale delle classi lavorative e che avrebbe reso politicamente utile un’alleanza sociale tra la piccola borghesia ed i lavoratori, in uno spirito di leale collaborazione fra tutte le classi sociali. Conclusioni che lo portarono nel 1897 all’insuperato saggio sul cattolicesimo come principio di progresso, dove accettava parte delle critiche dei vecchi cattolici sul papato romano, oramai volgarizzato ed isterilito
– quasi allineandosi alle parallele critiche di Nietzsche sulla morte di Dio …- auspicando però, un Nuovo Cattolicesimo, moralmente integro, ricercatore della Verità assoluta, teso alla Giustizia di Dio, con laici più colti in Teologia, storicamente capaci di un’esegesi critica delle fonti sacre, con una variante escatologica che superasse la morte, da lui intesa come un evento ineluttabile, ma che poteva essere vissuta santamente in armonia ai principi evangelici di speranza ed idonea a vincerne i limiti già lungo la vita. Codesta scuola di pensiero come si vede frutto di mediazione fra Roma e Berlino, lo portò ad esser rettore a Würzburg dal 1897, quando ebbe il favore dei professori non solo perché difese le legittime aspettative del movimento politico dei cattolici, ma anche perché segnalò da storico il ruolo ultra conservatore dei gesuiti nella Controriforma, fino a stigmatizzarli come un blocco dirigente arretrato rispetto allo sviluppo della società. Malgrado si fosse sempre opposto agli eccessi che avevano portato a conclusioni antidogmatiche, soggettiviste e dirette fortemente contro il Magistero della chiesa, tesi preferite dal teologo Tyrell e dallo storico Loisy
suoi coevi; Schell non fu immune dagli strali critici che il Sant’Uffizio gli inflisse con l’iscrizione del suo saggio nel 1907, all’indice dei libri proibiti su ordine di Papa Pio X, che com’è noto, con l’enciclica Pascendi Dominici Gregis del 1907 chiuse ogni forma di dialogo col mondo di inizio secolo, il Modernismo Cattolico, appunto. Se il braccio armato della riforma cattolica contro il protestantesimo, erano stati il mondo laico delle congregazioni religiose, l’ordinamento dei gesuiti ed il Codice Canonico del Concilio di Trento ‚500; nel primo decennio del ‚900 si adoperò all’uopo anche l’appena fondata Azione Cattolica, nonché l’applicazione più restrittiva dell’Indice dei libri proibiti ed il giuramento antimodernista rivolto a tutti i professori ed a tutti i laureandi delle Università cattoliche, dove veniva vietata ogni critica al concetto di miracolo e si negava qualsiasi adattamento del Dogma di fronte al mutare dei tempi. Erano anni molto duri in Germania ed in Europa per i cattolici, fra Pio X e Benedetto XV,sullo scoccare della Grande Guerra.
Erano i Pontefici che diedero filo da torcere ai docenti progressisti in Germania e nelle Università cattoliche, mentre nelle diocesi le Visite Apostoliche – o meglio le Ispezioni – provocarono reazioni non dissimili al nicodemismo cattolico di fronte all’inquisizione spagnola del ‚600. Il Cardinale Ferrari di Milano, i teologici laici Buonaiuti e Murri, subirono persecuzioni per il loro insegnamento. Eppure, una parte dei presbiteri e dei vescovi resistette adoperando l’arma della mediazione culturale e della pazienza, per impedire che l’odiato storicismo teologico, parente stretto del modernismo cattolico e fratello del relativismo religioso, tramutasse la fede cattolica in un new age piuttosto avanzato. Mediazioni culturali, ovvero aperture moderate al mondo che andava mutando nelle culture puramente scientifiche. La cui evidente secolarità non doveva però tracimare in una valanga di negoziabilità di Valori, che ebbe già prima di Montini – e delle scuole teologiche conciliari europee del secondo dopoguerra – valorosi adepti nella sede vescovile del Sud d’Italia, a cominciare da noi la figura di Giovanni Blandini, vescovo di Noto dal 1875 al 1913, anno della sua morte.
Divenuto Vescovo a 43 anni dopo un ventennio alternando studi di teologia, diritto e filosofia a Catania, esplicò un’intensa attività pastorale tutela dei lavoratori di Palagonia, sua città natale, dove favorì l’associazionismo sindacale. Come il confratello Luigi Sturzo per Caltagirone, partecipò al Consiglio Comunale di quella città, esercitando quella funzione per ben 30 anni. E quando il cardinale Dusmet di Catania lo nominò vescovo a Noto, ben presto da quell’alta carica rivendicò l’autonomia del Clero dai controlli controlli del Governo, ribadendo però – come aveva fatto lo Schell – l’obbedienza al Papa. Abbandonò qualsiasi controversia ermeneutica biblica, ben sapendo che con lo spirito laicista unico terreno d’incontro era la realtà sociale, attivando il movimento politico dei cattolici. Nel 1903 va segnalata una tappa essenziale della sua feconda vita pastorale, l’elaborazione di linee guida per l’assemblea dei Vescovi Siciliani a tutela dei lavoratori nelle campagne e soprattutto contro le pretese dei campieri che schiavizzavano il bracciantato. Nel 2003 una pattuglia di studiosi locali hanno avuto il coraggio di riparlarne, come quando poco dopo un teologo redenzionista tedesco, Otto Weiss, ha riaperto il caso di Hermann Schell, maestro di Karl Barth, di Rahner e Guardini, che tanta parte hanno avuto e continuano ad avere nella pastorale della Chiesa contemporanea.