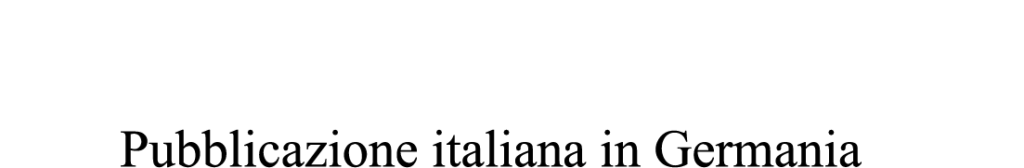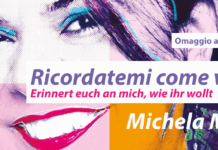Don Giovanni Ferro: dopo 44 anni in Germania il ritorno in Italia, tra memoria, sfide e nuove consapevolezze
Don Giovanni Ferro, sacerdote e giornalista, ha trascorso 44 anni in Germania come missionario al fianco delle comunità italiane, ricoprendo anche il ruolo di direttore del Corriere d’Italia. Dalla fine del 2022 è rientrato definitivamente in patria e oggi ci racconta la sua esperienza, condividendo impressioni e riflessioni su come ha ritrovato l’Italia dopo tanti anni vissuti all’estero.
Quando hai varcato la frontiera per tornare definitivamente in Italia, quali emozioni e pensieri ti hanno accompagnato?
Da quel viaggio ho il ricordo di aver avuto di me la sensazione come di uno che fa il tragitto di sempre, ma stavolta per non ritornarci più. Finis. Niente più Germania, ma anche niente l’Italia che era stata la mia. Varcavo la frontiera verso l’ultimo quarto della mia vita. Ero carico di robe da trasloco nel trambusto di quanto mi portavo o regalavo. Solo dopo cominciai a sentire meglio che della mia terra avrei ignorato moltissimo.
Dopo tanti anni all’estero, come hai vissuto il ritorno: ti sei sentito subito “a casa” o è stato un processo più complesso?
Il tornare in patria non l’ho trovato difficile, dato che furono le difficoltà stesse a ritrovarmi e alle quali mi ci ero preparato. Sui ritorni in terra d’origine conoscevo tutta una raccolta di esperienze e tanto giornalismo ben ragionato su delusioni, stress emotivo e tempi lunghi di adattamento con imprevisti. Lo sapevo da esperienze in cui io stesso avevo data una mano ad altri in situazioni del partire all’estero e poi nel ritornare. Sapevo che l’Italia mia, quella che lasciai, avrebbe continuato a mutare in mia assenza. Ora, se guardo indietro ai 44 anni di servizio all’estero nella realtà dell’emigrare, ci aggiungo il precedente di cinque anni prima, di quando cioè praticavo sovente una Germania che in realtà era fatta di due: la Bundesrepublik e la DDR ad Est. Le novità che mi aspettavano da oriundo dal Nord Est italiano, il Friuli, mia piccola patria con due lingue madri e altro ai confini con Austria e allora Jugoslavia, da secoli terra di migranti, mi avevano allenato alle complessità del vivere fra diversi. Il Paese che lasciavo nei primi anni settanta non si sarebbe di certo fermato a recuperarmi per il mio ritorno. Insomma restai ancora un po‘ straniero, stavolta a casa mia.
Quali sono stati gli ostacoli più duri da affrontare, grandi o piccoli, nel reinserirti nella vita quotidiana italiana?
Certamente mi confrontai con differenze in cose di sostanza o in piccolezze, anche con inedito disagio, nel pubblico amministrativo e in regole italianamente ignote per me, venute col tempo a mia insaputa. Arrivando per restarci, scoprivo dettagli di regolamenti e procedure che sentivo anche strane. Tuttavia decisi di non indignarmi, un po‘ per rispetto d’amor patrio, un po‘ per non dar fastidio ad altri che già vivevano dei loro disagi nazionali. Ero consapevole che anche noi italiani stando all’estero, soffriamo di disamore e rabbie per dei servizi in madrepatria che sovente ci scoraggiano. Un aspetto emblematico lo notai subito per la lingua italiana che ancora io parlavo, o scrivevo, con abitudini che mi ero portata dietro congelate in tono e vocabolario dal mio liceo classico in anni sessanta, quando il parlar bello era un’eleganza dell’anima, un prestigio d’arte e cultura che da millenni ci qualifica davanti al mondo intero. Notavo invece che l’italiano aggiornato da benessere di massa, da radiotelevisioni, fatto di anglicismi e modernità ovunque, anche in gente colta e di alto rango mi infastidiva, anche per le sgrammaticature. Per non dire dei termini sfacciatissimi, assai volgari, che mi scandalizzavano. Dico di quel parlar violento ormai diffusissimo, che mi arrivava come un sintomo di nevrosi del sesso, un’ossessione da eros degradato a schifezza. Ben altro che nel pudore di qualche decennio fa. Non ero abituato a questo in altre lingue d’Europa. Le baruffe da battaglia poi in TV con urla incrociate fra sordi mi scandalizzarono non poco. Non ero addomesticato alle TV imperanti, a decine di radio schiamazzanti, per non parlare dei “socials”,
Tornando, hai trovato una mentalità cambiata: quali aspetti della società italiana ti hanno sorpreso di più, in positivo o in negativo?
Vengo ai fatti. Affrontai nuove procedure nel civico, nel burocratico telefonico ovunque. Cercai di tener duro, superando tappe di settimane e mesi per aggiornarmi sul procedere. E devo dire che me la spuntai. Fu scoraggiante soprattutto la cosa con il medico di base e il sistema sanitario nazionale, di cui ho bisogno per sopravvivenza. Una maratona durata un anno fu poi la trasformazione della mia patente di guida tedesca in italiana. Ricordo costi che sapevo sarebbero stati assurdi fuori d’Italia, come le comparse davanti a ripetute commissioni mediche della motorizzazione civile, dal sapore da tribunale clinico. Difficile fu il recupero della mia cittadinanza italiana andata dispersa dall’Aire dalla quale del resto mi ero congedato. Neanche la residenza nel mio piccolo appartamento di proprietà era sopravvissuta negli anni, e fu stress con il Catasto per recuperarmela. Un tormento fiscale fu la mia nuova collocazione nella dichiarazione dei redditi, dopo che la Germania mi era stata paradiso fiscale grazie a residenza di pensionato all’estero e al bonus dal Finanzamt germanico che conosceva bene che poveri e sciagurati d’ogni genere erano la grande famiglia a mio carico. Anche la buona classe di merito per la mia indenne assicurazione auto, non mi fu riconosciuta, e fui retrocesso alla classe 14, che significò la mia ricaduta a diciottenne principiante – altro che Unione Europea. Conobbi altre fiscalità che tralascio per non scoraggiare qualche interessato alla cosa.
Guardando al passato, quali trasformazioni ti hanno colpito maggiormente nello stile di vita e nelle abitudini del Paese?
Certo l’Italia di decenni andati, non era più quella che mi salutava. Quando l’avevo lasciata, la parola “computer”, per fare un esempio, era ancora cosa di élites professionali, di ditte e centri di avanguardia, non roba di gente qualsiasi. Il “telefonino” poi era un aggeggio di persone rare piuttosto ignoto, ingombrante, di commessi viaggiatori e tecnici: Si sarebbe divulgato dagli anni novanta. Nel mio Friuli Venezia Giulia, regione Autonomia, nel frattempo la viabilità si era perfino rivoluzionata e rispetto ad altre zone era divenuta di eccellenza anche grazie a progetti di ricostruzione dopo il terremoto che stravolse paesi e centri urbani. La nostra terra un tempo di migranti si era internazionalizzata. Al punto che all’inizio io viaggiai spaesandomi continuamente. La gente era altra e l’anarchia intollerante su strada lo testimoniava. All’occhio di un antropologo, io pensai, i modi e linguaggi erano diventati qualcos’altro a suon di smart e internet universali.
Cosa ti è mancato della Germania e, allo stesso tempo, quali aspetti dell’Italia ti hanno confortato al ritorno?
Chiaramente cose buone tedesche mi sarebbero mancate, e mi imposi la pazienza. Altre bontà italiane, del resto, mi confortarono. Ma per me, figlio di guerra e subito dopo, notai che cominciava a finire un resto di romanticismo nel mondo della grande e piccola musica anche popolare e nel canto, una eccellenza di cose importanti per la mia anima, che in terra tedesca si era ritrovata in un paradiso terrestre per queste cose. Quindi mi sono sentito orfano del mio umus culturale che avevo goduto in una Germania capitale del mondo come mecca per gente musicale da ovunque. Ancora vedo e sento l’ignoranza – o dimenticanza – nel costume di massa di un’Italia che dal Rinascimento fino all’Ottocento era stata maestra per musica e canto in Europa. E ora qui penso che ciò sia una cifra indicativa di impoverimento estetico che è presagio di altre decadenze nel nostro paese: ce lo dice gente che indovina un cattivo futuro indagando in certe modernità che sono barbariche.
Parlando di servizi pubblici, come metteresti a confronto l’Italia di oggi con la Germania che hai conosciuto?
Quello di servizi è un termine che dice di tante situazioni della vita pubblica. Posso spiegare così: già il Regno d’Italia fattosi Repubblica, si era strutturato a modo suo con altre tradizioni di governo e questo l’ho capito in tanti momenti di Germania, passata per ben altra storia. Mi sentii come fra due mondi cresciuti diversi sulle stesse cose. Così che poi rimpatriandomi imparai a rassegnarmi dicendo anch’io: “Che ci puoi fare, questa è l’Italia, fatta così”. Alla burocrazia tedesca mi ero adeguato. A quella italiana non mi sono ancora rassegnato e accetto di tener duro fino al termine dei miei giorni. Nel mondo tedesco ebbi a che fare normalmente con personale competente e gentile in tante procedure, ma spesso in stile solo formale. Anche in Italia continuo a trovare gente competente che magari fa il meglio possibile fra assurdità burocratiche infinite. Ma qui ora incontro personale che è gentile e di cordialità autentica, ma non per professione ma per natura: qui il ”bel paese” Italia ha una umanità per cuore aperto e fantasia che ci salva da certi inghippi. Non sono io a dire che il sistema sanitario italiano non è quello tedesco, o svizzero, o… Dietro la situazione si intuisce che la politica del paese ha lavorato sia bene che assai male fra pubblico e privato. Il cosiddetto servizio privato è stato anche per me una sciagura e perfino anche un salvataggio. Ho capito che ci sarebbe molto da rivoluzionare, ma l’arte dell’improvvisazione e l’arrangiarsi in qualche modo è un recupero che qui aiuta la gente nei guai a sopravvivere. Qui il popolo non ricco di soldi, di contatti, di raccomandazioni, anche di mafie… se la cava come può. Parlando invece di “sistema tedesco”, una persona può dire solo di sé: in Germania io ho fatto esperienze tristi, come ho potuto anche godere di risurrezione clinica da buona Bundesrepublik di eccellenza. D’altronde in un paio d’anni sono mutate le cose in tutta Europa, in sicurezza pubblica in crisi, senza pace dentro le città, con masse migratorie destabilizzanti. I miei anni tedeschi dal 1974 fino 2000 sono quelli che ricordo con pace. Gli anni di dopo li sentivo già diventare diversi e non li ho in nostalgia. Anche la gioventù italiana che punta ora verso mete in Europa vive di considerazioni diverse di quelle che furono mie decenni or sono.
Anche la dimensione religiosa e spirituale l’hai vissuta in modi diversi tra i due Paesi: cosa hai portato con te di quella esperienza?
Per ciò che mi tocca come cristiano cattolico, sento ora che mi manca la vicinanza col mondo protestante centro-nordeuropeo e delle chiese Ortodosse là presenti, prossimità queste che hanno dato respiro al mio essere come sono. In tante realtà di Chiesa italiane che ho ritrovate in patria, ora vedo un diffuso senso del proprio campanile, una provincialità di costumi chiusi al resto del mondo e davanti al futuro. Qui si dorme spesso su vecchi allori. Anche gente di cultura è ferma a vecchie glorie, mentre la religiosità d’un tempo in Europa evapora con velocità che non era prevista. Ho vissuto in diverse Comunità di Missioni Cattoliche Italiane in Germania, da giovane sacerdote in Ruhr Gebiet, Essen e Bochum, in tempi di tanta frequenza e un’italianità di iniziative che eccelleva di associazionismo. Poi vissi in area Francoforte, ben altra realtà, nell’anonimità urbana fatta di distanze, poi fui in Niedersachsen, mondo quasi “scandinavo” e protestante, nella dispersione di connazionali.
Hai ancora legami vivi con la Germania, con persone o comunità a cui sei rimasto legato?
Il massimo dei rapporti che al momento conservo vivi fu in Arcidiocesi di Colonia, la metropoli italiana più Nord delle Alpi, come qualcuno sorride dicendo. In qualche modo là sono ancora legato per emergenze che ho sostenuto e dalle quali non mi sono ancora congedato. Qui in Italia, vedendo insieme le varie esperienze, penso e vivo perplesso su tante dimensioni di Chiesa costruitesi nei secoli e che rispetto, ma personalmente io punto su una spiritualità colta in diretta dal Vangelo che è ancora più antico. Lo imparai in emigrazione, perdendo cose di tradizione per andare alla sostanza
Con la tua esperienza, quale consiglio daresti a chi oggi sceglie di emigrare o a chi pensa di rientrare in patria?
A chi si è arricchito o ben sistemato in Germania, all’estero ovunque, consiglierei di dimenticare i disagi degli inizi, e di non farsene un monumento di se stessi da mostrare a chi non c’entra. E invece di saper dire grazie a persone e momenti che ha dato loro la provvidenza tedesca. Riconoscenza non è molto in uso, ovunque, ma in questo caso è d’obbligo. A chi invece torna in patria senza aver raccolto grande fortuna, consiglierei di perdonare a sé stesso, o a sé stessa, l’impulso a partire magari senza buona preparazione per il mondo tedesco, senza dimenticare che il detto “chi cerca trova”, non vale sempre. Per chi poi in questi ultimissimi tempi, anche per esperienze brevi di studio tipo Erasmus, va detto che la propria terra lasciata non resterà più la stessa. Anche le storie del cuore, ad esempio, possono preparare destini mai programmati. Allora non si darà fastidio ad altri con eventuali lamentele e nostalgia del perduto.
In conclusione, se ripensi al tuo cammino tra Germania e Italia, come si sono intrecciati nella tua vita spiritualità e servizio?.
In situazioni le più diverse in Germania in spazi religiosi o di nessuna religiosità, ho allargato a distanza le mie scarne conoscenze sulle Italie fra Nord, Centro, Sud e Isole con dati che io, da “polentone” del norditaliano, ignoravo. Ho vissuto da sacerdote, un tempo anche da giornalista, da assistente sociale e psicologo assai coinvolto fra desolati e poveri di ogni genere. In questo ultimo tempo di transito fra Deutschland e Italia un’idea di sintesi mi insegue: la nostra Europa, pure nelle diversità, sta insieme finendo di essere ciò che noi giovani negli anni Sessanta immaginavamo in epoca “sessantotto” Essere di Italia o di Germania, ora fa sempre meno differenza fra adolescenti e giovani. Siccome viviamo da cittadini dello stesso villaggio globale di informazione, che non ha pause giorno e notte. Anche il parlare di Emigrazione ed emigranti ora è diverso anche dal punto di vita religioso, dimensione che finora ha fatto molto da connettivo di comunità italiane di Germania – come io ho vissuto nel servizio all’Italianità fuori patria. Ora tante cose stanno evolvendo ad alta velocità.