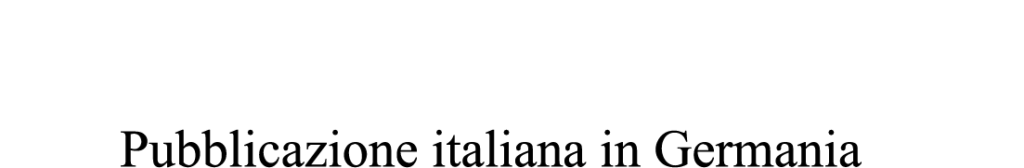Alle 7:35 del 21 aprile, il mondo ha perso una voce forte, limpida, spesso scomoda ma sempre ispirata dal Vangelo: Papa Francesco è morto. L’annuncio è giunto dopo poche ore per voce del cardinale Kevin Farrell, in un messaggio breve, solenne e carico di commozione:
«Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre».
L’eredità di un pastore venuto “dalla fine del mondo”
Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da una famiglia di origini piemontesi, era diventato l’arcivescovo del popolo prima ancora di salire al soglio di Pietro. Gesuita, figlio spirituale di Ignazio di Loyola, per lui la fede non è mai stata solo rito, ma vita quotidiana, concretezza, servizio. Il 13 marzo 2013, con le dimissioni shock di Benedetto XVI ancora nell’aria, venne eletto Papa, primo del continente americano, primo gesuita, primo ad aver scelto il nome di Francesco, il poverello di Assisi. Un nome-programma.
«Fratelli e sorelle, buonasera» — esordì affacciandosi quella sera sul balcone della Basilica Vaticana. Da subito si capì che sarebbe stato un Papa diverso. Non avrebbe occupato palazzi, non avrebbe indossato ermellini o croci d’oro. Scelse Casa Santa Marta, rinunciò agli onori e prese su di sé il peso della testimonianza.
Una Chiesa “ospedale da campo”
Papa Francesco ha restituito centralità al Vangelo delle Beatitudini, facendo della misericordia e dell’inclusione il cuore pulsante del suo pontificato. Ha parlato alle periferie geografiche ed esistenziali, ha lavato i piedi ai carcerati e ai migranti, ha toccato le piaghe dell’umanità senza paura né ipocrisie.
Non si è tirato indietro davanti ai mali del mondo. Ha denunciato lo scandalo della povertà, le disuguaglianze economiche, l’emergenza climatica, l’ipocrisia del potere. È entrato nei campi profughi, ha pregato nei luoghi della guerra, ha abbracciato il mondo musulmano e l’ebraismo in gesti di fratellanza autentica.
E ha riformato, non solo con le parole. Le sue riforme della Curia romana, delle finanze vaticane, l’apertura alle donne in ruoli apicali, la trasparenza nei processi canonici hanno messo in discussione meccanismi secolari, suscitando anche resistenze interne. Ma Papa Francesco ha continuato, passo dopo passo, con quella parresia — il parlare franco del Vangelo — che lo ha sempre caratterizzato.
Il tempo del lutto
Il Vaticano è entrato in una fase solenne: la sede vacante.
Da domani la salma sarà esposta in San Pietro per tre giorni alla venerazione dei fedeli. I funerali si terranno sabato 26 aprile alle 10, l’inizio del conclave sarà tra il 5 e il 10 maggio.
Dopo le esequie, si apriranno i novendiali, le nove giornate di preghiera in suffragio. Il Conclave per l’elezione del nuovo Papa si terrà tra 15 e 20 giorni, ma potrebbe iniziare anche prima se i cardinali elettori saranno già a Roma.
Francesco lascia una Chiesa aperta al dialogo, protesa verso le ferite dell’umanità. L’80% dei cardinali che entreranno in Conclave sono stati nominati da lui. Uomini provenienti da ogni parte del mondo, spesso sconosciuti tra loro, ma scelti per la loro pastorale concreta, la loro vicinanza alla gente, la loro testimonianza silenziosa.
Il suo pontificato in numeri e simboli
11 anni di pontificato (2013–2025)
67 paesi visitati nei cinque continenti
4 encicliche tra cui Laudato si’, sul creato, e Fratelli tutti, sull’amicizia sociale
7 esortazioni apostoliche, tra cui Evangelii gaudium, Amoris laetitia, Querida Amazonia
6 Assemblee sinodali, con una partecipazione crescente del laicato
Prima nomina femminile alla guida di un dicastero vaticano
Incontro storico con il Patriarca Kirill (2016), il primo nella storia tra un Papa e il capo della Chiesa ortodossa russa
Accordo provvisorio con la Cina per la nomina dei vescovi
Riforma organica della Curia romana, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium
Un testimone del tempo
Papa Francesco ha vissuto con accanto per quasi un decennio il predecessore Benedetto XVI, in un’inedita coabitazione all’interno del Vaticano. Dopo la morte di Ratzinger nel dicembre 2022, aveva continuato il suo cammino con crescente fragilità fisica ma immutato vigore spirituale.
È stato il Papa che ha rifiutato le etichette, che ha stretto mani e cuori, che ha chiamato “fratelli” tutti. È stato il Papa che ha chiesto “chi sono io per giudicare?” e che ha restituito speranza a molti che si erano allontanati dalla fede.
Oggi il mondo piange, ma la sua eredità spirituale non muore. È viva nei gesti di chi accoglie, di chi perdona, di chi lotta per la giustizia.
Papa Francesco non lascia solo un vuoto. Lascia un cammino.