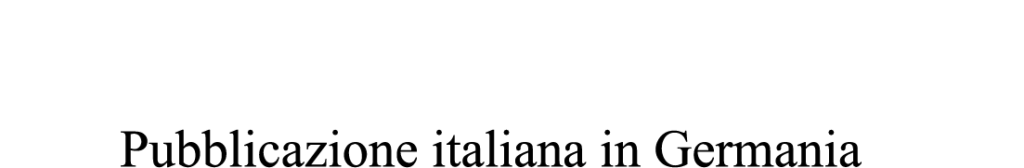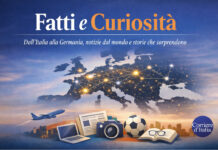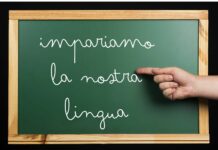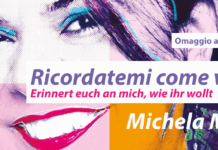La condanna di Giuseppe M. e le occasioni mancate del maxiprocesso di Duisburg
È una condanna pesante quella inflitta mercoledì scorso a Giuseppe M., 39 anni, ristoratore di Wesseling, cittadina lungo il Reno tra Colonia e Bonn: 11 anni e 3 mesi di carcere per traffico internazionale di cocaina e appartenenza a un’associazione mafiosa. La sua figura emerge come quella del capo di un gruppo criminale ramificato anche oltre i confini tedeschi. Ma, paradossalmente, è anche l’unico dei 14 imputati del maxiprocesso di Duisburg ad aver ricevuto una condanna per associazione mafiosa.
Un fatto che solleva più di un interrogativo, e che lascia un retrogusto amaro in una delle indagini più ambiziose mai condotte contro la criminalità organizzata in Germania.
Tutto ha inizio nel 2018 con l’operazione Pollino, una delle più vaste azioni coordinate a livello europeo contro la ’ndrangheta. Centinaia di agenti operativi in Germania, Italia, Belgio e Paesi Bassi. Il cuore dell’inchiesta batteva a Duisburg, città già segnata dal sangue nella strage di Ferragosto del 2007, quando sei uomini vennero uccisi davanti a un ristorante italiano. Un segnale di quanto radicate fossero — e siano ancora — le infiltrazioni della criminalità calabrese in Germania.
La procura di Duisburg aveva un obiettivo chiaro: dimostrare che il traffico internazionale di cocaina che passava per porti come quello di Rotterdam e si distribuiva in tutta Europa, fosse diretto da un’articolazione locale della ‘ndrangheta con sede a San Luca, in Calabria, ma ramificata e operativa anche in Germania.
Il processo si è aperto nell’autunno del 2020 con grande clamore mediatico. Per quattro anni si sono susseguite udienze, interrogatori, analisi di intercettazioni, ricostruzioni di movimenti finanziari, sequestri e testimonianze. La procura tedesca voleva fare scuola: dimostrare che la mafia calabrese non è solo un problema italiano, ma una presenza organizzata e attiva in Germania, capace di infiltrarsi nel tessuto economico attraverso attività apparentemente lecite — ristoranti, pizzerie, bar — e nel contempo gestire traffici illeciti su scala industriale.
Eppure, il risultato finale non ha soddisfatto nemmeno chi ha lavorato all’inchiesta. Solo una condanna su quattordici ha riconosciuto l’associazione mafiosa. Gli altri 13 imputati, tra cui alcuni considerati figure chiave, sono stati condannati sì per traffico di droga, truffa e altri reati gravi — uno di loro, ad esempio, ha ricevuto 8 anni e 4 mesi — ma nessun legame diretto con la ‘ndrangheta è stato formalmente riconosciuto dal tribunale, per insufficienza di prove.
Durante il processo, tutti gli imputati hanno mantenuto un rigoroso silenzio sull’argomento mafia. Nessuno ha ammesso legami con l’organizzazione, nessuno ha parlato di giuramenti, rituali, gerarchie. Senza pentiti, senza collaboratori di giustizia, le prove raccolte — per quanto consistenti sul piano investigativo — non sono bastate a costruire il mosaico completo in sede giudiziaria.
Una situazione che ricorda da vicino molte inchieste italiane degli anni ’80 e ’90, quando la difficoltà nel dimostrare l’esistenza dell’organizzazione criminale era spesso legata proprio all’omertà e alla mancanza di testimoni interni.
La figura di Giuseppe M. diventa allora simbolica. Da imprenditore della ristorazione a presunto boss locale della ’ndrangheta in Germania, è l’unico a pagare anche per l’associazione mafiosa. L’accusa ha convinto i giudici che lui fosse l’anello di congiunzione tra il traffico di cocaina e la struttura criminale di San Luca. Ma la sua è una condanna isolata, simbolica più che sistemica.
E questo è il punto dolente: un maxiprocesso con 14 imputati, durato anni, con centinaia di agenti coinvolti, si chiude senza che la giustizia tedesca abbia realmente messo nero su bianco l’esistenza di un’organizzazione mafiosa stabile e radicata sul territorio.
La procura non ha ancora commentato ufficialmente gli esiti del processo, ma fonti vicine alle indagini non nascondono la frustrazione. L’ambizione era alta: mostrare che la Germania non è solo terra di passaggio o rifugio per latitanti, ma parte attiva nelle dinamiche mafiose globali. Il verdetto finale, però, sembra ridimensionare quella narrazione.
Si tratta forse di un’occasione mancata, che rischia di indebolire gli strumenti giuridici a disposizione di chi combatte la mafia oltreconfine. Oppure, più ottimisticamente, può essere letto come un primo passo, un precedente importante che potrà essere utilizzato in futuro per incardinare meglio i reati associativi nei tribunali tedeschi.
Una cosa è certa: la criminalità organizzata non si ferma davanti ai confini nazionali, e nemmeno la giustizia dovrebbe farlo. Ma affinché la lotta sia davvero efficace, serve un cambio di passo. Servono norme europee più armonizzate, una cooperazione più stretta tra magistrature, e — soprattutto — una maggiore consapevolezza pubblica che la mafia non è un problema lontano, ma un fenomeno presente anche nel cuore dell’Europa.
Il maxiprocesso di Duisburg si chiude con una condanna importante, ma anche con molte ombre. E con la netta sensazione che la ’ndrangheta, ancora una volta, sia riuscita a rimanere nell’ombra.