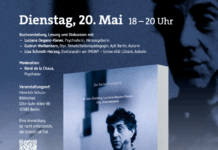Forse ha ragione chi sostiene che, in Italia, i cambiamenti (“riforme”) non si devono fare: solitamente peggiorano l’esistente. E l’esistenza.
Basti valutare con un po’ di freddezza l’evoluzione della tassazione sugli immobili nel corso degli ultimi anni. C’era l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Onestamente, era ben strutturata, con esenzioni estese sulle prima casa e una tassazione chiara sugli altri immobili. Aveva una sua variabilità che consentiva agli amministratori locali di “dosarla” a seconda delle esigenze della comunità locale, che godeva dei frutti di questa imposizione: l’unica veramente “federalista”.
Ma su essa s’accese il dibattito politico: troppe tasse, aboliamo questa. Il valore era simbolico, contro uno logica giusta: tassare gli immobili, le rendite, è meglio che tassare il lavoro. Ma se il lavoro non si può o non si vuole detassare – si disse – allora via le imposte dagli immobili. E i Comuni? Vedremo.
E da lì, la scelta s’è evoluta in complicazione, e quindi in farsa. Abolire l’Ici per introdurre l’Imu (imposta municipale unica) – ad opera dello stesso governo Berlusconi – è apparsa alla fine come una mossa gattopardesca: cambiare tutto per non cambiare nulla. Invece no: l’Imu è stata concepita in modo peggiore rispetto alla semplice Ici, con una condivisione degli introiti tra Stato e Comuni, con un meccanismo complesso di calcolo che cancellava certe detrazioni sulle prime case, e – quel che è incredibile – con un sostanziale aggravio fiscale. Si sono “abbassate” le tasse per poi “alzarle”.
Tutto bene dunque? Macché. La stessa parte politica ha poi fatto fuoco e fiamme contro l’Imu da lei introdotta. Il governo Letta può campare se sparisce l’Imu. Ma i Comuni? Vedremo.
E da lì un balletto che ha attraversato l’intero 2013. Via la prima rata Imu sulla prima casa; no, sospesa; rimane l’Imu su tutto il resto. Sospesa? No, tolta. Ma la seconda, l’acconto finale? Verrà sospeso, no: tolto. Sospeso o tolto a seconda dei giorni. Ma se manca l’Imu, mancano soldi allo Stato e ai Comuni che non sanno più come fare i propri bilanci. Che si fa? Vedremo.
Intanto cancelliamo ‘sto acronimo e ne introduciamo altri: Trise (tributo sui servizi comunali) che si divide in Tari (tassa sui rifiuti) e Tasi (tassa sui servizi indivisibili). Complicare il semplice: su questo siamo bravissimi. Ma pure lorsignori si sono accorti che la complicazione sarebbe stata eccessiva, tra aliquote differenziate, date di scadenza, rate da pagare, modifiche a livello di ogni Comune, sovrapposizioni e casi particolari… Si è fatto notare ai legislatori che anche un pensionato con la sua unica casa avrebbe dovuto consultare un commercialista per capire quanto e quando pagare.
Semplifichiamo, allora: facciamo il Tuc, tributo unico comunale (cioè l’Ici). Ma siccome la sigla ricordava più un biscotto che una tassa, via il Tuc e largo alla Iuc, imposta unica comunale. Cioè l’Ici. Ma siccome non si può tornare a ciò che era semplice e chiaro, questa Iuc verrà opportunamente congegnata per raggiungere due obiettivi: pagare più di prima, pagare facendo più fatica di prima.
Direte: noi italiani siamo così. Già, ma ora andiamo a spiegarlo agli investitori stranieri, che si rifiutano di comprare immobili in Italia, riversando miliardi di euro in Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Stati Uniti, ovunque meno che qui. Come si fa a pianificare un acquisto multimilionario (una catena di hotel, un centro commerciale, una palazzina di uffici) non sapendo quale sarà il carico fiscale da affrontare?
Ce lo chiedono, ce lo chiediamo. Ma risposta non c’è, o forse chi lo sa…