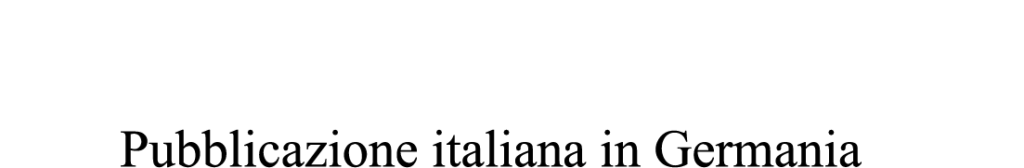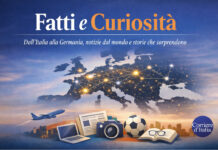Sanità in crisi, rincari ovunque – e il salario minimo non basta a proteggere i più deboli
Dal 1° luglio 2025 i cittadini tedeschi e non solo, devono prepararsi a una raffica di aumenti: dalle pensioni al costo della sanità, passando per le spedizioni internazionali, i contributi supplementari delle casse malattia e il tanto discusso aumento del salario minimo. Dietro alcuni provvedimenti apparentemente positivi si nascondono dinamiche controverse, che sollevano interrogativi sull’equità del sistema. Mentre le entrate dello Stato crescono, molti lavoratori e pensionati faticano a vedere benefici reali.
Sanità pubblica: buco da 6,2 miliardi e contributi in salita
Il sistema dell’assicurazione sanitaria obbligatoria (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV) è in profonda crisi. Il disavanzo stimato per il 2024 è di 6,2 miliardi di euro, nonostante il sostegno federale. Il risultato? Un nuovo aumento dei contributi supplementari già da luglio 2025. Alcune casse portano l’aliquota al 2,9%, e si prevede che nel 2026 si possa superare anche il 3%. Le spese per ospedali, ambulatori e farmaci crescono vertiginosamente, mentre le entrate non tengono il passo.
Secondo Oliver Blatt, del GKV-Spitzenverband, la situazione è “più drammatica del previsto” e senza una vera riforma strutturale, l’intero sistema è a rischio sostenibilità.
Pensioni più alte, ma anche nuove tasse per molti anziani
Dal 1° luglio, le pensioni aumentano del 3,74%. Una buona notizia? Solo in parte. Questo aumento farà superare la soglia di esenzione fiscale a circa 73.000 pensionati, che saranno per la prima volta obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Anche le pensioni per i cittadini della ex DDR salgono, passando a 400 euro mensili.
Operatori sanitari: salario minimo più alto, ma resta l’ombra della carenza di personale
Sempre dal 1° luglio, aumentano i salari minimi per gli operatori nel settore dell’assistenza agli anziani:
20,50 euro l’ora per i professionisti,
17,35 euro per gli assistenti qualificati,
16,10 euro per gli assistenti generici.
Parallelamente, cambiano anche le regole per chi assiste un familiare malato a casa: un budget annuo unificato di 3.539 euro permette ora una maggiore flessibilità tra assistenza preventiva e a breve termine.
Altri rincari: dai pacchi postali alla benzina
A completare il quadro:
- DHL aumenta le spedizioni internazionali (22,49 euro per un pacco medio).
- Le stazioni Shell non offrono più prelievi di contanti per i clienti bancari.
- I deputati del Bundestag ricevono un aumento del 5,4%, arrivando a 11.834 euro al mese.
- Entro il 31 luglio 2025, i contribuenti dovranno inviare la dichiarazione dei redditi, se non assistiti da un consulente.
Un’altra informazione importante e che dal 1° gennaio 2026 il salario minimo in Germania passerà da 12,82 a 13,90 euro l’ora, per poi arrivare a 14,60 euro nel 2027. Una crescita che, a prima vista, potrebbe sembrare una buona notizia: +72% rispetto al 2015, quando il salario minimo fu introdotto a 8,50 euro. Ma se si guarda meglio, il quadro è molto meno entusiasmante.
Non tutti, anzi, la maggior parte dei lavoratori in Germania guadagna già più del minimo o non rientra nei beneficiari – pensiamo a tirocinanti, apprendisti o disoccupati di lungo corso. Per loro, questo aumento non cambia nulla.
E per chi invece è coinvolto, il rischio è quello di un classico gioco delle tre carte: lo stipendio orario sale, ma le ore di lavoro diminuiscono. Succede spesso nei mini-job: per non superare i limiti fiscali, i datori di lavoro riducono le ore. Il risultato? Lo stipendio mensile resta praticamente lo stesso, nonostante l’aumento nominale.
C’è poi il nodo della povertà. L’aumento del salario minimo viene spesso presentato come un argine al lavoro povero. Ma i numeri raccontano altro, solo il 3% di chi riceve il Bürgergeld lavora a tempo pieno. Per gli altri, il salario minimo è irrilevante. Nessun impatto reale sulla povertà strutturale, solo un’aggiunta di facciata.
Il vero beneficiario di tutto questo? Lo Stato. Circa il 40% dell’aumento viene trattenuto in tasse e contributi. Nel 2026, un lavoratore a tempo pieno guadagnerà sì 186 euro lordi in più al mese, ma ne porterà a casa solo 109. E nel 2027? Dei 306 euro in più, resteranno 178 euro netti. Secondo l’Istituto IAB, le entrate fiscali aggiuntive per lo Stato ammonteranno a diversi miliardi di euro l’anno. Altro che misura sociale.
È come se non bastasse, il 76% dei cittadini teme che l’aumento del salario minimo alimenti una nuova ondata di inflazione. E ha buoni motivi, in quanto i costi per le imprese salgono, e il rischio è che vengano scaricati su prezzi e consumatori. Per evitare tutto questo, esperti come Matthias Warneke dell’Unione dei Contribuenti chiedono una vera riforma fiscale e la fine della cosiddetta progressione a freddo, quel meccanismo per cui l’aumento degli stipendi viene rapidamente “mangiato” dall’aumento delle tasse.
In conclusione si può dire che ci sono tanti aumenti ma pochi benefici reali. Nonostante l’apparente attenzione a salari e pensioni, l’impressione diffusa è che le misure adottate finiscano per avvantaggiare lo Stato più che i cittadini. La sanità pubblica è in affanno, il costo della vita continua a salire e il salario minimo – per molti – non rappresenta una vera via d’uscita dalla precarietà.
Il rischio concreto è che a pagare il prezzo della crisi siano sempre gli stessi: i lavoratori a basso reddito, i mini-jobber, le famiglie e gli anziani.