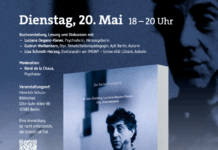Populismo e terrorismo contribuiscono ad aumentare i rischi a livello globale, e anche il Vaticano compare per la prima volta nella Risk Map compilata da Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, in collaborazione con Roubini Global Economics e The Risk Advisory Group. Dall’ultima edizione della mappa, che analizza i rischi politici, il terrorismo e gli episodi di violenza legati ad avvenimenti politici, emerge che il 2016 ha visto un incremento del 14% degli attacchi terroristici nel mondo, passando dai 3.633 attentati nel 2015 ai 4.151. La crescita nei Paesi occidentali è del 174%, con 96 attacchi nel 2016 rispetto ai 35 del 2015.
Confusione, dilettantismo, indecisione politica. Indagini a carico dei servizi segreti, più segreti che capaci. È una generale sensazione di imbarazzo che fa a pugni con l’orgoglio mostrato solo qualche tempo fa, quando Londra scagliava aspre critiche sulla Casa Bianca, colpevole di non aver conservato con cura certe informazioni sull’attentato avvenuto a Manchester. Theresa May e il suo Governo hanno cercato e cercano in questo periodo di far credere di avere tutto sotto controllo ma il loro sforzo è ormai quasi patetico. Salman Abedi, il ragazzo di 22 anni che ha fatto strage nella Manchester Arena, era ben noto per i suoi legami con gli ambienti dell’islam radicale. Di più: era il rampollo di una famiglia il cui patriarca, Ramadan Abedi, era un mlitante del Gruppo combattente islamico di Libia, una formazione anti-Gheddafi legata ad Al Qaeda. Ramadan era tornato in Libia nel 2011 per combattere contro il Rais e si era portato dietro il figlio, che anche in seguito era andato avanti e indietro dalla Libia.
Tutto in segreto? Non troppo, visto che le autorità sapevano dei suoi viaggi, sapevano della sua radicalizzazione e peraltro ben conoscevano gli umori della comunità libica di Fallowfield, a Sud di Manchester, dove tra gli altri aveva trovato rifugio anche Abd al-Baset Azzouz, esperto di ordigni esplosivi e capo di un gruppo di almeno 300 miliziani affiliato ad Al Qaeda e attivo in Libia. La vicinanza con Azzouz potrebbe spiegare, tra l’altro, come mai un terrorista pivello come Salman andasse in giro con un ordigno con un duplice meccanismo d’innesco, studiato per rendere certa la deflagrazione dell’esplosivo. Peccato che nessuno abbia pensato di applicare agli Abedi il TEO (Temporary Exclusion Order), ovvero la legge che dal 2015 consente di impedire il rientro nel Regno Unito a coloro che sono sospettati di essere foreign fighter. Legge che in questi due anni è stata applicata una sola volta, come è stata costretta ad ammettere Amber Rudd, ministro dell’Interno, subito travolta dalle polemiche e ormai a rischio di dimissioni forzate. Tutto questo, però, rappresenta alla perfezione ciò che noi occidentali da quasi 17 anni (cioè da quando George Bush junior la proclamò, il 20 settembre 2001) chiamiamo “guerra al terrorismo”: un informe e ipocrita pasticcio che ci ha portati ad avere sempre più attentati (tra 2014 e 2015 un più 18% negli attacchi suicidi), sempre più morti (cresciuti di nove volte tra 2000 e 2016) e sempre meno sicurezza.
Dopo tutto questo tempo, seguitiamo a chiamare “terrorista” chiunque uccida civili. Sembra una cosa sensata ma non lo è: c’è un’enorme differenza, infatti, tra il mattocchio di Londra, che si lanciò con l’automobile sui passanti sul ponte di Westminster, e il kamikaze di Manchester, che portava sulle spalle un ordigno costruito da un professionista. La stessa differenza che passa tra uno che viene mandato a uccidere dai propri demoni interiori e uno che fa una strage su mandato e indicazione di menti ferine ma lucide.
Noi occidentali siamo ormai diventati incapaci di qualunque distinzione. Se avessimo conservato un minimo di lucidità, capiremmo che contro il “lupo solitario” dalla mente deragliata c’è poco che si possa fare, oltre a confidare nella professionalità delle forze di polizia e dei servizi sanitari. Mentre c’è molto che si può ancora fare contro le azioni dei professionisti del terrore, quelli capaci di trovare uno squilibrato, trasformarlo in un kamikaze e lanciarlo in mezzo alla folla con una bomba che nessuno può disinnescare.
È questo il terrorismo di cui dovremmo avere paura, è questo il terrorismo che si può combattere e neutralizzare, come proprio il “caso Manchester” e la storia di Salman Abedi dimostrano. E la prima cosa da fare sarebbe tagliare le sue linee di rifornimento. Viene però il sospetto che anche la confusione abbia un suo scopo. Che senso ha che il G7 concluda che serve un maggiore scambio di informazioni tra i Paesi membri per combattere gli attentatori se Donald Trump, appena prima di firmare quell’impegno, ha rovesciato sull’Arabia Saudita, che con il Qatar è uno dei grandi sponsor della violenza islamista, un fiume di armi che andranno ad alimentare, appunto, anche il terrorismo? Che senso ha che Theresa May si impegni a garantire la sicurezza del proprio Paese se l’industria degli armamenti del Regno Unito ha come primo cliente proprio quell’Arabia Saudita di cui abbiamo appena detto? Se ci sono più di 120 joint venture anglo-saudite che fatturano centinaia di miliardi di sterline l’anno? Che senso ha se la Germania è la “locomotiva d’Europa” anche nella vendita delle armi, che secondo il cosiddetto Rüstungsbericht (rapporto sugli armamenti) ha avuto un notevole incremento da record nell’export di armamenti? A che servono tutte le dichiarazioni se poi le azioni politiche concrete vanno in senso contrario?
Ecco, forse tutta quella confusione in merito a terroristi e terrorismo serve proprio a questo. A non far capire ai cittadini spaventati che se si è il migliore amico del migliore amico dei terroristi, la guerra al terrorismo te la puoi scordare. Anche Trump, come da 16 anni tutti i suoi predecessori, conoscerà la polvere dell’Afghanistan. La sabbia alzata a mulinelli dal vento penetra in bocca e nelle narici, offusca la vista e avvolge l’orizzonte in un’atmosfera sospesa, cinerea e giallastra, allo stesso tempo abbagliante e dalle lunghe ombre scolpite dal ritmo veloce del passaggio delle nubi contro le montagne. Questo luogo, soffocante di giorno, pungente di notte, è il Far West d’Oriente degli americani, la guerra più lunga mai condotta dagli Stati Uniti.
In un anno i talebani, a volte in alleanza con l’Isis, si sono impadroniti di 50 distretti da cui erano stati cacciati nel 2001 dopo l’11 settembre, hanno ucciso una media di 20 soldati afghani al giorno, 6mila dal 2016, più del doppio delle perdite Usa e Nato in 16 anni di conflitto; in attentati suicidi e con bombe artigianali (Ied) dall’inizio dell’anno sono stati ammazzati 1600 civili, la maggior parte nella capitale Kabul. Ma in fondo è qui che tutto è cominciato quando l’Armata Rossa nel dicembre 1979, dopo la rivoluzione khomeinista in Iran, invase il Paese e gli americani con i soldi sauditi e la logistica del Pakistan appoggiarono la guerra dei mujaheddin contro l’Urss: allora questi erano “i nostri eroi” poi sono diventati i “barbari” jiadisti talebani e dell’Isis che ispirano gli attentatori europei. Jalaluddin Haqqani, ritenuto oggi uno dei più sanguinari e potenti jihadisti, venne descritto allora come la “bontà impersonificata” da Charlie Wilson, il deputato americano che con l’Operazione Ciclone rifornì di missili Stinger i mujaheddin.
Nel 2001, sotto i bombardamenti Usa, Bin Laden ed i leader di Al Qaeda sfuggirono alla cattura grazie agli uomini del network Haqqani. I generali pakistani, che lo hanno sempre coccolato, ritengono Jalaluddin e il figlio Sirajuddin tra i loro migliori alleati per riprendere l’influenza sulla Linea Durand, la frontiera popolata dai pashtun: per Islamabad l’Afghanistan è parte vitale della sua “profondità strategica” perché sull’altro fronte c’è l’India.
Gli Usa riempirono di medaglie i generali pakistani che contribuirono al crollo del Muro nel’89, ma questi sono anche i maggiori alleati esterni di alcuni gruppi talebani pur essendo il Pakistan un Paese nel mirino degli attentati. Con i suoi servizi segreti (Isi), Islamabad spalleggia da sempre la guerriglia talebana e, nonostante le minacce Usa, continua a manovrare i gruppi islamici radicali facendo leva sulle rivalità locali, mai sopite, tra l’etnia maggioritaria dei pashtun e le altre componenti della società afghana. E i talebani sfruttano le logiche tribali per trasformare il conflitto su base etnica e religiosa (guerra agli sciiti e agli hazara) e minare la stessa compagine governativa di Kabul. In Afghanistan, teatro impegnativo anche per le forze armate italiane che hanno schierato a Herat 900 soldati, si misurano le contraddizioni e i limiti della strategia Usa. E così Trump, sulla spinta dei suoi generali, dovrà inviare altre truppe in appoggio agli 8.800 soldati Usa già sul terreno insieme ad altri 6.500 degli alleati e della Nato. Basteranno?
Il generale Roger Turner, tornando in queste settimane nell’Helmand, dove aveva già combattuto anni fa, ha avuto una cattiva sorpresa. I marine hanno dovuto alleggerire l’assedio al capoluogo Lashkar Gah mentre l’intera provincia è in mano ai talebani che hanno fatto fuori tutti i capi tribali con cui Turner aveva a suo tempo negoziato la difesa della regione, strategica per la guerriglia e il traffico dell’oppio. I talebani non hanno fatto molta fatica a conquistare questa area.
Gli americani mettono i soldi per l’esercito afghano rifornendolo di armi e carburante che poi i comandanti rivendono alla guerriglia. La polvere dell’Afghanistan da due secoli offusca le strategie delle superpotenze, così come le idee malsane di politici populisti che si preoccupano solo del loro interesse e non certo di quel populismo che nacque come un movimento politico e intellettuale della Russia della seconda metà del XIX secolo, caratterizzato da idee socialisteggianti e comunitarismo rurale che gli aderenti ritenevano legate alla tradizione delle campagne russe.