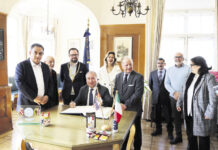Vita e opere
Spesso la fama di un genio si espande oltre la morte per effetto non solo della sue opere, ma anche di coloro che ad esse si rifanno e ne ripropongono la figura perché la grandezza del personaggio oltrepassa fino a noi ogni limite di tempo e di spazio. E può capitare che la fama dell’epigono brilli o scompaia in tutto o in parte permanga pari a quella del Maestro, ovvero si oblii nel mutare di genere e costumi. La storia funge da “lucido”, allora, per rinverdire sia colui che lasciò il seme, sia il contadino che ne raccolse il frutto e seppe offrire all’usufruitore un’immagine verosimile tale da rinnovare e ampliare la grandezza del genio originale. Operazione che l’interprete attuale riserva ad autori che non ebbero alcun ricordo duraturo se non per un breve periodo, salvo a resuscitare proprio in occasione delle ricorrenze legate all’originale. È questo il caso del drammaturgo Pietro Cossa (Roma, 1830 – Livorno, 1881), quasi perduto nella memoria letteraria nazionale, dopo una semi stroncatura di Benedetto Croce nel 1914, malgrado le sue opere teatrali avessero avuto un certo successo poiché apparse addirittura in Prussia, come vedremo fra poco. Forse non fu solo la critica letteraria a stroncarlo: la continuità del successo del pubblico gli mancò per buona parte della sua intensa produzione italiana.
Ma chi era Pietro Cossa?
Il primo indice a suo favore iniziale non secondario fu il notorio prevalere, per buona parte dell’800, del melodramma sulla scena teatrale italiana. Dopo Alfieri, Foscolo e soprattutto Manzoni, il teatro italiano perse di mordente, anche perché la nuova borghesia dell’Italia risorgimentale non aderì allo sviluppo parallelo europeo, che con Goethe e Schiller, ma poi con Wilde, Shaw, Ibsen, Čechov, prenderà le vele con la nascita del Verismo e del Decadentismo a cavallo dei due ultimi secoli. Del resto, solo con Marco Praga – per esempio, “La moglie ideale”, 1890 – e Giovanni Verga – “Dal tuo al mio” 1903 – si potrà parlare di un teatro verista italiano di stampo europeo, per altro ancora non di grande successo per il pubblico. E fu questo il limite anche per Pietro Cossa: romano, di formazione classica, fuggito dal Seminario e difensore della Repubblica Romana, emigrato in Cile e Perù, rimase fedele a tutti gli ideali risorgimentali. Anticlericale e Massone, cantante d’opera e professore di italiano e di storia a Jesi nelle scuole tecniche; alla presa di Roma nel 1870, ritornò a Roma e cominciò a scrivere romanzi storici.
Il suo credo estetico risaliva alle conclusioni del Manzoni e del Verdi, i quali cercarono nei rispettivi ambiti l’arte nella storia e il romanzo nel reale, dove già Schiller nel “Don Carlo” aveva contrapposto il marchese di Posa a Filippo II, cioè il principio già indicato dal Goethe nella “invenzione del vero”. Inoltre, nel decennio che precedette la sua morte, assunse la carica politica di Commissario Regio sui Comuni della Provincia di Roma; scrisse un numero ampio di drammi storici – circa 15! – dimostrando subito di aderire – come disse Francesco De Sanctis – alla “mania del secolo”, cioè la drammaturgia storica, che Tommaso Grossi, Massimo D’Azeglio, Francesco Domenico Guerrazzi, avevano perseguito proprio nel decennio di preparazione alla seconda guerra d’indipendenza e alle soglie dell’unità. E dunque, i primi due drammi storici: “Puškin” e “Beethoven”, due protagonisti del Romanticismo di prima versione, due drammi – il primo in versi e il secondo in prosa – ebbero una prima rappresentazione al vecchio teatro “Nicolini” di Roma nel 1869 e nel 1870, ideati fra un bicchiere di “Frascati” e in mezzo alle note rime in stornello popolare. Qui Pietro andò a immedesimarsi in quei giovani un po’ scapigliati che poco più di un mezzo secolo prima poetavano nelle taverne di Lipsia, come aveva vissuto il giovane Goethe, il “titano” che si era scagliato contro i “parrucconi” pietisti e come Cossa stesso ribadiva contro il grasso clero reazionario romano guidato dai Gesuiti, più che non dall’ormai statico Pio IX.
La sua natura di artista era naturalmente rivolta al “Vero” e dunque ai sentimenti del protagonista delle sue opere. Infatti la scelta di quelle due figure sulla scena era stata fatta apposta per resuscitare il loro mito nella nuova borghesia della nuova Italia, speculando sul loro carattere scontroso costantemente i lotta col mondo reazionario cattolico. Cossa, invero, a leggere il diario della sua breve vita, non volle in quelle occasioni odiare il mondo, ma espose in sostanza la difficoltà del vivere, specie quando le idee estetiche che voleva esprimere non venivano comprese dal pubblico contemporaneo. E questo fu il dramma di quest’autore, che oggi appunto merita di essere ricordato al pari del modello tedesco di un Hoffmann o di un von Kleist.
Il “Beethoven”: freddezza in Italia e fortuna in Germania.
La prima prova a carico del Cossa per la mancata fortuna di questo dramma, malgrado il primo successo di pubblico nelle poche repliche a Roma; fu la lunghezza della rappresentazione: ben 5 atti in 130 pagine, dove poi solo alcuni attori venivano sovraccaricati di centinaia di battute, mentre non pochi di essi venivano sollevati dall’onere di un’ampia recitazione. Nondimeno, se la formazione classica lo tenne legato all’unità di tempo e di luogo – come spiegò nella successiva commedia drammatica “Plauto e il suo secolo” del 1872, profeticamente anticipatrice delle attuali rappresentazioni cinematografiche che spesso caratterizzarono il panorama ironico di un Woody Allen; rimase però irrisolto in lui il grave problema dei confini dell’unità di azione, dove il miscelaggio delle vicende, ovvero la coesistenza dei caratteri opposti, andava scolpita, ma non ripetuta con un’acribia storica tendente alla pura ripetizione del fatto, senza alcuno spazio per la fantasia.
Facciamo un esempio testuale: nel dialogo tutto ideologico fra il compositore Hummel e il Genio musicale nostro protagonista, non solo si è dovuto aspettare l’atto secondo e la scena XIma, ma anche l’oscurità di alcune battute – e il rinnovo costante ad eventi esterni ignoti al pubblico – che rendevano certamente difficile l’approccio e l’ascolto di un pubblico privato dall’estetica del pathos e che invece il melodramma riservava nello scontro dei caratteri.Tuttavia, alcune pagine rivelavano – e ancora lo dimostrano – “l’offerta poetica esistenziale di Cossa”. Si veda al riguardo il tragico confronto critico fra lo stesso Hummel, caposcuola classico della musica strumentale, erede di Haydn e Händel, e Beethoven, quando respingeva qualche battuta dopo, quando Hummel lo disapprovava per l’ardore febbrile con cui lavorava, cosa che lo divorerà facilmente nella vita reale. Ludwig con impeto crede di essere il sole che vivifica il mondo. Hummel però gli opponeva in più battute di essere un pò disordinato e oscuro. La riposta del Genio è stupefacente: “l’oscurità è cosa propria di tutto ciò che è nuovo; diverrà luce col tempo… E poi io non potrò essere mai imitatore di altri italiani e tedeschi che hanno scritto chiaro e senza difficoltà”. Le conclusioni del Maestro di Bonn vale tutto il dramma: “Io non potrò essere mai imitatore. O bene o male che io faccia questo bene o questo male lo voglio fare da me, e per me. Gli illustri scrittori pur nominati – Mozart, Haydn – e Voi stesso hanno tenuto una strada diversa e io ho fatto bene divergere. Io tengo la mia strada, e credo anche di far ben perché il bello é multiforme…Hanno ripetuto mille volte che lo stile è l’uomo. Orbene, se mutassi stile muterei natura ed un simile miracolo non potrebbe farlo che Dio!” Hummel, sconsolato, ma convinto, chiudeva questo straordinario dialogo inventato, ma veramente credibile di Cossa. “Il convincimento di un artista come siete Voi è sempre rispettatile, e, se non arriveremo ad intenderci, certamente ci stimeremo”.
Il dialogo qui necessariamente riassunto dimostra ancora la capacità espositiva poetica e drammatica del Cossa: era un grande nel delineare i caratteri e i dialoghi personificando movimenti culturali nei due personaggi. Ma gli mancava l’abilità a equilibrare l’intero testo in modo unitario e una maggiore abilità artistica, mentre la sobrietà delle scene e degli atti non lo vedeva primeggiare. Comunque, nei successivi drammi – specialmente nel “Nerone”, va notato che divenne finalmente un misurato librettista d’opera per questa rappresentazione lirica di Boito soltanto nel 1924, tanti anni dopo la morte e che fu ritrovata dal Toscanini fra le carte del Maestro che ne aveva riportato la tragedia nel libretto. Benedetto Croce aveva peraltro riconosciuto a Cossa la padronanza degli avvenimenti storici, ma lo criticava perché non era mai riuscito a limare la figura dei ribelli rappresentatati. Nerone, Messalina, Cola di Rienzo, I Borgia, i Napolitani del 1799, tanto per citare gli altri drammi, erano fondati su una liricità della declamazione fin troppo retorica e da un complesso teatrale imponente e costoso, malgrado il tentativo di attrarre il pubblico romano per la materia trattata. Eppure, una lettura esistenzialista di altre battute oggi lo perdonerebbe. Infatti, all’atto I, scena V, Beethoven dirà: “Io soffrirò e morirò per l’arte, ma come si soffre e si muore per la donna che si ama; i figli del mio dolore vivranno immortali nel regno dell’armonia”. Interpretazioni che il D’Annunzio ebbe modo di lodare una delle poche repliche italiane del “Beethoven”, e che volle ripetere in un suo dramma del 1907, “Più che l’amore”, episodio I, dove “la febbre”, indicata dal Cossa, altro non era che un uragano e un grido: “dalla sua sinfonia sorgeva una forza che sempre afferrerà alla gola gli uomini”.
Ma la battuta che fece tremare Wagner che vide il Beethoven e che sicuramente lo influenzò – la si ritrova all’atto V, scena V: “Affascinato dalla potenza dell’estro, io Beethoven, pensai di creare come Iddio e, sconosciuto verso di lui, ebbi in disdegno di sapere che le mie armonie le rubavo alla selvaggia maestà della tempesta, all’usignolo che riempe il bosco dei suoi canti, ai mille inni che si levano dalla campagna sotto il sole di primavera: ma il gran superbo fu umiliato, il dito di Dio toccò le mie orecchie e l’intera creazione non manda più un suono fino a me”. Come non è possibile intravvedere in questa battuta, liricamente ispirata, una proiezione del pensiero wagneriano all’epoca imperante proprio nel ciclo “Der Ring des Nibelungen”, rappresentato per la prima volta a Bayreuth dal 13 al 17 agosto del 1876? Infatti, non fu un caso che alcuni drammi del Cossa, vennero tradotti presto in tedesco: il “Plauto”, e proprio il “Beethoven”, i primi tradotti dal Lungwitz tutti a Lipsia nel 1881 e il più famoso “Nerone”, tradotto dal Reissner nel 1874 e addirittura con successo rappresentato a Vienna in italiano nel 1881 sotto la regia di Ernesto Rossi, un grande amico livornese col quale aveva cenato qualche ora prima di morire.
Mentre la critica storico-materialista svalutava il Cossa, peraltro in buona compagnia con un altro scrittore politico a quello coevo, Felice Cavallotti (Croce nel 1905 e poi nel 1914 sulle colonne della “Critica”); contemporaneamente, in Germania il critico musicale e letterario Hans Volkmann lo elogiava. Partendo dalle positive valutazioni dei C.G. Bitter sulla “Gazzetta letteraria prussiana” (Preußische Jahrbücher del 1879) che aveva sottolineato il parere del Wagner sull’effetto poetico di Beethoven tanto da lui apprezzato; Hans Volkmann giunse a dire che ”Lo squarcio della vita di Beethoven, offerto nell’opera del Cossa, gli appariva ben costruito; credibile nei fatti rappresentati nella triste vicenda con Giulia Gucciardi, figura trasposta nella giovane Lucia Neefe e resa nella successiva e verosimile descrizione del Genio, incattivitosi per la sordità e per gli insuccessi relativi alle ultime opere”.
Il critico tedesco vide quelle tracce autobiografiche del Cossa proprio nel suo “Beethoven”. E da ciò dovremmo ripartire per una futura riedizione di quel dramma, accentuando la sottesa tematica dell’artista profeticamente isolato in una realtà culturale spesso immobile e dunque incline alla rassegnazione del quieto vivere, come avvenne per i drammi iniziali di Brecht (per esempio nel “Baal” del 1923) o di Pier Paolo Pasolini (“I turchi in Friuli” del 1944).