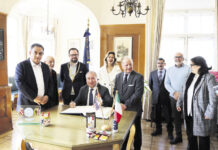Dafne
Prodotto da Vivo film con Rai Cinema, il film Dafne di Federico Bondi ha commosso il pubblico del Festival del cinema di Berlino raccogliendo molti applausi ed elogi. Al centro della pellicola è la storia vera di una donna di 35 anni afflitta da sindrome Down, ma capace di affrontare la vita come se l’handicap non ci fosse. Col suo carattere esuberante e trascinante, Dafne vive in famiglia coi genitori Luigi (Antonio Piovanelli) e Maria (Stefania Casini). Lavora alla Coop dove è amata e stimata da tutti i colleghi. Momento cruciale della vicenda è la perdita improvvisa della madre, che si era occupata dell’educazione della figlia dandole tutto l’amore possibile. Rimasta sola col padre, Dafne si vede costretta ad affrontare un’esperienza nuova, quella del lutto famigliare, e dopo una prima fase di sbandamento, grazie all’incredibile forza interiore di cui è dotata, riesce non solo ad elaborare il lutto, ma addirittura a farsi carico lei delle difficoltà dell’anziano padre, sprofondato nella più cupa depressione e tormentato dalla paura di lasciare sola la figlia alla sua morte. La svolta è data da un viaggio che padre e figlia intraprendono insieme camminando per i sentieri della montagna diretti verso il paese d’origine della madre scomparsa. I due riescono a ricostruire un rapporto tra di loro, imparano a conoscersi in modo nuovo. Ed è Dafne a ristabilire un certo equilibrio in famiglia imponendosi come la figura guida che si prende cura del padre esortandolo a bere meno vino e soprattutto a «non buttarsi giù».
Il film è costruito con una delicatezza rara e commovente, senza il minimo cedimento alla retorica (come sovente accade in pellicole che trattano di malattia e handicap). Bravissima Carolina Raspanti che interpreta se stessa come è nella vita reale (recita senza copione) dando credibilità a una donna capace di essere più forte della sua menomazione di partenza e di trattare gli altri alla pari. La Dafne di Bondi (ma probabilmente anche la Carolina della realtà) è una vera e propria forza della natura, con un carattere solido e inarrestabile, determinato e consapevole, dotata di una voglia di vivere inossidabile. Il difetto genetico, la mancanza di un cromosoma, fa di Dafne una creatura diversa, ma per molti aspetti migliore nella sua vivacità e incoscienza. Bellissima la scena in cui, poco dopo la morte della madre, a un infermiera che vorrebbe somministrarle degli ansiolitici per calmarla, risponde «Le prenda lei quelle pasticche, io voglio piangere!». Una battuta che da sola rivela tutta l’intensa umanità della protagonista, che si ribella a un sistema che vorrebbe riportare tutto alla giusta misura e a un ordine fittizio in cui anche la disperazione va controllata e disciplinata. Dafne in fin dei conti è dotata di buon senso più di tutti gli altri personaggi, e si attiene alle regole anche a costo di apparire pedante.
Dafne è il secondo lungometraggio del regista fiorentino Bondi, dopo Mar Nero del 2008. «La mia è una commedia drammatica che non cerca di trasformare la disabilità in intrattenimento» ha spiegato il regista il quale si è imbattuto per caso sui social in Carolina Raspanti ed è rimasto affascinato dalla sua personalità, dal suo carisma. «Un giorno – ha raccontato Bondi – ho visto a una fermata un padre e una figlia con la sindrome di Down che si tenevano per mano. Mi apparvero come degli eroi, due sopravvissuti. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Carolina, con cui è nata un’amicizia fondamentale non solo per il film, ma anche per la mia vita». Sarebbe semplicistico liquidare il film come la rappresentazione di una donna che riesce ad affermarsi nella vita nonostante il pesante handicap di partenza. Dafne è qualcosa di più di un film sulla sindrome di Down o sulla diversità. È un film sulla necessità di coltivare contatti umani e amicizie, perché tutti siamo Dafne, tutti abbiamo dentro di noi delle risorse da approfondire. È un film che costringe lo spettatore a interrogarsi su sé stesso, sui propri preconcetti e sulle proprie ansie.
Selfie
Il tema è per certi aspetti simile a quello trattato ne La paranza dei bambini, ma le modalità sono del tutto differenti. Quello girato da Agostino Ferrente, il cui titolo completo è Selfie (Ho sognato che Davide era vivo) è un documentario dedicato ai cosiddetti “camorra-millennials”, ragazzi che si raccontano con video-selfie, ma che potrebbero di colpo passare dal cellulare alla pistola. Protagonisti sono Alessandro (Alessandro Antonelli) e Pietro (Pietro Orlando), due adolescenti che si filmano con un iPhone per raccontare il loro complicato quartiere, il Rione Traiano, attraverso la loro vita quotidiana e, soprattutto, l’amicizia che li lega. Al centro della loro storia, come un ombra, la tragedia vera nel 2014 di Davide Bifolco, un loro amico ucciso da un carabiniere al termine di un inseguimento.

Alessandro e Pietro, non sono camorristi e non hanno la minima intenzione di diventarlo. Uno fa il barista, l’altro vorrebbe diventare parrucchiere. Quando hanno girato il film non avevano ancora compiuto i 18 anni. Il regista Ferrente era partito per girare un documentario sulla morte di Davide Bifolco, ma in corso d’opera il progetto è cambiato radicalmente. Mette in mano a Alessandro e Pietro uno smartphone, dà loro alcune indicazioni di massima, e chiede loro di raccontare se stessi, l’amicizia con Davide, il loro quartiere, i loro amici, i loro sogni. L’estetica del selfie diventa, da inconsapevole, consapevole, e la scelta di Ferrente si rivela azzeccata. I due giovanotti si rivelano attori provetti e per tutto il film affermano di non voler far la fine di tanti loro coetanei: non vogliono spacciare, non vogliono diventare “uomini d’onore”, non vogliono andare in giro armati, non vogliono far la fine dei camorristi che bazzicano le vie del loro quartiere. Vogliono lavorare. Vogliono avere una vita normale. A Napoli, in quella Napoli, sembra una cosa impossibile.
Ferrente, il regista di L’orchestra di Piazza Vittorio e di Le cose belle, è uno dei documentaristi più attenti e più aperti del nostro cinema, e il suo Selfie rappresenta una bellissima sorpresa oltre che una conferma.
Normal
Anche quello di Adele Tulli è un documentario che si propone un compito ambizioso: raccontare attraverso le immagini e senza nessun commento autoriale esterno gli stereotipi di genere che condizionano il modo di vivere in Italia, ovvero i luoghi comuni dell’essere uomo e donna oggi. In realtà la regista fa di più. Mette lentamente sotto i riflettori e ingigantisce la realtà mostrando quanto ci sia in essa di oggettiva follia. Tra le sequenza più eclatanti che documentano queste realtà normalmente anormali si possono citare le seguenti: donne agli ultimi mesi di gravidanza che gareggiano in difficili esercizi di ginnastica pre-parto; un bambino vestito di tutto punto dal padre da pilota per partecipare a una gara di mini-motociclismo; un fotografo alle prese con poetiche quanto imbarazzanti foto di una coppia di innamorati; torte a forma di fallo per un addio al celibato tutto al femminile; maschi alfa alle prese con guerre finte e videogiochi violenti e ancora maschi alfa a lezione per perfezionare la loro virilità dialettica. In questo caravanserraglio di situazioni, accompagnate solo da una ossessiva colonna sonora, emerge tutto il grottesco di ciò che ci circonda e che per assuefazione neppure più notiamo.
«Nei miei film precedenti ho lavorato su temi relativi al genere e alla sessualità e poi mi sono sempre occupata di attivismo, politica, movimenti femministi lotta delle donne» – ha dichiarato la regista Tulli – «ma ci tengo a dire che Normal non ha alcuna volontà di dare risposte sui generi, ma casomai creare degli interrogativi. L’idea era quella di creare accostamenti che riescano a provocare un senso di straniamento e di sorpresa davanti allo spettacolo della “normalissima” realtà di tutti i giorni».