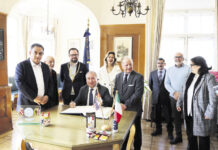L’opera di Verdi, che vide la sua prima il 9 marzo 1942 al Teatro alla Scala di Milano, sembra, per alcuni critici, un’opera costruita intorno ad un unico successo: il coro dei prigionieri che canta l’inno “Va pensiero”.
Von Mayenburg lo libera da confini temporali e traspone la storia in un mondo lontano e vicino al momento stesso.
La scenografia di Tanja Hofmann e le luci di Daniel Müller presentano dei neon che quasi accecano il pubblico. Un elemento disturbatore, vista la serie di neon in fila, che fanno perdere la concezione temporale e spaziale. Così lo spettatore è quasi obbligato a chiudere gli occhi e concentrarsi sulla musica. In effetti, il brano inizia piano, quasi in sottovoce e giunge come da lontano, quasi come se, all’inizio, prevalesse, l’indecisione a volersi affidare all’evasione del pensiero. Piano piano il volume aumenta e i singoli membri del coro attraversano le sbarre, fino ad essere tutti fuori dalle sbarre neon e continuare a cantare l’inno alla libertà.
È quasi come se il canto abbia l’onere di dare colore e verve ad un mondo triste ed un destino amaro e come se Verdi avesse inserito in questa composizione tutto il dolore e le avversità che visse sulla propria pelle durante il periodo della composizione, in qui perse ben 3 dei suoi familiari. Così, l’incarico originale di comporre un’opera gioiosa si trasformò in un grido di dolore che anela alla pace, al perdono.
Von Mayenburg decide di porre un forte accento sulle diatribe e sulle avversità, inserendo, diversi chiari riferimenti ad eventi occorsi durante il dodicennio nero di supremazia nazista, tra cui il falò dei libri (non considerati politicamente corretti) il 10 maggio 1933 e la notte in cui vennero distrutti tutti i negozi e le abitazioni degli ebrei il 9 novembre 1938, per non parlare della scena finale in cui tutti i protagonisti si alleano in file, teste rasate, per entrare nella caldaia e sfuggire così alle angherie.
I costumi di Sophie du Vinage accentuano all’estremo sfarzo e povertà, nobiltà e miseria: così Nabucco (Michael Bachtadze) e Abigail (Astrid Kesseler) hanno costumi e colori esagerati: piume dorate, colori brillanti e regali, trame scintillanti, mentre Zaccaria (Hiroshi Matsui) e Ismaele (Angelos Samartzis) sembrano dei normali operai dell’epoca industriale del primo novecento.
La scenografia, come sottolinea anche la drammaturga Frederike Krueger, è volutamente industriale, ma non ha intenzione di essere il perno dello spettacolo. La sua concezione è versatile, tanto da trasformarsi in prigione, night club, palazzo reale o fornace. Un luogo-non luogo in un tempo atemporale, in cui l’unico aspetto attuale rimangono i sentimenti forti e, a volte, non corrisposti, su cui, alla fine, prevale il perdono, chiesto in fin di vita, non solo per motivi di fede.
La fede, invece, rimane quasi oscurata in questa interpretazione. Il Gran Sacerdote (Markus Jaursch) sembra più assetato di fame e potere che da vera fede e convinzione nella propria fede: istiga Abigail alla rivolta, ma dichiara insano di mente Nabucco e strumentalizza Abigail per i suoi scopi di annullamento del popolo ebreo. Ma Abigail, sviluppa nel corso degli eventi, una propria coscienza prendendo atto della strumentalizzazione e non stando più al gioco, rifiutando quindi il potere e pentendosi sentitamente delle sue malefatte. Fenena (Judith Braun), passa in secondo piano, anche quando è la protagonista principale dell’azione. È come se al personaggio avessero tarpato le ali, per cui, non riesce mai a manifestare quella forza di volontà e di carattere che dovrebbero essere peculiari per una sovrana. Metafora per significare che non esistono sovrani di diritto?