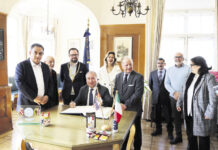Ad alcune settimane di distanza dalla Conferenza internazionale di Lima sui cambiamenti del clima, (Lima Climate Change Conference) il bilancio è tutt’altro che entusiasmante. Se si escludono le dichiarazioni e i documenti, estremamente adattati alle esigenze di questo o di quello, si vede che in realtà si continua come prima. Le due settimane di trattative minuziose, a cui si sono aggiunte due giornate straordinarie, hanno dimostrato che, come nelle precedenti occasioni, alle dichiarazioni non riescono a seguire i fatti.
Questo il problema di sempre. Anche la bassa attenzione che i media hanno avuto per la Conferenza, in fondo conferma che le aspettative erano altrettanto basse. Così come sono basse, già da ora, le aspettative per la prossima conferenza di Parigi del dicembre 2015, nella quale i documenti di Lima, compreso l’Appello finale per la protezione del clima, dovrebbero trasformarsi in un chiara Convenzione con regole e controlli per mantenere il surriscaldamento ambientale al di sotto dei 2 gradi. Speriamo di sbagliarci ma temiamo di avere ragione. A Parigi si continuerà con l’andazzo noto. Fermo restando che queste conferenze sono comunque utili, rimane da chiedersi perché, a riunione finita, tutti se ne vanno a casa e non succede più niente. La ragione principale sta forse nel meccanismo stesso delle conferenze.
Gli Stati si incontrano periodicamente quasi per un rituale mediatico; si incontrano non veramente per risolvere i problemi, bensì per dare all’opinione pubblica l’impressione di occuparsene. D’altra parte bisogna riconoscere che le opinioni pubbliche dei vari Paesi, soprattutto in Occidente, sono, sì, preoccupate del cambiamento del clima o del surriscaldamento dell’atmosfera, ma lo sono molto di più all’idea che l’energia pulita di domani possa essere più cara di quella sporca di oggi. Quindi avanti piano e più con dichiarazioni che con fatti. Ma a Lima si è reso evidente un altro problema, tutt’altro che piccolo, la cui risoluzione ci pare fondamentale se vogliamo sperare in un successo anche minimo alle prossime Conferenze, Parigi compresa. La questione parte da lontano: dal maggio 1992 e dal Convenzione allora firmata a New York, in sede Onu, sul cambiamento del clima. Parliamo della celebre UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).
Ora, la Convenzione del 1992 fu firmata dapprima a New York e poi ratificata nello stesso anno a Rio de Janeiro dai Paesi cosiddetti in via di sviluppo. Questi due tempi della ratifica non furono casuali. I Paesi in via di sviluppo reclamavano –allora- una responsabilità diversa, e quindi un approccio diverso, al problema. Si sentivano –ed erano di fatto- più vittime che colpevoli della incontrollata emissione nell’atmosfera di sostanze velenose. Essi tendevano a considerare il cambiamento del clima come un effetto posticipato del colonialismo europeo del Diciannovesimo secolo. Agli europei, americani, australiani la ricchezza e le risorse, -dicevanoe a loro la povertà e i problemi. Insomma, ad una responsabilità diversa doveva anche corrispondere un comportamento diverso. Questo il principio di allora. Toccava soprattutto agli occidentali risolvere il problema.
A ventitre anni dalla firma del UNFCCC le cose sono però cambiate, e di molto. Alcuni degli Stati che ratificarono a Rio la Convenzione, dalla parte dei Paesi poveri, in particolare India e Cina, ora sono tra i più grandi emettitori di sostanze tossiche nell’atmosfera. La Cina in particolare ha dimostrato nell’ultimo decennio di avere imparato molto bene la lezione del colonialismo europeo ed è tra i principali responsabili della rapina delle risorse in Africa. Peraltro, la rapida crescita industriale di entrambi gli Stati si basa proprio sullo sfruttamento estremo del suolo, dell’atmosfera e delle risorse, oltre che del lavoro. La Cina, in particolare, gioca poi con grande cinismo le diverse carte a seconda delle convenienze del momento.
A Lima si presenta dalla parte dei Paesi del Terzo mondo, mentre alla conferenza del G20 bussa come nazione fortemente industrializzata. Anche per ciò che riguarda, infine, l’Arabia Saudita, il discorso non è molto diverso. A Lima si è presentata come “Paese in via di sviluppo”, sulla scia del gruppo di Rio, ed ha assunto un ruolo di freno con India e Cina. Tuttavia vanta uno tra i redditi pro capite più alti del mondo. Nel passato nessuno ha osato protestare e a Lima è rimasto il principio della responsabilità differenziata. Si è introdotto –e qui bisogna dare atto alla volontà di chi ha votato il documento finale- il principio “Lost & Damage”: uno strumento attraverso il quale i Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili alle conseguenze dei cambiamenti climatici potranno ricevere delle compensazioni economiche per le calamità naturali.
Benissimo come misura passiva. Per il resto però si delega alla volontà dei singoli Paesi. Insomma, i nodi del passato vengono al pettine e formano un’ombra scura sulla prossima Conferenza di Parigi che dovrebbe essere proprio conclusiva del ciclo partito nel 1992. Che, per Parigi, i problemi siano risolti, lo speriamo, ma lo dubitiamo. Anche perché c’è da prendere atto di un fenomeno nuovo che a Lima non è stato considerato: la caduta del prezzo di gas e petrolio rende meno convenienti le energie alternative.
La ricerca in quella direzione potrebbe bloccarsi se il prezzo delle fonti tradizionali dovesse rimanere tanto basso. Un problema in più che potrebbe-speriamo di no!- vanificare gli sforzi fatti fino ad ora.