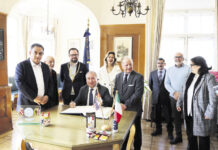Ho conosciuto nel 2002 a Bruxelles Gianni Allemanno allora Ministro delle politiche agricole e forestali in occasione della presentazione del progetto del “Marchio di qualità dei ristoranti italiani nel mondo”. Dopo le deludenti vicende di “Ciao Italia”, un’associazione che aveva goduto dell’avvallo di due presidenti italiani Pertini e Scalfaro, il ministro si era reso conto della necessità di un vero sigillo di autenticità del buon gusto italiano a tavola, un marchio in grado di offrire ai consumatori di altre nazionalità una garanzia di qualità e ai più bravi ristoratori italiani un riconoscimento della loro professionalità. Chi aveva avuto modo di seguire gli sviluppi della gastronomia italiana in Germania dopo la costruzione del muro di Berlino s’era reso conto di aver di fronte un progetto molto ambizioso. Sicuramente non facile da realizzare, a causa della notoriamente scarsa propensione degli italiani all’associazionismo e anche a causa dell’insoddisfacente diffuso livello di qualità che il Marchio, comunque, si proponeva di alzare.
Quel che il ministro Allemanno aveva però sottovaluto era che l’idea del “Marchio di qualità” già all’atto della sua nascita si trascinava dietro un carrozzone romano di enti parassitari pubblici o privati pronti a impossessarsi delle diverse strutture necessarie per far funzionare il progetto. Come un apparato per selezionare e scegliere i ristoranti più meritevoli, ai quali assegnare il “certificato di conformità” o un ente in grado di esercitare le procedure di controllo di un Marchio di qualità avrebbe dovuto avere una scadenza temporanea e quindi soggetto a periodici controlli.
Era previsto, inoltre, che il Marchio di qualità non sarebbe stato gratuito. Ancor oggi è difficile capire come mai il ministro Allemanno avesse potuto dare il suo benestare alla riscossione di quattromila euro (mille per il rinnovo) che i ristoratori italiani avrebbero dovuto pagare all’ARDI, Associazione Internazionale Ristoratori d’Italia, o a Buonitalia, società per la promozione dei prodotti alimentari italiani, due enti creati appositamente per gestire il Marchio. Un vero scandalo perché in questo modo il Governo italiano si faceva pagare il riconoscimento del lavoro di chi con la sua iniziativa contribuiva all’estero all’immagine della buona tavola italiana. Inoltre, era anche previsto che i clienti dei ristoranti contrassegnati dal Marchio di qualità avrebbero avuto la possibilità di acquistare prodotti tipici italiani attraverso appositi punti internet istallati all’interno dei ristoranti ai quali naturalmente sarebbe riconosciuta una percentuale sul fatturato. Insomma, un giro di affari con un “magnamagna” con i fiocchi, il tutto sotto il tetto dell’iniziativa governativa.
L’iniziativa del Marchio di qualità del ministro Allemanno fortunatamente non ha funzionato, come del resto prima erano fallite altre simili iniziative, a cominciare dalla prima, la più importante, che fu quella dell’associazione “Ciao Italia” fondata nel 1979 dal senatore Bartolo Cicciardini e da Alfio Bocciardi, presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. La storia del “Ciao Italia” durata almeno due decenni è lastricata di episodi d’incompetenze e di mediocrità con presidenti nazionali tutti intesi a mettersi in mostra e a trarre vantaggio per il loro proprio ristorante. Senza mai affrontare, per non dire risolvere, uno solo dei molti problemi della categoria dei nostri ristoratori all’estero che il ministro Allemanno, come molti altri politici prima di lui, amava definire “uno dei biglietti da visita più preziosi per l’Italia”. Purtroppo i momenti magici vissuti dalla ristorazione italiana negli ultimi decenni in Germania non ritorneranno mai più. Afflitti e scoraggiati dal peso dei gravi errori commessi da chi avrebbe dovuto accompagnarli e seguirli nel loro iniziale successo, oggi i ristoranti italiani – rimasti abbarbicati in formule vecchio stile incapaci di soddisfare le moderne esigenze di un mercato in continua evoluzione – faticano visibilmente a cogliere e a interpretare lo spirito alimentare del nostro tempo. A dispetto del fatto che sia proprio quello che caratterizza al meglio la sana dieta mediterranea nella quale, possiamo dirlo senza falsi orgogli, difficilmente qualcuno ha qualcosa da insegnarci.
Fotocopie del “made in Italy“
Mentre il ministro Allemanno cercava inutilmente con il suo ambizioso progetto di trasformare degli emigrati italiani improvvisatisi ristoratori in ambasciatori della cucina e dell’arte di vivere all’italiana, nello stesso tempo gli investitori finanziari tedeschi avevano capito che la richiesta gastronomica su quello che è il maggior mercato europeo era ancora in parte insoddisfatta. Soprattutto la domanda del pubblico giovanile che non aveva né il denaro, né la voglia di sottostare al rituale del primo, secondo e dessert tipico del ristorante italiano in Germania nel secolo scorso. Sono così esplose accanto alle pizzerie le “italo-restaurant-kette”, come Vapiano, l’Osteria, Tialini e XII Apostoli dove il cliente è assolutamente libero di ordinare un solo piatto. Tutte catene di ristoranti tuttora in fase di espansione con un’offerta di cucina all’italiana come quella dei ristoranti di Osteria e Tialini, senz’altro accettabile per un pubblico con un palato non eccessivamente esigente. Meno soddisfacente, invece, il livello di Vapiano, catena tedesca che è la più diffusa in Germania e anche in altri Paesi.
Tutto ancora da affrontare poi è il problema dei falsi alimentari italiani, un fenomeno che stando alla Coldiretti supera largamente i 50 miliardi di euro, un importo pari al doppio delle esportazioni originali dell’Italia. La “pirateria agroalimentare” si serve di immagini, concetti, parole, colori, denominazioni e ricette che richiamano alla mente i tipici prodotti dell’Italia senza aver nulla a che vedere con la sua realtà produttiva. Il fenomeno ovviamente è anche da imputare al vortice ormai irreversibile della globalizzazione che travolge mescoIa e standardizza tutti quei prodotti che non sono difesi da una certificazione di autenticità a tutta prova. ll classico esempio quando si parla di questo problema è quello del “Parmesan”, una sfacciata imitazione dei nostri Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Adesso è il turno della mozzarella di bufala, un alimento che in Germania ha una domanda molto sostenuta da parte dal consumatore e che conseguentemente ha sollecitato la fantasia dei produttori europei e in modo particolare di quelli tedeschi sempre molto solleciti quando si tratta approfittare delle lacune giuridiche delle normative di Bruxelles. Colpa naturalmente anche della faciloneria dei produttori e dei politici italiani che purtroppo si svegliano soltanto quando è troppo tardi. Adesso è anche il turno dei prodotti agroalimentari provenienti dalla Cina, basti pensare all’importazione dei pomodori pelati San Marzano. Molto preoccupanti sono anche le imitazioni dell’olio di oliva extravergine italiano, un problema che aumenterà di attualità quest’anno a causa del deludente produzione della scorsa stagione.
Di tutto questo e di molto altro ancora parleremo nei prossimi numeri del Corriere d’Italia. Quali siano stati i primi ristoranti italiani nel dopoguerra tedesco, chi i grandi protagonisti della ristorazione italiana nelle varie città della Germania, quanti siano i veri ristoranti italiani e quelli che invece fingono di esserlo per evidenti motivi di cassetta. E poi la riscoperta della cucina “povera” con i suoi piatti semplici e genuini, il successo della tazzina del caffè espresso e del tiramisu, del perché gli spaghetti vadano alla grande e il risotto invece meno. Naturalmente anche della pizza ormai un piatto mondiale nelle più impensate e incredibili versioni offerte in Germania. Naturalmente anche della “storia infinita” dei falsi della cucina italiana e delle targhe e delle patacche attestanti qualità e autenticità italiane che qualcuno continua a distribuire e ingenui ristoratori a comprare.