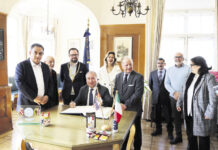Quasi settanta anni fa usciva nelle sale cinematografiche quello che potremo definire un poema migratorio, “Il cammino della speranza”, non tanto spesso riproposto nei nostri massa media, salvo qualche apparizione in presenza di eventi luttuosi sulle nostre coste. Che la stampa nazionale abbia svalutato la ricorrenza di questa a opera tragica sulla nostra emigrazione, lo testimonia una recensione sul sole 24/ore di domenica 3 maggio 2020, dove l’illustre critico Roberto Escobar nel citare un libro di Carlo Carotti sul significato del film, commette uno svarione non indifferente, individuando in Massimo Girotti l’attore che impersonava il protagonista.
Un minimo di controllo cartaceo – e per i più anziani un semplice ricordo – può correggere l’errore: l’attore è Raf Vallone, e come protagonista femminile Elena Varzi, divenuta poco dopo la moglie di Raf. Poco male, visto che quell’articolo, basato su un ottimo libro di cui raccomandiamo la lettura, parla di una vicenda verosimile capitata ad un gruppo di minatori siciliani di Capodarso, in provincia di Caltanissetta, costretti ad emigrare verso la Francia per sottrarsi alla fame più nera nei primi anni ‘50, visto che un crollo in miniera non solo aveva ucciso molti lavoratori, ma aveva lasciato sul lastrico decine di compagni, costretti a pagare 2000 lire a testa per raggiungere un posto di lavoro al di là delle Alpi a un ”caporale”, cioè un mediatore che pretendeva quella cifra cadauno per farli arrivare a destinazione. Una famiglia di quattro persone, tanti giovani senza futuro in quel maledetto paese e un “Leader“, quel Saro Cammarata che riuscirà a stento a passere il confine, insieme alla donna più matura del gruppo, Barbara Spadaro, vedova bianca del disastro. A cosa aspiravano? Un tozzo di pane, un bicchiere di vino, ballare la sera, un lavoro sicuro, anche se in miniera , dove fra qualche anno la tragedia di Marcinelle in Belgio (8 agosto 1956!) mieterà tante vittime italiane da far impallidire il numero degli scampati di Capodarso.
Il regista di quel film – Pietro Germi, già famoso nel 1949 con il western all’italiana “In nome della legge” – novello Omero, rilegge l’esodo biblico di Mosé dall’Egitto, modelli culturali per credenti e non credenti che dovrebbero rinfrescare la memoria a quegli intellettuali che non hanno capito ancora come le migrazioni costituiscono il lievito della storia. Dunque, “il cammino della speranza” verso un mondo migliore, senza cimiteri pieni di morti di fame e fuori da una terra di mafia, poco prima superbamente narrata, dove un giovane magistrato – lì veramente Massimo Girotti! – per una buona parte del film non aveva capito dove iniziava lo Stato e dove finiva la Mafia. E quindi il viaggio in un Italia centrosettentrionale, che li considerava “terroni”, rifiutati a Parma, abbandonati a Torino, truffati a Roma da quel mediatore che li lascerà a Termini senza soldi e senza bagagli; con alcuni malcapitati della carovana a girovagare per Roma, pronti a cadere nelle mani della malavita locale e il pensiero và ai tanti migranti magrebini divenuti spacciatori (e oggi prostitute e perfino portatori di covid sulle nostre coste…). Divisioni, liti, amori prospettive di lavoro, scontri e incontri, come nei viaggi classici; ma anche nelle peregrinazioni e nelle avventure picaresche sul modello del Basile nel ‘600. La vicenda corrispondeva all’esperienza personale di Germi al porto della sua città natale, Genova, dove l’emigrazione interna e esterna era di casa, tanto da impressionare all’inizio dell’800 il giovane Mazzini.
Fu una scelta decisiva che recò all’Italia più di una soddisfazione: proprio la prima edizione del festival di Berlino del 1951, vide conferire al regista genovese il primo Orso d’argento, proprio perché somigliava tantissimo ai tanti italiani, slavi e turchi che i decreti di Adenauer avevano richiamato in Germania per riattivare le fabbriche semidistrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale. E come nell’Esodo aleggiava la certezza di raggiungere la Terra Promessa, come pure lo spirito di Virgilio e di Omero aveva caratterizzato greci e troiani verso le antiche patrie e il mondo nuovo di Roma; così anche la speranza era nei cuori di quei poveri uomini e donne quando videro le Alpi. Pensiamo un attimo a Colombo che vide le coste dell’America; oppure a Goethe che plaudì le truppe francesi rivoluzionarie che avevano battuto a Valmy l’esercito della reazione. Oppure, a quei miserabili immigrati che dal fondo dell’Africa vedono le coste agrigentine dove le folle dei bagnanti folleggiano sulle spiagge… Insomma, ogni volta che noi vediamo un obiettivo raggiunto dopo anni di sforzi, dolori e pericoli; quando tocchiamo l’età dell’oro, un mondo sognato e mai vissuto, questi siamo e saremo anche Noi. E che mai poteva accadere? Potevano riuscire le guardie francesi nel loro disumano tentativo di fermare Saro e compagni sulle linee del confine? Se rivedrete il film, fissatevi gli sguardi di quelle ultime inquadrature. Volgono centinaia di bruttissimi film attuali e rendono giustizia a Germi, qui collaborato da Fellini come sceneggiatore e Monicelli come aiuto regista. Germi non solo eguaglia, se non supera, altri grandi italiani registi a livello mondiale: per esempio, De Sica e De Santis, il cui “Riso amaro” visse anche di luce riflessa negli stessi anni, nulla togliendo allo spirito eroico delle mondine lì eccezionalmente rappresentato.
L’ottimistico finale di Germi, intriso di speranza, è un’opera che va al di là del neorealismo cinematografico, in cui scolasticamente lo si inscrive. La perfezione del finale – all’epoca criticato anche da sinistra, se non di più – lo rende un’opera classica, un poema che la materia migratoria non fa che esaltare a renderlo un gioiello indimenticabile, degno di stare accanto agli immortali film di Chaplin. Nondimeno, di questo film – che non dimostra affatto i 70 anni di età – merita ricordare la colonna sonora, la cui popolarità inimitabile ne prova la classicità, non inferiore alle sonorità del compianto Morricone. Ci riferiamo alla ballata popolare siciliana “vitti ‘na crozza” composta su un testo di autore sconosciuto, musicata dall’agrigentino Franco Li Causi, che venne cantata per primo da un quasi sconosciuto cantautore, Peppino Ferrara, che per altro doppiò con la sua voce l’attore Renato Terra nella parte di Momnino, uno del gruppo in marcia verso la Francia. La ballata narrava nostalgicamente la vita trascorsa di un ateo che in punto di morte piange per non avere un funerale come gli altri, rappresentando così una metafora della morte. In questo canto epico quanto dolente – forse ricavato da un coro di minatori di Favara (dove la parola “cannuni” non è il cannone arma di guerra, bensì l’ingresso della miniera), sta un teschio – na crozza supra nu cannuni” – che alla domanda di chi è ancora illuso di continuare a vivere, così dice:” Morii senza tocco di campana\i miei anni se ne sono andati e non so più dove\se non li sconto qua i miei peccati\li sconterò nell’altro mondo\oh scellerato! Preparatemi il letto, ché sono tutto mangiato dai vermi\ora che sono arrivato agli ottanta anni\ chiamo la vita e la morte mi risponde\ “.
Molteplici sono i significati delle parole utilizzate: se il significato di canto di dolore e morte dei minatori entusiasmò Germi e Fellini, quasi dando ragione alla tragicità della storia e allo spirito sarcastico del giovanissimo Monicelli; il costante accompagnamento musicale confliggeva con l’ottimistica soluzione finale e dava corda ai critici marxisti che, come Aristarco dalla colonne dell’”Unità” demolirono il valore del film. Anzi, non mancò chi di parte borbonica fece risalire la ballata a metà ‘800, focalizzando una caratteristica delle usanze locali in materia di giustiziati, spesso briganti. Infatti nella canzone si cita un teschio di un giustiziato che sta appeso in bella mostra ad una torre di guardia, il c.d. “Cannuni”. Cosa che dovette accadere anche durante il massacro di Bronte operato dai garibaldini di Bixio, onde quei nostalgici ne rilessero il senso perché era loro obiettivo infangare le glorie della spedizione dei Mille. E lo stesso avvenne per i Fasci siciliani di un trentennio dopo, quando gli altri pezzi della canzone arieggiavano i moti indipendisti irlandesi analoghi agli eventi siciliani di fine ‘800. Sia come sia, queste influenze politiche alquanto macabre non impedirono a questa ballata di diventare l’inno epico simboleggiante l’emigrante italiano, tanto che fin dal 1951 il motivo non cessò di essere preso e ripreso con varianti fra le più varie in relazione ai diversi flussi emigratori di lavoratori italiani verso l’estero. Da Murolo, a Profazio, da Modugno a Gabriella Ferri, dal tenore Michelangelo Verso fino a Carmen Consoli. Gli italiani all’estero ne hanno fatto la loro bandiera e Germi va altresì omaggiato, al di là del successo commerciale degli anni ‘60 che lo vide il massimo fondatore della commedia ironica all’italiana, con il suo indimenticabile “Divorzio all’italiana”. Un film che fotogramma per fotogramma andrebbe rivalutato.