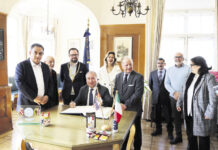Quando si progetta un giornale per una comunità emigrata –ma lo stesso vale anche per qualsiasi altro mediaci si deve porre la questione: perché? Perché si produce ancora un giornale di emigrazione? Questo è un punto fondamentale, altrimenti ci smarriamo, non sappiamo che fare e cosa produrre. Dunque: perché la fatica quotidiana di pubblicare qualcosa per una comunità emigrata nella sua lingua di origine? La domanda è complessa e richiede una risposta variegata. La prima che mi viene in mente è: visibilità.
Le comunità emigrate non ce l’hanno. Per i media locali non esistono. In Germania, quando si parla di stranieri si pensa ai turchi; ma gli italiani, che hanno gli stessi problemi di inserimento non vengono considerati stranieri dall’opinione comune. Si nascondono. Non vogliono essere visibili. Eppure la visibilità è importante, perché documenta una storia, una passione, una volontà di partecipare. Senza visibilità non saprebbe nessuno quanto l’emigrazione italiana sia stata fondamentale nel miracolo economico tedesco del secondo dopoguerra.
Nessuno conoscerebbe le storie di Salvatore alla Bosch, di Carmelo alla Mercedes, di Giovanni alla Siemens. Senza la storia, Salvatore, Carmelo e Giovanni rimarrebbero senza patria, persi nel nulla. Nessuno saprebbe che, senza di loro e senza il loro lavoro, la Germania non sarebbe quella che è. I media danno una visibilità a questa comunità e, con ciò, li fanno rientrare nella storia. In più ribadiscono che la storia non è più, com’era nei secoli passati, una sola storia nazionale. Esistono una storia ed una geografia della trasmigrazioni; cosa di cui i libri di storia nelle scuole italiane, come in quelle degli altri paesi europei, non hanno ancora preso atto. Ma alla domanda perché? Ci sono altre risposte. Una seconda risposta è: identità. Carmelo, Salvatore e Giovanni vivono in Germania, a Stoccarda, a Francoforte, ad Amburgo. Vengono da differenti regioni: dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Veneto.
Non sanno nulla l’uno dell’altro. Uno è del sud, l’altro del nord. Non si conoscono e, visto che si vergognano di essere emigrati, non si vogliono neppure conoscere, perché negli occhi dell’altro rivedrebbero la loro sconfitta. Per quello si nascondono. Per quello sono invisibili. Per quello non vogliono essere riconosciuti. Per quello, quando ritornano al paese, lo fanno con la mercedes nuova fiammante, anche se vivono in un buco da qualche parte; una soffitta, una baracca. L’emigrazione è stata la loro sconfitta ed ora vogliono il loro riscatto. Un giornale li aiuta a capire che non sono soli, che ce ne sono altri di italiani come loro. Li aiuta ad essere meno sconfitti, perché la comunità è grande, ha potenzialità, potrebbe fare molto (anche se non lo fa).
Il giornale che leggono ogni mese da loro una identità. Perché parla di loro. Certo, potrebbero leggere il Corriere della Sera, e spesso lo fanno, ma non parla di loro. Potrebbero leggere la Süddeutsche Zeitung, e spesso lo fanno, ma non parla di loro. Come i libri di storia, anche grandi i giornali nazionali sono rimasti ad un concetto di storia che risale a qualche secolo or sono, quando i popoli conicidevano con le nazioni. E era un concetto sbagliato anche allora! Come conseguenza, viene alla mente subito una terza risposta, che si chiama comunità. O, se vogliano evitare confusioni linguistiche, collettività.
Il senso di essere un collettivo può darlo soltanto un media di comunità. È un contarsi, è un sapere che gli altri ci sono, che sono come noi, con gli stessi problemi e con gli stessi propositi. Se si riuscisse –e non ci siamo ancora riusciti- a dare coscienza a questa massa di persone che sono una collettività, molti dei nostri problemi sarebbero risolti. Prolemi legati alla mancanza di integrazione, di partecipazione, di dibattito. Il singolo si sente isolato, non ha il coraggio di esprimersi. La collettività lo appoggia, lo rende visibile, lo spinge avanti. Naturalmente per riuscire in questo compito estremamente difficile, è necessaria una qualche forma di formazione. Usiamo questa parola un po’ antipatica, che sa di scuola, ma rende tuttavia bene il concetto.
Pensiamo un attimo alla politica. Noi abbiamo di fronte un popolo che non partecipa se non in minima parte alla definizione delle regole collettive. Un popolo molto abituato al voto di scambio. Un popolo in buona parte refrattario ad ogni forma di partecipazione, individuale o collettiva. Un popolo che si accoda e si inchina con referenza al primo padrino che passa. Un popolo di furbi, insomma, che alla fine risulta un popolo perdente in tutti i piani sociali, economici, politici. Qualcuno dovrà dire a questo popolo che si trova in un cul de sac. Qualcuno dovrà dire loro che il voto di scambio è sporco ed illegale.
Qualcuno dovrà dire loro che a forza di essere un popolo di furbi, sono anche il popolo degli ultimi. Questa “educazione” -mettiamo la parola tra virgolette- la si dovrebbe fare a diversi livelli. La vorremmo vedere di più nelle scuole, nelle istituzioni, nelle Missioni. Spesso non la si fa. Allora restiamo noi dell’informazione a dire, a parlare, a fare denunce. E poi, ultimo punto ma non ultimo, la battaglia sui diritti. Quella la facciamo insieme a pochi altri e con pochi ringraziamenti.
Ma chi interviene altrimenti sulla chiusura dei consolati? Sulla mancanza di giustizia nei tagli ai bilanci? Chi fa la battaglia per il mantenimento del voto? Chi per la doppia cittadinanza? Chi per la partecipazione agli organismi politici locali? Chi fa le grandi battaglie, insomma, se non noi dell’informazione? Ecco perché pubblichiamo un giornale. Ora, non tutti sono contenti di come il giornale è fatto, e ce ne dispiace. Cercheremo di lavorare meglio, ma siamo anche sicuri che accontentare tutti è non fare contento nessuno.