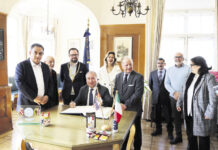Il silenzioso ritorno della „sindrome di alienazione parentale“ (Entfremdungssyndrom)
Enrico ha otto anni. Suo papà è stato allontanato dal nucleo familiare grazie ad un provvedimento di protezione civile da parte del tribunale di famiglia (Familiengericht), dopo che il giudice aveva accertato una serie di maltrattamenti a discapito della ex-compagna Luisa, mamma di Enrico. Qualche mese dopo, il padre di Enrico riesce – con l’appoggio dello Jugendamt – ad ottenere una regolata frequentazione del bambino (Umgang). I due s’incontrano un giorno a settimana, ad accompagnarli è un operatore sociale. All’inizio sembra tutto normale, ma con il passare del tempo Enrico non si sente più a suo agio, dice alla madre che suo papà parla sempre di lei, che è „cattiva“, una „vipera“, che ha „distrutto una famiglia“. Insomma, Enrico non vuole vedere più il padre e ogni volta, prima degli incontri, scoppia a piangere. La madre, disperata, si rivolge al tribunale: chiede l’affidamento e l’interruzione della frequentazione. Ma il tribunale sostiene il contrario: il problema è lei, la madre, colpevole di aver fatto allontanare emozionalmente il figlio dal padre (Entfremdung).
Questa di Enrico e Luisa è una storia fittizia, ma che riassume in breve lo sviluppo di una vicenda tipica che riguarda la cosiddetta „sindrome di alienazione parentale“ (il termine corretto: „sindrome di alienazione genitoriale“), una prassi applicativa che vittimizza ulteriormente la donna che denuncia gli abusi subiti e contribuisce a rendere difficoltosa la sua fuoriuscita dalla spirale della violenza.
Dal rapporto di GREVIO, un organo indipendente del Consiglio d’Europa, che monitorizza l’applicazione della Convenzione di Istanbul (per la tutela delle donne contro la violenza di genere), anche sull’Italia, è emerso, infatti, che spesso le madri non denunciano la violenza subita perché spaventate dalla prospettiva di perdere i loro figli. Sono molti i casi giudiziari in cui si è ritenuto che una madre, che ha subito per anni senza denunciare immediatamente il compagno violento, non sia adeguata a prendersi cura dei minori; altre volte si perviene invece a dubitare della donna o si relativizza la violenza da lei denunciata e, in nome del principio della bi-genitorialità, si affidano i figli anche al padre violento.
Che gli uomini – e i loro avvocati – abbiano individuato questa strada per invertire, nelle aule dei tribunali in cui si decide sull’affidamento dei minori, il ruolo di accusato e accusatore stupisce, ma solo fino ad un certo punto. Quello che davvero colpisce è che alcuni giudici, e soprattutto molti consulenti tecnici del tribunale, prendano sul serio questa pseudo-teoria. La PAS, o anche „sindrome di alienazione parentale“, è stata ipotizzata da uno psichiatra forense americano negli anni ’80 e si fonda sull’idea che, se un figlio rifiuta di vedere il padre, la motivazione risiede solo ed esclusivamente nella manipolazione operata dalla madre. E la cura? Ovviamente l’allontanamento coatto dalla fonte della tossicità, la madre, il suo contesto sociale, la sua casa.
Mentre in Italia la Cassazione nel marzo del 2022 si è espressa nettamente in riguardo, dichiarando la PAS non fondata e dunque non applicabile, in Germania finora la Corte federale non ha avuto modo di esprimersi in riguardo: vi sono, invece, alcune sentenze delle Corti d‘Appello, come quella di Dresda del 25 aprile del 2002 e quella di Brandeburgo del 26 febbraio 2015, che – nonostante le critiche mosse dalla comunità scientifica – ammettono la possibilità di un „Entfremdungssyndrom“, ovvero di una sindrome di alienazione. Su quali basi? Non si sa. Difatti la PAS non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla comunità scientifica internazionale ed è oggetto di aspre critiche e di dibattito politico e giuridico fin dalla sua prima elaborazione
Anche in Italia, nonostante il verdetto della Cassazione, la PAS sta trovando nuove strategie di riconoscimento. Si è passati, infatti, ad un preteso comportamento alienante del genitore presso cui vivono i minori, non più una patologia quindi, ma una condotta. Si perviene all’affermazione di questa situazione attraverso il concetto di “bi-genitorialità”, analizzata indipendentemente dalla presenza della violenza domestica e delle cause che hanno dato origine alla separazione dei genitori. Le consulenze tecniche d’ufficio non considerano le violenze esercitate da un genitore sull’altro, così come non tengono conto della violenza assistita dai minori. Si opera secondo il principio che il minore debba comunque mantenere relazioni significative con entrambi i genitori.
Ma siamo sicuri che questa sia la strada giusta? È ammissibile che una frequentazione di un genitore violento sia sempre nell’interesse del bambino?
Mi pare proprio di no. A questo punto bisogna, dunque, rivalutare alcuni dogmi: se vogliamo realmente prendere sul serio la violenza di genere, se la Convenzione di Istanbul è una priorità per la nostra società, allora dobbiamo distanziarci da alcuni principi che possono sicuramente andar bene quando si tratta di genitori „normali“ e non violenti. Ma in presenza di atteggiamenti violenti, maltrattamenti e violenza fisica o psichica nei confronti di un genitore, l’interesse del bambino dev’essere, innanzitutto, quello di non dover assistere a nessuna di queste forme di violenza, anche in forma di tentativi da parte del genitore violento di manipolare la psiche del bambino; e, infine, di frequentare il genitore violento solo se costui, magari dopo una lunga terapia, è riuscito a curarsi.