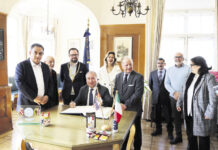A lezione da Giovanni Falcone
L’ultimo capitolo di “Cose di Cosa nostra” Giovanni Falcone lo dedica al tema dei Poteri, quelli con la “P” maiuscola. In uno Stato che si ritiene – nella sua stessa Costituzione – democratico, il Potere è del popolo, dunque potere popolare. Cosa vuol dire? Si tratta di delineare quell’esigenza di autogoverno che caratterizza, appunto, il pensiero democratico. Per passare, tuttavia, dall’ideale alla prassi politica, per rendere cioè operativa questa esigenza, occorre pensare ad istituzioni delle quali possa dirsi che sono espressioni di autogoverno. Per configurare istituzioni di questo tipo, occorre porsi il quesito circa chi decide e come deve decidere.
Falcone a tal proposito punta il dito proprio sul concetto del Potere, quello che dovrebbe, in realtà, contrastare le mafie. “All’estero si chiedono sbalorditi come mai lo Stato italiano non è ancora riuscito a debellare la mafia”. Poi aggiunge: “I motivi sono numerosi”, analizzando la struttura subculturale della mafia, per poi passare al dunque: “Non bisogna inoltre dimenticare la relativa giovinezza dello Stato italiano a differenza, per esempio, di uno Stato francese plurisecolare e ipercentralizzato”. Insomma, uno “Stato debole, di recente formazione, decentrato, diviso ancora oggi in tanti centri di potere, non è in grado di organizzare la lotta alle mafie”, sentenzia Falcone.
In altre parole: la mafia, essendo contro la volontà generale, è antidemocratica. Lo è in primo luogo in quanto ogni azione mafiosa è volta a destabilizzare le istituzioni, quelle stesse istituzioni che in una democrazia dovrebbero essere la rappresentazione auto-governativa dello Stato. Un esempio concreto: la corruzione. Cos’è la corruzione se non la perenne e silenziosa destabilizzazione delle istituzioni?
E, in secondo luogo, la mafia è antidemocratica in quanto è una forma di potere esterno ai meccanismi democratici. Vale a dire: il mafioso detta legge, una legge che non è volontà generale ma volontà del mafioso, di un individuo non legittimato dalla sovranità del popolo, un individuo che insegue solo la sua volontà, fatta di profitto e cieca sete di potere.
Ecco perché la Storia d’Italia è stata fin dall’inizio accompagnata da vicende che hanno un richiamo mafioso. Il connubio mafia-Stato, infatti, non è una scoperta recente, ma un dato di fatto che ha sempre caratterizzato il ruolo del Potere stesso in Italia. Emblematica, a questo proposito, è la vicenda di un certo Emanuele Notarbartolo, nominato presidente, alla fine dell’Ottocento, del Banco di Sicilia, all’epoca uno dei più grandi istituti bancari del Paese, dotato perfino della facoltà di battere moneta. Notarbartolo era abituato a prestare soldi alle più ricche famiglie del Palermitano, senza mai chiederne la restituzione. Una volta divenuto presidente, Notarbartolo decise, per il bene delle casse della Banca di Sicilia, di cambiare registro iniziando a chiedere che i soldi venissero restituiti. Del resto si trattava di prestiti e non di donazioni. Oggi la potremmo definire un’oculata azione di risanamento finanziario, che però non fu portata a termine perché il 1 febbraio del 1893 Notarbartolo venne trovato ucciso con ventisette coltellate sul treno Termini Imerese-Trabia. Solo dopo molti anni l’autorità giudiziaria individuò come mandante occulto Raffaele Palizzolo, nobile siciliano e senatore. Un delitto, secondo l’accusa, che doveva proteggere gli interessi della borghesia siciliana protetta dalla mafia. Con il passare degli anni e dei processi giustizia non fu fatta: la Corte di Appello di Firenze, nonostante le prove schiaccianti, assolse Palizzolo, che divenne una vera e propria celebrità.
Questa vicenda, però, non racconta soltanto del legame tra mafia e Stato. Questa vicenda dimostra come la mafia, fin dall’inizio, si è sporcata le mani solo quando il suo potere era in bilico, proprio perché lo Stato aveva iniziato ad agire (o, meglio detto, reagire).
Lo racconta anche Falcone ricordando un’altra celebre vittima della mafia, il generale Dalla Chiesa. “Nel febbraio 1982 un avvocato venne nel mio ufficio per chiedermi, a nome del generale, l’ordinanza di rinvio a giudizio del procedimento contro Spatola e altri atti. Capii allora che pensava di venire a Palermo”. Poi aggiunge: “Giunse a Palermo il 30 aprile; passarono maggio, giugno e luglio, arrivò l’agosto con le vacanze; il 3 settembre venne assassinato. Non ha avuto il tempo di sopperire alle carenze della macchina investigativa”. E quale “colpa” aveva Dalla Chiesa? Quella di fare “richiesta di maggiori mezzi per combattere seriamente la mafia”, conclude Falcone. Dalla Chiesa, nominato prefetto di Palermo, voleva ottenere risultati significativi: a Cosa nostra sicuramente non era sfuggito con quale decisione e impegno personale il generale aveva combattuto il terrorismo.
Un ultimo esempio, forse quello più evidente (oltre alle uccisioni di Falcone e Borsellino): l’assassinio di Pio La Torre (e Rosario di Salvo) il 30 aprile 1982. La Torre, infatti, era in procinto di far passare una proposta di legge, che poi venne promulgata nel settembre 1982, la cosiddetta “Rognoni-La Torre”, che introdusse nel codice penale l’art. 416-bis, il quale prevedeva per la prima volta nell’ordinamento italiano il reato di “associazione di tipo mafioso” e la confisca dei patrimoni di provenienza illecita. Questa legge ha contribuito a destabilizzare il potere mafioso proprio perché lo Stato non solo aveva finalmente gli strumenti per contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso, ma in quanto il Potere dello Stato criminalizzando la mafia ne riconosce l’esistenza stessa del fenomeno e la sua pericolosità per la società civile. Possiamo trarre, dunque, qualche conclusione: la mafia, come sosteneva Falcone, è antidemocratica e per questo indegna di una società civile in quanto non rispetta quella volontà generale che dovrebbe essere l’unica forma di volontà all’interno di uno Stato democratico.