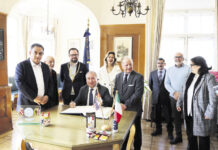Alessandro Wandael è un fotografo. La sua è una professione in cui il successo dovrebbe dipendere solo dal talento. Ma non nella sua nativa Italia, dove il sistema delle assunzioni funziona per conoscenze. “Fotografi, che hanno familiari o altri gradi di parentela con gli editori, lavorano regolarmente – ci racconta -, mentre quelli che non ce l’hanno, non lavorano”.
Il trentasettenne Mr Wandael, un originale architetto, se ne è andato all’estero ancor prima di essere laureato: prima a Berlino, adesso a New York. Le cifre in questo settore sono spesso datate o troppo vaghe, ma sicuramente Mr Wandael è lungi dall’essere solo. Secondo quanto dicono quelle dell’Ocse risalenti al 2005, è infatti tra quei 300 mila meglio istruiti italiani che hanno scelto di lasciare un Paese diventato ricco senza aver smantellato una struttura sociale in cui l’accesso al lavoro dipende dalle relazioni familiari, dalle affiliazioni politiche e dalle “raccomandazioni” (il termine è stato lasciato in italiano).
Nell’ultimo mese, in diverse città d’Italia si sono succedute svariate violente proteste di studenti contro la riforma del sistema universitario della ministra Gelmini. Alcuni cronisti hanno inquadrato queste ultime come un sintomo di frustrazione dei giovani, ormai stufi di quel tipico modo di fare le cose all’italiana. Quanto è serio il problema? “Non esiste”, disse nel 2002 un giovane Ministro, sostenendo che i laureati fuggiti dal Paese fossero solo 150-300 all’anno. Secondo un suo collega dell’attuale governo, invece, l’unica reale causa di preoccupazione sarebbe la partenza di giovani scienziati.
Peccato che, secondo uno studio del 2004, la percentuale di quelli con la laurea sul totale di emigrati si sia quadruplicata tra il ’90 e il ’98. Un altro studio ci racconta invece che, nel 1999, quelli laureati che hanno cancellato la loro residenza italiana sono stati ben 4000, mentre l’americana National Science Foundation fa sapere che il 17% degli italiani che si sono laureati negli Stati Uniti, la destinazione più popolare, sono impiegati oggi nella ricerca e sviluppo. La più grande fetta lavora invece come manager. Quello che però distingue l’Italia dai suoi corrispettivi non è tanto il numero assoluto di laureati che lasciano il Paese (nel 2005 quelli che se ne andavano da Gran Bretagna, Francia e Germania erano di più che in Italia), ma il cosiddetto “brain drain”, cioè “fuga dei cervelli”, un fenomeno tipico delle economie in via di sviluppo.
Questo succede quando, come in Italia, il numero di istruiti che lascia il Paese supera il numero di quelli stranieri che entra. Al contrario, molti Paesi, ritenuti per sviluppo pari all’Italia, sono coinvolti dallo “scambio di cervelli”: così, mentre gli scienziati inglesi del computer scompaiono verso la Silicon Valley, i medici ricercatori spagnoli trovano lavoro in Inghilterra. Lo scorso anno, il governo di Silvio Berlusconi ha fatto il suo secondo tentativo in nove anni di richiamare gli accademici esiliati, questa volta con agevolazioni fiscali.
Ma questo provvedimento ancora una volta non centra il problema. Ne è convinta Sonia Morano- Foadi, una docente di legge all’università de Oxford Brookes che ha intervistato più di 50 scienziati emigrati italiani nel 2006. I suoi soggetti, infatti, hanno identificato due principali ragioni alla base della loro decisione di lasciare il Paese natale: una è lo scarso investimento in ricerca e sviluppo (il più basso dell’Unione europea a 15 nel 2004); e l’altra è “il più radicato ed importante problema dell’università in Italia”, vale a dire il “suo non trasparente sistema di reclutamento”. Di fronte a tutto questo, gli incentivi sono di certo insufficienti.